L’ultimo grande romanzo di Fedor Dostoevskij, il più ambizioso, il più ricco e articolato, I fratelli Karamazov, richiede un lettore molto esperto e preparato, che sia il perfetto “lettore modello” immaginato da Umberto Eco. La complessità è tale che anche un’autrice avvertita come Elena Ferrante in L’amica geniale commette l’errore di considerare la parte relativa al processo la più avvincente perché aperta a entrambe le ipotesi di colpevolezza e innocenza, secondo se parli la pubblica accusa o la difesa dell’imputato, mentre in realtà il lettore sa già che l’assassino è stato Smerdjakov il cuoco e arriva al processo solo per aspettare il verdetto dei giurati. Che peraltro lo stesso Dostoesvkij anticipa quando all’inizio del dibattimento parla di «esito doloroso e fatale».
A ben vedere Dostoevskij non ha voluto un giallo, dove il responsabile si scopra canonicamente alla fine, ma un romanzo sociale e pure intimistico che poi diventa nella seconda parte, dopo l’arresto e con l’interrogatorio preliminare nella taverna di Mokroe, un legal thriller psicologico. Anziché il whodunit Dostoevskij ha cercato il whydunit, il perché del delitto invece di chi lo ha commesso. Il romanzo è di fatto una lunga interrogazione sul perché delle cose. Il giallo non c’è, altrimenti non si sarebbe avuta la confessione di reità del cuoco di Fedor Pavlovic, il padre ucciso, resa a Ivan Karamazov e soltanto a lui due giorni prima che metta in atto il proposito di suicidarsi. Morto il vero colpevole, Smerdjakov, rimane come unico testimone e depositario della verità il solo Ivan Fedorovic, dapprima convinto come la gran parte della responsabilità del fratello Dimitrj, ma poi pronto a riferire ai giurati quanto ha appreso da Smerdjakov, tanto da consegnare loro come prova i tremila rubli rubati in casa della vittima. Sarebbe il colpo di scena decisivo e tutto lo presagisce perché la ricostruzione che ha fatto Dostoevskij della sera del delitto, tenuta volutamente su una indistinta superficie dei fatti, si presta invero a creare la suspence, ma Ivan non è creduto attendibile dal tribunale giacché è preda di una febbre cerebrale che lo fa delirare al punto da riferire di avere avuto addirittura un incontro con il diavolo. Perché Dostoevskij fa questo? Prima crea l’attesa, poi la scioglie rendendo noto il colpevole, quindi non vuole che la verità si manifesti improvvisamente in pubblico con lo stesso effetto dirompente della lettera depositata da Katja nella quale Dimitrj le annunciava la decisione di uccidere il padre. La risposta è nello spirito del romanzo: la febbre di Ivan è dovuta a un rimorso, lo stesso che spinge Smerdjakov a impiccarsi, la consapevolezza cioè di essere il colpevole morale dell’omicidio, il vero parridica, colui che ha istigato il cuoco a uccidere il padre.
 Se Dostoevskij avesse voluto il giallo, avrebbe evitato l’incontro rivelatore tra Ivan e Smerdjakov e lasciato che la verità emergesse spettacolosa nell’aula giudiziaria. Ma Dostoevskij non voleva la verità, bensì la consacrazione dell’errore giudiziario (com’è intitolato il dodicesimo libro), così da mettere in capo alla giustizia umana la stessa colpa attribuita a quella divina, in confutazione dell’una e dell’altra per opera dello stesso Ivan, autore del poema “La leggenda del grande inquisitore” (che è un sofisticato apparato requisitorio sul tema della teodicea) e artefice della verità portata in tribunale e qui rigettata.
Se Dostoevskij avesse voluto il giallo, avrebbe evitato l’incontro rivelatore tra Ivan e Smerdjakov e lasciato che la verità emergesse spettacolosa nell’aula giudiziaria. Ma Dostoevskij non voleva la verità, bensì la consacrazione dell’errore giudiziario (com’è intitolato il dodicesimo libro), così da mettere in capo alla giustizia umana la stessa colpa attribuita a quella divina, in confutazione dell’una e dell’altra per opera dello stesso Ivan, autore del poema “La leggenda del grande inquisitore” (che è un sofisticato apparato requisitorio sul tema della teodicea) e artefice della verità portata in tribunale e qui rigettata.
Fosse stato del resto un giallo, il principale elemento accusatorio, costituito dalla porta del giardino che il servo Grigorj ricorda aperta (segno che Dimitrj è entrato in casa del padre per ucciderlo e derubarlo) mentre l’imputato afferma di averla trovata chiusa, non sarebbe stato liquidato con una inopportuna battuta da parte di Smerdjakov a colloquio con Ivan: richiesto di spiegare come fosse stato possibile che Grigorj l’avesse vista aperta dal momento che Fedor Pavlovic l’aveva aperta solo a lui, ma dopo che Grigorj era stato colpito da Dimitrj in fuga, risponde che al servo è sembrato di vedere la porta aperta ma non l’ha vista. Certamente una spiegazione non all’altezza dell’immaginazione dostoevskijana, ma tale da relegare in secondo piano un dato che in un giallo sarebbe stato invece fondamentale.
Dostoevskij è mosso da altri intenti. Pensa al seguito della sua saga familiare e sociale (ma morirà pochi mesi dopo) e lascia dunque il romanzo pressoché incompiuto. Nulla sappiamo infatti della progettata fuga di Dimitrj dopo la condanna ventennale ai lavori forzati in Siberia, né se Ivan sopravvivrà alla malattia. Nulla sappiamo di cosa farà Aleksej, il fratello minore che sin dal prologo è indicato come l’eroe protagonista mentre il romanzo è presentato come sua biografia, proposito questo confermato alla fine dall’hurrà lanciato a suo nome dai ragazzi di Kolja. E ancora, niente si sa del futuro di Gresun’ka e della rivale Katja, entrambe innamorate di Dimitrj, il quale lo è però solo della prima, che è pretesa pure dal padre, mentre la seconda lo è anche di Ivan: in un giro di vagheggiamenti e sospiri amorosi che in realtà isteriliscono e rendono non poco improbabile un romanzo che tuttavia vale non per le passioni incrociate, in omaggio dopotutto alla voga romantica del tempo, ma per le questioni esistenziali sollevate circa le molteplici e complesse trame della condizione umana. Si capisce dunque il finale, certamente piuttosto melodrammatico per l’incontro davanti a Dimitrj in ospedale di Gresun’ka e Katja – scena madre teatrale e plateale che sente della sotie – e quanto mai dissonante perché Dostoevskij preferisce dedicare l’epilogo al funerale del piccolo Iljusa anziché agli sviluppi postprocessuali: e ciò fa di proposito per riportare Aleksej sulla ribalta e calare le tende su di lui.
Il processo, con l’arresto a Mokroe e il primo interrogatorio notturno, occupa quasi metà del romanzo e Dostoevskij ne racconta lo svolgimento operando in due sensi: da un lato riepilogando i fatti già narrati nei dettagli, ma sottoposti ora al vaglio del giudice istruttore e del sostituto procuratore, con la raccolta delle testimonianze e delle diverse versioni, e da un altro ricostruendo la stessa istruzione preliminare da narratore onnisciente e terzo, così come ha fatto in precedenza, salvo riferire l’intera vicenda dei Karamazov a una storia ben nota nella cittadina dove immagina di vivere, chiamata Skotoprigonevsk, termine che in russo indica un mercato delle bestie. Ma arrivati al dibattimento, con l’inizio del dodicesimo libro, Dostoevskij cambia improvvisamente veste: da narratore estraneo si fa testimone diretto del processo e prende posto tra il pubblico. E come osservatore più volte scrive di poter riportare solo per stralci quanto ricorda di aver visto e sentito (ma poi trascrive accuratamente lunghissime parti della requisitoria e dell’arringa), rinunciando a raccontare «per filo e per segno» ciò che avviene in aula, e in questo modo sembra perciò valersi di una inopinata trovata ad effetto per rendere più vivida e suggestiva la scena. In realtà risponde a un preciso progetto di grande narratologia.
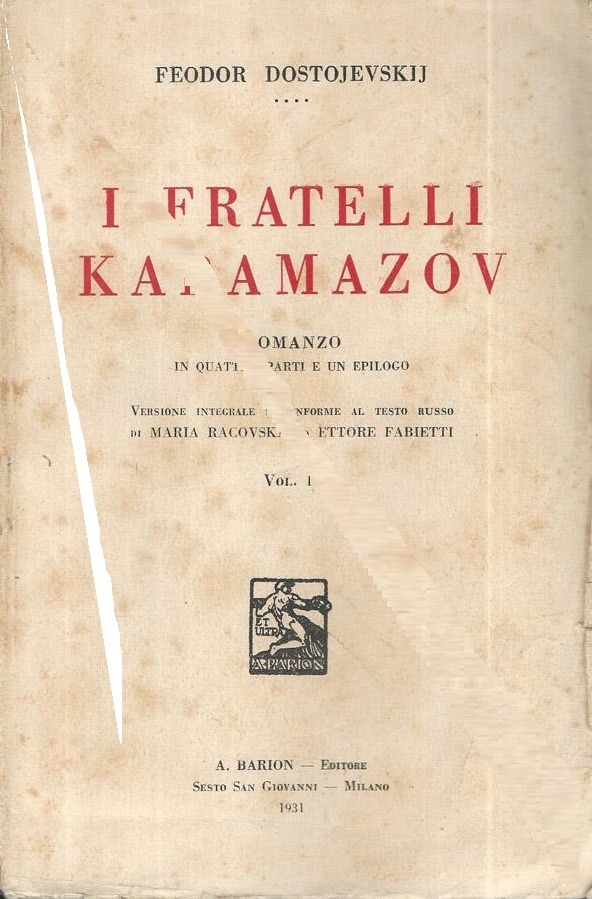 Avendo raccontato tutti i fatti per filo e per segno, sceverando il più profondo recesso di ogni coscienza, tanto da aver rasentato lo stucchevole per le tante divagazioni, le digressioni e le descrizioni minute che sono sembrate superflue e buone solo per i romanzi d’appendice a puntate, come in effetti I fratelli Karamazov fu conosciuto essendo uscito su una rivista prima che in volume, Dostoevskij si viene a trovare di fronte a una seria impasse: non può lasciare che l’accusatore e il difensore indulgano in alcuna congettura perché dovrebbe subito zittirli, conoscendo nei particolari la realtà dei fatti, né può sconfessare se stesso e quanto ha scritto nel rischio di apparire nei panni di chi deliberatamente inganni il lettore raccontando il falso quando ha ripetutamente dato i fatti per realmente avvenuti. La soluzione la trova in un colpo d’ala, un’autentica mossa del cavallo: si spoglia da romanziere e si veste da cittadino confuso nella folla che assiste al dibattimento – un dibattimento che curiosamente si svolge in un’unica udienza che comincia la mattina e termina, nello sfinimento generale, a notte inoltrata con il verdetto di colpevolezza dei giurati e le opposte reazioni del pubblico di cui egli si fa mero portavoce. Alla certezza dei fatti sostituisce dunque il dubbio, che assale lo spettatore e lascia fuori dall’aula il narratore. Per essere più chiaro scrive così quando si addice a narrare: «Non posso continuare in questo modo, in parte perché molte cose non riuscii a sentirle, altre non riuscii ad approfondirle, altre ancora le ho dimenticate, ma soprattutto perché, come ho detto prima, non ho letteralmente né spazio né tempo per menzionare tutto quello che fu detto e fatto». Dostoevskij finge di essere un altro, uno del pubblico, peraltro piuttosto disattento. Atteggiamento utile per evitare di dover prendere posizione di fronte a una sentenza di condanna ingiusta e sbagliata. Ma ciò è noto solo al lettore, perché il pubblico l’accetta come espressione della sovrana volontà statale. E Dostoevskij non spende una parola a favore di Dimitrj. Al pronunciamento del verdetto, il dodicesimo libro si chiude infatti con questo brano:
Avendo raccontato tutti i fatti per filo e per segno, sceverando il più profondo recesso di ogni coscienza, tanto da aver rasentato lo stucchevole per le tante divagazioni, le digressioni e le descrizioni minute che sono sembrate superflue e buone solo per i romanzi d’appendice a puntate, come in effetti I fratelli Karamazov fu conosciuto essendo uscito su una rivista prima che in volume, Dostoevskij si viene a trovare di fronte a una seria impasse: non può lasciare che l’accusatore e il difensore indulgano in alcuna congettura perché dovrebbe subito zittirli, conoscendo nei particolari la realtà dei fatti, né può sconfessare se stesso e quanto ha scritto nel rischio di apparire nei panni di chi deliberatamente inganni il lettore raccontando il falso quando ha ripetutamente dato i fatti per realmente avvenuti. La soluzione la trova in un colpo d’ala, un’autentica mossa del cavallo: si spoglia da romanziere e si veste da cittadino confuso nella folla che assiste al dibattimento – un dibattimento che curiosamente si svolge in un’unica udienza che comincia la mattina e termina, nello sfinimento generale, a notte inoltrata con il verdetto di colpevolezza dei giurati e le opposte reazioni del pubblico di cui egli si fa mero portavoce. Alla certezza dei fatti sostituisce dunque il dubbio, che assale lo spettatore e lascia fuori dall’aula il narratore. Per essere più chiaro scrive così quando si addice a narrare: «Non posso continuare in questo modo, in parte perché molte cose non riuscii a sentirle, altre non riuscii ad approfondirle, altre ancora le ho dimenticate, ma soprattutto perché, come ho detto prima, non ho letteralmente né spazio né tempo per menzionare tutto quello che fu detto e fatto». Dostoevskij finge di essere un altro, uno del pubblico, peraltro piuttosto disattento. Atteggiamento utile per evitare di dover prendere posizione di fronte a una sentenza di condanna ingiusta e sbagliata. Ma ciò è noto solo al lettore, perché il pubblico l’accetta come espressione della sovrana volontà statale. E Dostoevskij non spende una parola a favore di Dimitrj. Al pronunciamento del verdetto, il dodicesimo libro si chiude infatti con questo brano:
Condussero via Mitja [diminutivo di Dimitrj]. La lettura della sentenza fu rimandata al giorno successivo. Nell’aula si sollevò un trambusto indicibile, ma io non restai a sentire quello che si diceva. Ricordo soltanto alcune battute ad alta voce che udii all’uscita. «Si beccherà una ventina d’anni di miniera». «Non meno». «E così, i contadinotti [i giurati] hanno tenuto duro». «E hanno bell’e sistemato il nostro Miten’ka [vezzeggiato di Dimitrj]».
Nessuna indulgenza e l’accoglimento del giudizio popolare. Dostoevskij non ha comprensione né per lui, un «mascalzone» a sua stessa detta, dalla vita disordinata e biasimevole, né per Ivan, il vero parricida, l’ateo irriducibile. Il suo favore è tutto per Alesha, il ragazzo di ogni pregio e virtù che voleva farsi monaco e per il quale una parte abbondantissima del romanzo viene impegnata per edificarne la statura morale attraverso la figura dello starec Zosima, il suo padre spirituale in odore di santità – benché il suo cadavere alla fine puzzi come ogni mortale e contrariamente a ogni santo. Attorno a Zosima è costruito un romanzo nel romanzo che è una colossale digressione rispetto al caso del padre ucciso. Ma di digressioni è formato I fratelli Karamazov, un esercizio narrativo che può essere studiato come prova delle possibilità del romanzo di non esaurirsi mai, perché dimostra la teoria secondo cui ogni personaggio introduce un nuovo romanzo che comincia con la storia di quel personaggio. I continui rimandi che Dostoevskij fa di un racconto ad un altro momento («Ne parleremo in seguito») rivelano una eterogenesi di fini che mutua l’effettiva realtà della quale l’autore moscovita non coglie, senza farsi alcuno scrupolo di apparire logorroico e per amore della circostanza, che la sostanza – ciò che costituisce uno dei motivi per cui I fratelli Karamazov richiedono un lettore forte e forgiato, disposto anche a sostenere un cerebralismo che a volte sottende una materia cervellotica, una trama confusa e poco coerente, personaggi ondivaghi.
In questo quadro la figura di Smerdjakov è la meno riuscita: ritenuto da tutti un idiota, succube anche dell’irritamento di Ivan che lo plagia, è tuttavia capace di strategie di intelligenza sopraffina, come l’idea della busta con i soldi lasciata a terra strappata, così da far credere che non è stato lui l’omicida, giacché ne conosceva il contenuto per cui non l’avrebbe aperta, e l’astuzia di indurre, ma senza esprimersi chiaramente, sia il procuratore che l’avvocato a valutare proprio questa circostanza per scagionarlo. Mostra anche la grande lucidità che gli fa gridare a Ivan: «L’assassino principale siete voi». Ma pure il delitto che compie appare confuso: da un lato è premeditato, come fa capire a Ivan, e da un altro appare come istintivo e deciso al momento in cui sente Grigorj urlare a Ivan «parricida». Anche il personaggio di Katja Ivanovna è incerto: ama e odia Mitja contemporaneamente e mentre fornisce prove della sua colpevolezza si dichiara poi pronta a rischiare per farlo evadere. Agrafena Aleksandrovna, la Grusen’ka, non è da meno: opportunista, di costumi leggeri, alquanto svampita, ama tutti e tutti prende in giro, Mitja compreso, ma poi chiede di poter andare in Siberia per stargli vicina. Quanto alla trama, essa ruota anche attorno a tremila fatidici rubli, che costituiscono la somma conservata da Fedor Pavlovic in una busta, la somma che Katja consegna a Mitja perché la spedisca a dei parenti a Mosca, la somma che Mitja ritiene necessario trovare per potere fuggire con Grusen’ka. In realtà una diversa cifra avrebbe svuotato l’apparato accusatorio, cosicché Dostoevskij trova preferibile una vistosa incongruenza a un diverso indirizzo diegetico.
E trova anche, molto stranamente, di non doversi mai pronunciare sul tema centrale, il parricidio. In tribunale l’accusatore è il solo a stigmatizzare il reato invitando i giurati a non giustificare l’assassinio di un padre da parte del proprio figlio, ma il difensore appresta argomenti proprio per giustificare l’assassinio di un genitore abbietto commesso da un figlio non trattato come tale. Dostoevskij si limita a riportare entrambe le opinioni, ma per il resto evita di affrontare il tema, il più scottante e importante tra i tantissimi che pure ha analizzato. Solo una volta Ivan dice a sé stesso di odiare Mitja non perché Katja vada a trovarlo in carcere ma «per il fatto che aveva ucciso il padre», parole che Dostoevskij ritiene di dover scrivere in corsivo. Ma subito dopo Ivan parla a Mitja del piano di fuga cui ha pensato mentre ha già cominciato a maturare la consapevolezza di essere stato il mandante del parricidio e si appresta al terzo e ultimo incontro con Smerdjakov che gli rivelerà l’innocenza del fratello.
Dostoevskij, che chiama «punti romantici» gli aspetti della vita privata individuale, quella che Mitja vuole preservare durante l’interrogatorio preliminare, si dimostra allo stesso tempo il più percussivo esploratore dell’animo umano e nello stesso tempo vuole essere uno scrittore realista, che racconta ai suoi soli concittadini una storia privata che essi conoscono bene essendo loro la sua fonte principale più volte richiamata. Una storia data per vera che però è difficile immaginare che sia mai avvenuta, gravida com’è di inverosimiglianze e contraddizioni. Tuttavia, nonostante i difetti a volte strutturali, I fratelli Karamazov rimane un capolavoro assoluto della letteratura di tutti i tempi. Tolstoj, al quale Dostoevskij pure guardò con attenzione per scrivere il suo romanzo, come ha dimostrato George Steiner in Tolstoj e Dostoevskij, lo volle sul comodino del suo letto di morte e la filosofia ha sempre ammirato il libro per le sue coraggiose tesi circa i rapporti tra uomo e Dio. In Ivan, che crede in Cristo ma non in Dio, che a volte è ateo e a volte credente, si è voluto vedere lo stesso Dostoevskij il quale per tutta la vita si è interrogato in effetti sull’esistenza di Dio. Come osserva Vladimir Laksin nel saggio introduttivo a un’edizione Einaudi, il mirabile di questo romanzo è nell’atteggiamento del suo autore che non lo ha scritto per offrire risposte a domande universali ma per cercarle. Il fatto che quasi tutti i personaggi mutino comportamenti e idee, che in gran parte non sono descritti fisicamente se non per vaghi cenni (Ivan non lo è per niente), è spia di una ricerca frenetica dell’essere. E forse, cercando e non trovando l’uomo e con esso Dio, Dostoevskij ha dato in esso la più febbrile prova della loro indeterminabile natura.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
[è appena uscito il nuovo romanzo di Gianni Bonina: “Ammatula” (Castelvecchi) – di recente in libreria anche il volume: “Fatti di mafia” (Theoria)]
* * *
[Tutte le puntate di Leggerenza sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo




