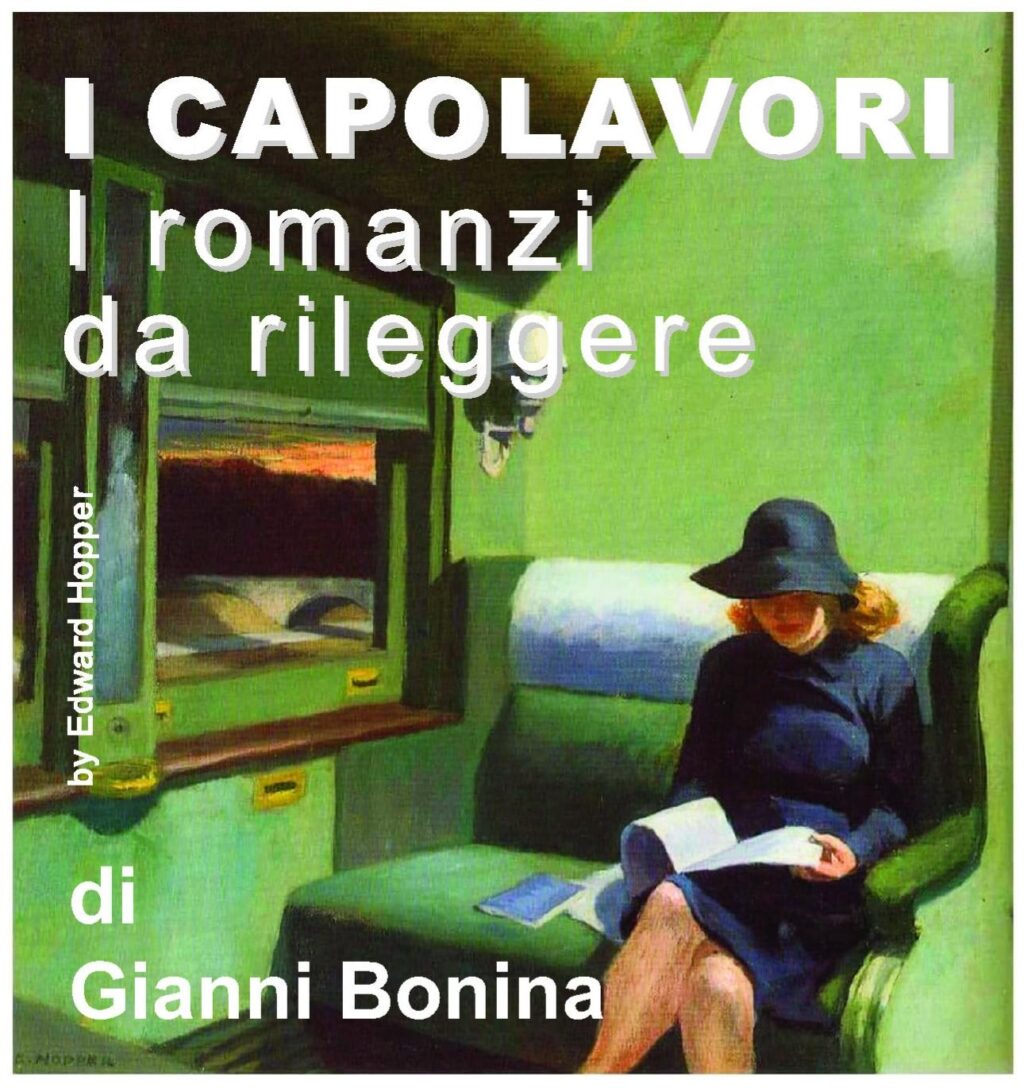
Nel 1946, all’indomani della Conferenza di Potsdam e del ricordino geopolitico dell’Europa, George Orwell sente l’urgenza (nonostante l’avanzata consunzione tisica che gli lascia solo quattro anni di vita) di tornare dopo sette anni al romanzo e in Perché scrivo, elzeviro dello stesso periodo, si fa un proponimento: “Spero di scrivere un altro romanzo abbastanza presto. È destinato a essere un fallimento (tutti i libri lo sono), ma ho le idee piuttosto chiare sul tipo di testo che voglio scrivere”. Sbaglia a pronosticare un insuccesso e sbaglia anche quanto alla chiarezza delle idee: 1984 nasce da un fomite di impegno politico, ma risente dei nodi della coscienza civile e letteraria che l’autore ha tenuto irrisolti, prima e dopo il suo capolavoro.
 Sebbene infatti, ancora in Perché scrivo, dichiari la propria vocazione éngagé (“Ogni rigo di lavoro serio che ho prodotto dal 1936 l’ho scritto, direttamente e indirettamente, contro il totalitarismo e per il socialismo democratico”), in Dentro la balena del 1940 si è piuttosto schierato dalla parte di Arthur Miller, comprendendone – pur non giustificandone – la spinta escapista nel disinteresse mostrato ai turbinosi rivolgimenti politici mondiali e dando fondamento all’immagine di Giona che dentro la balena trova il modo di estraniarsi dal mondo, mentre due anni dopo, in Gli scrittori e il Leviatan, suggerirà che “quando uno scrittore si impegna in politica dovrebbe farlo come cittadino, non come scrittore”, essendo necessario “stabilire una linea di demarcazione più netta tra i nostri convincimenti politici e i nostri convincimenti letterari”. Orwell è allora autore camusiano della massima presenza nella realtà o autore calviniano dell’assoluto distacco da essa?
Sebbene infatti, ancora in Perché scrivo, dichiari la propria vocazione éngagé (“Ogni rigo di lavoro serio che ho prodotto dal 1936 l’ho scritto, direttamente e indirettamente, contro il totalitarismo e per il socialismo democratico”), in Dentro la balena del 1940 si è piuttosto schierato dalla parte di Arthur Miller, comprendendone – pur non giustificandone – la spinta escapista nel disinteresse mostrato ai turbinosi rivolgimenti politici mondiali e dando fondamento all’immagine di Giona che dentro la balena trova il modo di estraniarsi dal mondo, mentre due anni dopo, in Gli scrittori e il Leviatan, suggerirà che “quando uno scrittore si impegna in politica dovrebbe farlo come cittadino, non come scrittore”, essendo necessario “stabilire una linea di demarcazione più netta tra i nostri convincimenti politici e i nostri convincimenti letterari”. Orwell è allora autore camusiano della massima presenza nella realtà o autore calviniano dell’assoluto distacco da essa?
1984 è invero il frutto di uno stato permanente di inquietudine (lo stesso per il quale è stato ben cinque anni, poi ripudiati, poliziotto britannico e imperialista in Birmania, ha cambiato mogli e più volte lavoro, ha tentato di stuprare una donna, ha condotto en travesti anche vita da barbone, ha professato una fede di socialista non essendolo fino in fondo, ha nascosto il contributo decisivo della prima moglie Eileen Maud O’Shaughnessy sia alla Fattoria degli animali che allo stesso 1984) e fonte di una rabbia sorda rivolta contro l’insorgenza tirannica cui Orwell assiste impotente vedendo determinarsi la costituzione dei Blocchi contrapposti, presupposto di una “Guerra fredda” annunciata.
All’inizio l’autore non pensa a un romanzo distopico, tanto da meditare il titolo “L’ultimo uomo in Europa”, intendendo quindi denunciare il proprio presente, e forse non pensa neppure a una forma-romanzo del tipo La fattoria degli animali, perché è il saggio a premergli, l’atto politico di intervento e di protesta; senonché il successo, sofferto, tardo, ma prorompente della Fattoria (prima sua operazione nella specie della favola di demistificazione dell’ideologia totalitaristica), lo convince a seguire la stessa via. Ma 1984 (titolo che nasce da un gioco di inversione delle due ultime cifre concepito a romanzo completato) è, per la trascrizione integrale di due capitoli, il primo e il terzo, del “Libro” proibito di Emmanuel Goldstein, l’oppositore fantasma del regime a capo della Confraternita, un saggio a tutti gli effetti, meglio un pamphlet ragionato e lucido sullo scacchiere geopolitico, sulla forma di stato e di governo di Oceania e sulle previsioni di maliscenza della situazione globale.

Il romanzo non ha in realtà bisogno del Libro, ma per Orwell è il Libro (il cui autore implicito è proprio lui, piazzato alle spalle di Trotzskij) ad avere bisogno del romanzo cosicché la sua visione del mondo, sia pure facendosi visionaria, possa avere un pubblico che un trattato non gli assicurerebbe nelle stesse proporzioni. Significativa è l’Appendice dedicata ai “Principi della Novalingua”: non è un estratto del Libro perché appare come scritta molti anni dopo addirittura il 1984 (“Nel 1984 nessuno usava esclusivamente la Novalingua per comunicare”) ed ha la natura dello studio filologico opera del narratore e quindi dello stesso autore. Che a questo punto sembra aver voluto timbrare il suo romanzo di “falso”.
Libello dunque travestito, 1984 si è nondimeno assestato nel genere letterario del distopico come signum individuationis di uno Stato, futuristico e immaginario, alla mercé di un Partito unico opprimente, totalitario e liberticida. Orwell in verità non ha bisogno di immaginare un Paese che sia là da venire, perché ce l’ha davanti nell’evidenza dell’Unione sovietica, né fa mistero del correlato, giacché i cittadini e le autorità statali si chiamano tra di essi “compagni”, la superpotenza Eurasia è riferita alla Russia, il termine “Partito” è un lessema eponimo di un preciso sistema, quello russo. Ed è infatti proprio l’Urss – o Russia sovietica come spesso è chiamata – che Orwell punta a rappresentare, con l’escamotage di posticipare di trentasei anni i fatti in narrazione, anzi il vasto apologo del caso Winston Smith (nome mutuato da Churchill e cognome preso dalla più diffusa onomastica britannica): senza però immaginare che proprio intorno al 1984 prenderanno il via le trattative che tre anni dopo porteranno Reagan e Gorbarciov a firmare un primo trattato sul disarmo atomico, quanto allo smantellamento delle basi europee, e che mancheranno solo cinque anni perché l’impero sovietico cada su se stesso. Quando insomma Orwell prefigura il culmine del totalitarismo si ha invece l’inizio del suo declino proprio nella roccaforte euroasiatica.
Decidendo di riportare eventi, benché finzionali, compresi entro il 1984, l’anno in cui Winston Smith imprende a scrivere il suo diario segreto destinato alle future generazioni perché sappiano, Orwell non può che attenersi, scrivendo in realtà dal ’46 al ‘48, alle conoscenze del suo tempo, per modo che, sancendo nel fantomatico Libro che “con l’instaurazione di economie autosufficienti in cui la produzione è direttamente proporzionale al consumo intero, si è chiusa la corsa ai mercati che rappresentava la motivazione principale delle guerre del passato e la contesa per le materie prime non è più una questione di vita e di morte”, essendolo semmai diventata la disputa della manodopera, manca clamorosamente di presagire fenomeni epocali quali l’estrazione petrolifera, la globalizzazione e i flussi migratori che negli anni Ottanta del riflusso saranno realtà dominante. Di più. Quando scrive che “con lo sviluppo della televisione e i progressi tecnologici che resero possibile ricevere e trasmettere simultaneamente dallo stesso apparecchio, la vita privata cessò di esistere”, Orwell non può immaginare l’avvento di Internet e, fatta salva una più capillare comunicazione, i suoi effetti collaterali circa il massimo restringimento proprio della vita privata nella quale ogni individuo si sarebbe rinchiuso. Né può sapere, parlando alla fine degli anni Quaranta di stelle lontane milioni di anni-luce, che oltre la nostra galassia esistono miliardi di altri sistemi solari.
Tutt’altro che profetico, 1984 è allora un romanzo legato al tempo del suo autore e dunque alla metà del ventesimo secolo. Va letto come tale e non alla stregua di un vecchio vaticinio che si realizzi nel nostro tempo. Concordava anche Umberto Eco quando in una prefazione al romanzo scriveva: “Il libro ha molto poco di profetico. Almeno i tre quarti di quanto racconta non è utopia negativa, è storia”. Orwell parla ai contemporanei per metterli in guardia, ma guarda ai posteri, così cadendo nel distopico e nel fantastico, rasentando la science-fiction. Ma prima dei suoi “monitoranti”, dei “parlascrivi”, del “bipensiero”, della “psicopolizia”, della “novalingua”, ci sono stati gli androidi di Asimov e le sue tre leggi robotiche, sono arrivati il “soma” e l’ipnopedia di Aldous Huxley di Il mondo nuovo, è appena uscito in America La scimmia e l’essenza dello stesso Huxley sugli effetti della guerra atomica: il romanzo distopico è insomma già cresciuto. Del resto Orwell conosce bene, avendolo recensito, il fondamentale Buio a Mezzogiorno (1940) di Arthur Koestler, dove un dissidente del regime stalinista sottoposto a tortura accetta di confessare ogni colpa benché innocente perché, secondo Orwell, non c’è alcun motivo per non farlo: esattamente quanto farà Winston Smith nelle mani dei suoi aguzzini.
Orwell innova tutt’al più evocando le ricadute del totalitarismo su una società nella quale la guerra è elemento costitutivo del suo sviluppo, motivo di un’emergenza senza fine che richieda la concentrazione generale e distragga gli individui da occasioni di felicità qual è il sesso, assolutamente scoraggiato. Winston e Julia sanno che, amandosi e incontrandosi, hanno firmato il loro arresto e reso inevitabile “l’orrore degli scantinati del ministero della Verità”. Ma pensano che il Partito non potrà loro modificare le opinioni politiche che nutrono quali avversari del Grande Fratello, perché “possono farti dire quello che vogliono, ma non possono fartela pensare”, tuttavia Winston sperimenterà che proprio i pensieri gli saranno per mezzo della tortura, cancellati e dovrà accettare che due più due fa cinque, senza alcuna possibilità di dimostrare il contrario perché il passato con tutto il suo bagaglio di saperi non esiste più. Chiara l’allusione di Orwell alle pratiche di condizionamento mentale e indottrinamento in uso nei regimi dispotici. Ovvero, nella sua ottica di socialista liberale contrario a ogni forma di coercizione, nell’Unione sovietica di Stalin.
 In questa prospettiva, se per il suo spirito allegorico La fattoria degli animali appare molto più attuale, 1984 viene oggi posto a paradigma moderno proprio per le sue pronunciate implicazioni politiche. Cosa fa Orwell? Corregge a suo modo l’Accordo di Potsdam e divide il mondo in tre grandi potenze – Oceania, Eurasia ed Estasia – riconducendole a Stati Uniti, Unione sovietica e Cina. L’Europa, culla del nazismo e del fascismo le cui ceneri sono ancora calde e perciò non intende toccarle, la assegna all’Eurasia, escludendo però le isole britanniche che confluiscono nell’Oceania, tanto che la moneta corrente a Londra, capitale di Autodromo Due, è il dollaro. Smembra così l’Europa (peraltro precorrendo anche la Brexit) e si pone come antieuropeista nel momento stesso in cui destina il vecchio continente a un regime chiamato “Socing”, contrazione di “English socialism”, retto dal Partito a capo del quale si erge “l’infallibile e onnipotente” Grande Fratello, immaginato iconograficamente a mezzo tra Hitler e Stalin, e considerato una divinità terrena, tale da non doversi mai pronunciare la parola “Dio”.
In questa prospettiva, se per il suo spirito allegorico La fattoria degli animali appare molto più attuale, 1984 viene oggi posto a paradigma moderno proprio per le sue pronunciate implicazioni politiche. Cosa fa Orwell? Corregge a suo modo l’Accordo di Potsdam e divide il mondo in tre grandi potenze – Oceania, Eurasia ed Estasia – riconducendole a Stati Uniti, Unione sovietica e Cina. L’Europa, culla del nazismo e del fascismo le cui ceneri sono ancora calde e perciò non intende toccarle, la assegna all’Eurasia, escludendo però le isole britanniche che confluiscono nell’Oceania, tanto che la moneta corrente a Londra, capitale di Autodromo Due, è il dollaro. Smembra così l’Europa (peraltro precorrendo anche la Brexit) e si pone come antieuropeista nel momento stesso in cui destina il vecchio continente a un regime chiamato “Socing”, contrazione di “English socialism”, retto dal Partito a capo del quale si erge “l’infallibile e onnipotente” Grande Fratello, immaginato iconograficamente a mezzo tra Hitler e Stalin, e considerato una divinità terrena, tale da non doversi mai pronunciare la parola “Dio”.
Scopo primario del Socing è creare l’uomo devoto al Partito-divinità dividendo la società in “Partito Interno”, il cervello, “Partito Esterno”, le mani e “prolet”, la massa “istupidita” che deve essere tenuta in tale stato, perché si istruirebbe se la ricchezza fosse distribuita equamente e di conseguenza capirebbe che la casta oligarchica dei privilegiati al potere non avrebbe alcuna funzione per cui la rovescerebbe. Questa è però la teoria contenuta nel Libro, cioè il credo del Partito. Orwell la pensa invece diversamente e lo fa dire a Winston: “Se c’è una speranza, va cercata nei prolet”. Secondo Winston i proletari sono i soli ad essere rimasti umani e quindi capaci di raggiungere una consapevolezza sufficiente, come “coscienza di classe”, a insorgere contro il Partito e abbatterlo. Non è questione di ricchezza. Il popolo ha unicamente bisogno di prendere atto – marxianamente, leninianamente – della propria condizione di assoggettamento per ribellarsi, anche se non istruito.
Winston se ne rende conto assistendo a un litigio tra donne davanti a una bancarella. La furia mostrata da una di loro lo impressiona. “Che potenza spaventosa era risuonata in quel grido”: messa al servizio di un’altra causa avrebbe sortito, con tutte le altre, un effetto rivoluzionario. Guardando poi la forza fisica di una lavandaia in cortile, Winston capisce che è simbolo dei prolet e auspica che la forza si muti in consapevolezza: “Da quei lombi vigorosi un giorno sarebbe dovuta sorgere una razza di esseri consapevoli”.
Questa visione nasce in Orwell agli inizi del quinto decennio del Novecento quando comincia a La fattoria degli animali. Nella prefazione rivela che l’idea gli è venuta dopo aver visto un ragazzino colpire più volte un enorme cavallo da tiro: “Se solo questi animali prendessero coscienza della loro forza non dovremmo avere alcun potere su di loro; gli uomini sfruttano gli animali più o meno allo stesso modo in cui i ricchi sfruttano il proletariato”.
Winston Smith, che fa parte del Partito Interno e lavora al ministero della Verità con il compito di cancellare documenti del passato perché la storia da accreditare come autentica sia quella scritta al presente (“La storia si è fermata, non esiste null’altro che un infinito presente”), è attratto dai prolet e vuole conoscere da loro come si viveva prima della “Rivoluzione” degli anni Cinquanta. Va in un pub e parla con un vecchio avventore dal quale non apprende che banalità di poco conto, Quel che fa Winston lo ha fatto lo stesso Orwell, che più volte si è travestito da barbone per stare con i poveri e raccontare dal vivo la loro esperienza.
In questa e altre chiavi il romanzo riflette pienamente la coscienza dell’autore e le sue fobie, come quella per i topi, lo strumento di tortura che terrorizza Winston, ma mostra anche palesi implausibilità forse dovute allo stato di salute di Orwell sempre più grave. Appare soprattutto inverosimile che, in un clima di sospetti nel quale sono invischiati pure i bambini, pronti a denunciare per legge persino i genitori in odore di eterodossia, Winston non venga colto da alcun dubbio circa la vera identità del vecchio negoziante, sul quale non compie alcuna indagine, arrivando addirittura ad affittare una sua camera, e ancora di più non diffida di O’Brien, al punto da andare a casa sua portando con sé addirittura Julia per dichiararsi entrambi nemici del Partito e disposti a entrare nella Confraternita. Imprecisa è la figura di Julia, che è disinteressata al Partito e alla politica come anche all’ideologia della Confraternita (forse un ricalco di Arthur Miller), è piena di vita e di voglia di sesso, militante e attivista solo apparentemente, ma poi aderisce alla “Resistenza” e tace quando O’Brien dice, contro la sua concezione della vita già espressa con fermezza a Winston, “Noi siamo i morti, la nostra vita è nel futuro”. Ondivaga è la condotta anche di O’Brien, che tortura e rianima Winston Smith con piacere sadico e animo solidale troppo spiccati per non essere contradditori. Persegue lo scopo di rieducarlo ai dogmi del Partito, alla fine riuscendoci e nondimeno decide di farlo uccidere benché Winston sia tornato un cittadino obbediente e un utile quadro del Partito: utile idiota però, se ha comprato un quaderno, gesto vietatissimo, per lasciare scritte non le sue memorie o eventuali teorie o manifesti politici, ma appunti di poco conto, ben sapendo di rischiare di essere scoperto e che nessun utilizzo avrebbe potuto mai farne, giacché “nemmeno un parola anonima scribacchiata su un pezzo di carta sarebbe sopravvissuta fisicamente”.
Manca poi il prolet eroe e martire, il John il Selvaggio di Buio a mezzogiorno, che dia voce e volto alla classe dei poveri e della massa dei cittadini, costituendo il vero antagonista del Potere. E mancano Londra, l’Oceania con i suoi trecento milioni di abitanti, gli altri due Stati, gli scenari di guerra (messi in dubbio da Julia ma dati per certi dal Libro), la vita quotidiana, la gente comune. Ma a Orwell interessa poco la tenuta della trama, importandogli il fondamento della sua polemica. La storia di sesso di Winston e Julia, un po’ sopra le righe in un romanzo politico e pubblico, ma efficace, è da lui assunta a colpa emblematica, motivo di reale violazione dei precetti del Partito, sicché le parole di Julia sintetizzano il clima istituzionale instaurato da Orwell: “Quando fai l’amore consumi energia. E dopo ti senti benissimo e non te ne frega più di niente. E loro non lo sopportano che tu ti senta così. Vogliono che tu sia sempre carico come una molla. Tutto questo marciare avanti e indietro e inneggiare e sbandierare è solo sesso andato a male”.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
[i nuovi libri di Gianni Bonina sono: “Un cuore per la signora Chimento” (Marlin editore); “Ammatula” (Castelvecchi); “Fatti di mafia” (Theoria)]
* * *
[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]
* * *
© Letteratitudine – www.letteratitudine.it
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo



