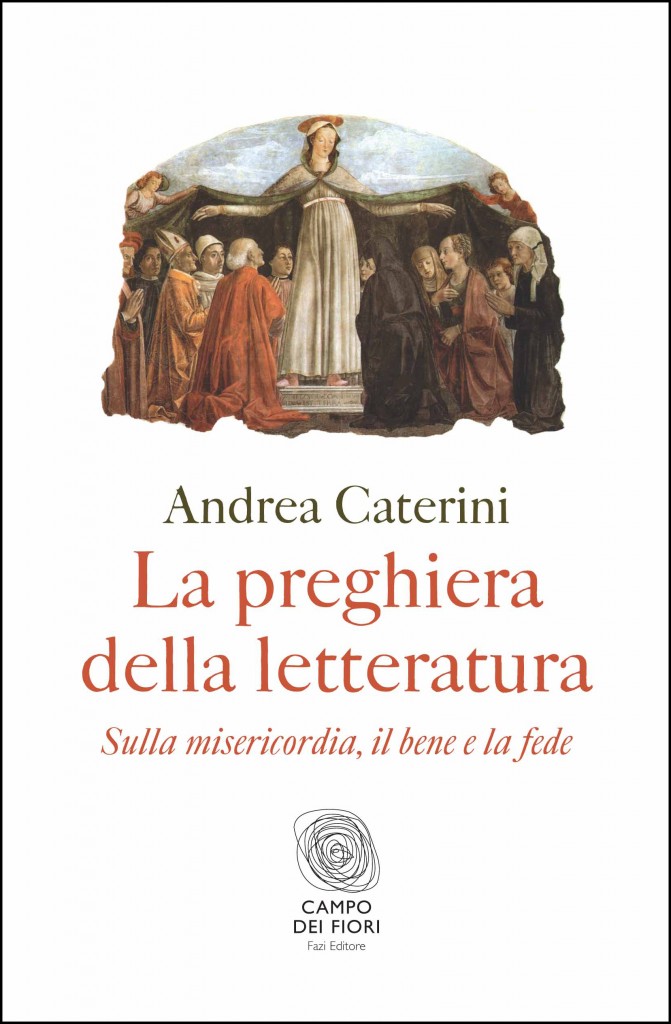 “LA PREGHIERA DELLA LETTERATURA. Sulla misericordia, il bene e la fede” di Andrea Caterini (Fazi editore)
“LA PREGHIERA DELLA LETTERATURA. Sulla misericordia, il bene e la fede” di Andrea Caterini (Fazi editore)
* * *
Il nuovo appuntamento della rubrica di Letteratitudine chiamata “Saggistica Letteraria” è dedicato a questo ottimo lavoro di Andrea Caterini intitolato “La preghiera della letteratura. Sulla misericordia, il bene e la fede” (Fazi editore).
In queste pagine, Andrea Caterini (scrittore e saggista: ne approfitto per ricordare il suo romanzo “Giordano”… qui un’intervista all’autore), propone una riflessione su alcuni termini chiave della cristianità: Pace, Sacrificio, Misericordia, Bene, Santità e Fede. Sono parole antiche (potremmo dire “eterne”) e pregne di significato. Caterini analizza ogni parola attraverso la lettura e l’analisi di uno o più scrittori, da Virgilio a Dostoevskij, da Anna Achmatova ad Anton Cechov. Come precisato nella scheda del volume, “La preghiera della letteratura” non è però un libro di critica letteraria (anche se attraverso la letteratura costruisce i suoi ragionamenti filosofici, con la convinzione che essa sia ancora uno strumento privilegiato di conoscenza)… ma “riflette su quanto la letteratura sia essa stessa una particolare forma di preghiera e di come poesia e testi sacri abbiano da sempre dialogato tra loro“.
Per gentile concessione dell’autore e della casa editrice, pubblichiamo di seguito il capitolo intitolato “Il sacrificio” (dove lo scrittore “protagonista” è Cechov).
* * *
Il sacrificio
(da La preghiera della letteratura di Andrea Caterini – Fazi editore)
1.
[…]
 In ogni pagina di Čechov ci sembra che un senso d’affanno, uno spezzarsi del fiato, un’angoscia di soffocamento stiano sempre a un momento dall’arpionarci. Eppure Čechov non si lamenta di nulla, si nasconde discreto dietro le parole. No, non è lui che impreca miseria e ingiustizia. Delega ai suoi personaggi ogni espressione. Li osserva, convinto di non poterli curare, di non poter curare, nonostante la scienza – lui medico, oltre che scrittore – il tumore che s’annida dentro ognuno: il terrore della morte, il senso di inadeguatezza e impotenza rispetto alla vita, l’incapacità che gli uomini hanno di comprendersi. Eppure è lì, al lume fioco di una lampada, stretto all’angolo, piegato su una sedia dietro le quinte, sempre sfuggente, con l’atteggiamento di chi pare abbia un’anima fredda, schermato da una patina di imperturbabilità. Se nessuno può nulla, sembra però dica, bisognerà pure che qualcuno si sacrifichi per l’umanità, che all’umanità sia concessa una felicità che io, Anton, osservandovi da dietro e piangendo, ma sempre senza lacrime, non posso concedermi. Che gli uomini siano felici. Ma come? Che qualcuno vi racconti, nel bene e nel male, chi siete. Nella biografia che gli dedica, La vita di Čechov – una biografia che somiglia a un romanzo attento a svelare la personalità, la sensibilità del personaggio, più che al rigore delle fonti –, Irène Némirovsky scrive che «Malgrado il desiderio dei suoi lettori e della critica, l’opera di Čechov non insegna nulla. Mai potè dire con sincerità, come faceva Tolstoj: “Agite così e non altrimenti” […]. In compenso, le sue lettere e la sua vita elevano davanti a noi l’immagine ammirevole di un uomo che, nato giusto, delicato e buono, si sforzò senza sosta di diventare migliore, più tenero, ancora più caritatevole, più affettuoso, più paziente, più sottile». Certo ci sembra che la Némirosvsky non sbagli a dire che Čechov «non insegna nulla». No, Anton non è un maestro, non ha la presunzione di pontificare, non è capace di muovere un popolo così come il conte Tolstoj, che invitava a vivere nel bene. Ma in cosa consisteva il bene proposto da Tolstoj? Mi permetto un inciso non privo di senso. Al principio del 1900, il critico trentaquattrenne di Kiev, il semisconosciuto Lev Šestov, quello che diventerà negli anni successivi uno dei maggiori filosofi e teologi del XX secolo ma che aveva allora pubblicato solo un libro dedicato a Shakespeare passato però inosservato, dà alle stampe uno studio che farà invece molto discutere, L’idea di bene in Tolstoj e Nietzsche. Tolstoj, invece, è già l’autore dei suoi capolavori: Guerra e pace e Anna Karenina. Quando Šestov propone il suo libro ad alcuni editori, c’è chi gli consiglia di non pubblicarlo, perché le accuse a Tolstoj e l’adesione alla filosofia di Nietzsche gli causeranno certo dei problemi. In verità Šestov sta definendo e gettando le basi di quella che sarà la ricerca filosofica che lo accompagnerà per tutta la vita, espressa poi in numerosi libri come Sulla bilancia di Giobbe (1929) e Kierkegaard e la filosofia esistenziale (1936). Non era cosa poco coraggiosa mettersi contro il conte Tolstoj in quel momento, se è vero che l’autore de La morte di Ivan Il’ic era allora considerato in patria una specie di profeta e che ormai rinnegava anche il suo lavoro precedente. Šestov vuole prendere di mira la sua ultima produzione, sintetizzata nel saggio Che cos’è l’arte?, un libro che, nota il filosofo, con l’arte non ha nulla a che fare. Tolstoj ha in mente esattamente questo: l’uomo deve servire il bene per poter vivere al meglio, e non importa se tale bene prestabilito e ideologicamente razionalizzato nasconda una crepa, una falla, un dubbio dentro cui lo stesso Tolstoj vive (come dimostrano le sue opere precedenti) pur decidendo di tacerlo, credendo non utile esporlo ai suoi discepoli: l’intero popolo russo. Tolstoj, di fatto, anche credendo che la sua ideologia – l’ideologia di un bene che fosse sinonimo di Dio, ma un Dio idealizzato, costruito a tavolino – fosse insufficiente a comprendere ogni cosa della vita, pensa sia necessario che gli uomini, affinché avvenga il loro riscatto sociale, più che esistenziale, debbano seguirla. È qui che Šestov edifica la sua disamina contro la morale e il moralismo, un discorso che sarà pure il contenuto dell’intera sua opera filosofica. Si domanda alla sostanza dove sia Dio nell’idea moralistica di bene, e se per caso questa morale altro non sia che cattiva fede. Il filosofo comprende che la ricerca speculativa non è tale se non trova un corrispettivo di verità nella vita degli individui, e che nessuna costruzione razionalistica può definire la vera realtà dell’esistenza umana. È ciò che ha compreso e cercato di esprimere Nietzsche, il quale, scrive Šestov, per tutta la vita cercò Dio senza mai riuscire a trovarlo, come è evidente in Al di là del bene e del male e in Così parlò Zarathustra. Siamo ancora lontani dal suo testamento filosofico, Atene e Gerusalemme, che Šestov pubblicò lo stesso anno della sua morte, nel 1938. Ma la chiusura de L’idea di bene in Tolstoj e Nietzsche già indica il percorso: «Bisogna cercare ciò che è al di sopra della compassione, ciò che è al di sopra del bene. Bisogna cercare Dio». In Atene e Gerusalemme, poi, arriverà a spiegare che ciò di cui non è mai riuscita a liberarsi la filosofia è della concezione di «necessità». Una necessità che la rendeva schiava dell’idea di bene e di male. Ma la conoscenza del bene e del male giunsero all’uomo dopo il peccato originale. Occorre cercare «al di sopra del bene»; occorre un gesto di fede per liberarsi della colpa, per liberarsi della morale.
In ogni pagina di Čechov ci sembra che un senso d’affanno, uno spezzarsi del fiato, un’angoscia di soffocamento stiano sempre a un momento dall’arpionarci. Eppure Čechov non si lamenta di nulla, si nasconde discreto dietro le parole. No, non è lui che impreca miseria e ingiustizia. Delega ai suoi personaggi ogni espressione. Li osserva, convinto di non poterli curare, di non poter curare, nonostante la scienza – lui medico, oltre che scrittore – il tumore che s’annida dentro ognuno: il terrore della morte, il senso di inadeguatezza e impotenza rispetto alla vita, l’incapacità che gli uomini hanno di comprendersi. Eppure è lì, al lume fioco di una lampada, stretto all’angolo, piegato su una sedia dietro le quinte, sempre sfuggente, con l’atteggiamento di chi pare abbia un’anima fredda, schermato da una patina di imperturbabilità. Se nessuno può nulla, sembra però dica, bisognerà pure che qualcuno si sacrifichi per l’umanità, che all’umanità sia concessa una felicità che io, Anton, osservandovi da dietro e piangendo, ma sempre senza lacrime, non posso concedermi. Che gli uomini siano felici. Ma come? Che qualcuno vi racconti, nel bene e nel male, chi siete. Nella biografia che gli dedica, La vita di Čechov – una biografia che somiglia a un romanzo attento a svelare la personalità, la sensibilità del personaggio, più che al rigore delle fonti –, Irène Némirovsky scrive che «Malgrado il desiderio dei suoi lettori e della critica, l’opera di Čechov non insegna nulla. Mai potè dire con sincerità, come faceva Tolstoj: “Agite così e non altrimenti” […]. In compenso, le sue lettere e la sua vita elevano davanti a noi l’immagine ammirevole di un uomo che, nato giusto, delicato e buono, si sforzò senza sosta di diventare migliore, più tenero, ancora più caritatevole, più affettuoso, più paziente, più sottile». Certo ci sembra che la Némirosvsky non sbagli a dire che Čechov «non insegna nulla». No, Anton non è un maestro, non ha la presunzione di pontificare, non è capace di muovere un popolo così come il conte Tolstoj, che invitava a vivere nel bene. Ma in cosa consisteva il bene proposto da Tolstoj? Mi permetto un inciso non privo di senso. Al principio del 1900, il critico trentaquattrenne di Kiev, il semisconosciuto Lev Šestov, quello che diventerà negli anni successivi uno dei maggiori filosofi e teologi del XX secolo ma che aveva allora pubblicato solo un libro dedicato a Shakespeare passato però inosservato, dà alle stampe uno studio che farà invece molto discutere, L’idea di bene in Tolstoj e Nietzsche. Tolstoj, invece, è già l’autore dei suoi capolavori: Guerra e pace e Anna Karenina. Quando Šestov propone il suo libro ad alcuni editori, c’è chi gli consiglia di non pubblicarlo, perché le accuse a Tolstoj e l’adesione alla filosofia di Nietzsche gli causeranno certo dei problemi. In verità Šestov sta definendo e gettando le basi di quella che sarà la ricerca filosofica che lo accompagnerà per tutta la vita, espressa poi in numerosi libri come Sulla bilancia di Giobbe (1929) e Kierkegaard e la filosofia esistenziale (1936). Non era cosa poco coraggiosa mettersi contro il conte Tolstoj in quel momento, se è vero che l’autore de La morte di Ivan Il’ic era allora considerato in patria una specie di profeta e che ormai rinnegava anche il suo lavoro precedente. Šestov vuole prendere di mira la sua ultima produzione, sintetizzata nel saggio Che cos’è l’arte?, un libro che, nota il filosofo, con l’arte non ha nulla a che fare. Tolstoj ha in mente esattamente questo: l’uomo deve servire il bene per poter vivere al meglio, e non importa se tale bene prestabilito e ideologicamente razionalizzato nasconda una crepa, una falla, un dubbio dentro cui lo stesso Tolstoj vive (come dimostrano le sue opere precedenti) pur decidendo di tacerlo, credendo non utile esporlo ai suoi discepoli: l’intero popolo russo. Tolstoj, di fatto, anche credendo che la sua ideologia – l’ideologia di un bene che fosse sinonimo di Dio, ma un Dio idealizzato, costruito a tavolino – fosse insufficiente a comprendere ogni cosa della vita, pensa sia necessario che gli uomini, affinché avvenga il loro riscatto sociale, più che esistenziale, debbano seguirla. È qui che Šestov edifica la sua disamina contro la morale e il moralismo, un discorso che sarà pure il contenuto dell’intera sua opera filosofica. Si domanda alla sostanza dove sia Dio nell’idea moralistica di bene, e se per caso questa morale altro non sia che cattiva fede. Il filosofo comprende che la ricerca speculativa non è tale se non trova un corrispettivo di verità nella vita degli individui, e che nessuna costruzione razionalistica può definire la vera realtà dell’esistenza umana. È ciò che ha compreso e cercato di esprimere Nietzsche, il quale, scrive Šestov, per tutta la vita cercò Dio senza mai riuscire a trovarlo, come è evidente in Al di là del bene e del male e in Così parlò Zarathustra. Siamo ancora lontani dal suo testamento filosofico, Atene e Gerusalemme, che Šestov pubblicò lo stesso anno della sua morte, nel 1938. Ma la chiusura de L’idea di bene in Tolstoj e Nietzsche già indica il percorso: «Bisogna cercare ciò che è al di sopra della compassione, ciò che è al di sopra del bene. Bisogna cercare Dio». In Atene e Gerusalemme, poi, arriverà a spiegare che ciò di cui non è mai riuscita a liberarsi la filosofia è della concezione di «necessità». Una necessità che la rendeva schiava dell’idea di bene e di male. Ma la conoscenza del bene e del male giunsero all’uomo dopo il peccato originale. Occorre cercare «al di sopra del bene»; occorre un gesto di fede per liberarsi della colpa, per liberarsi della morale.
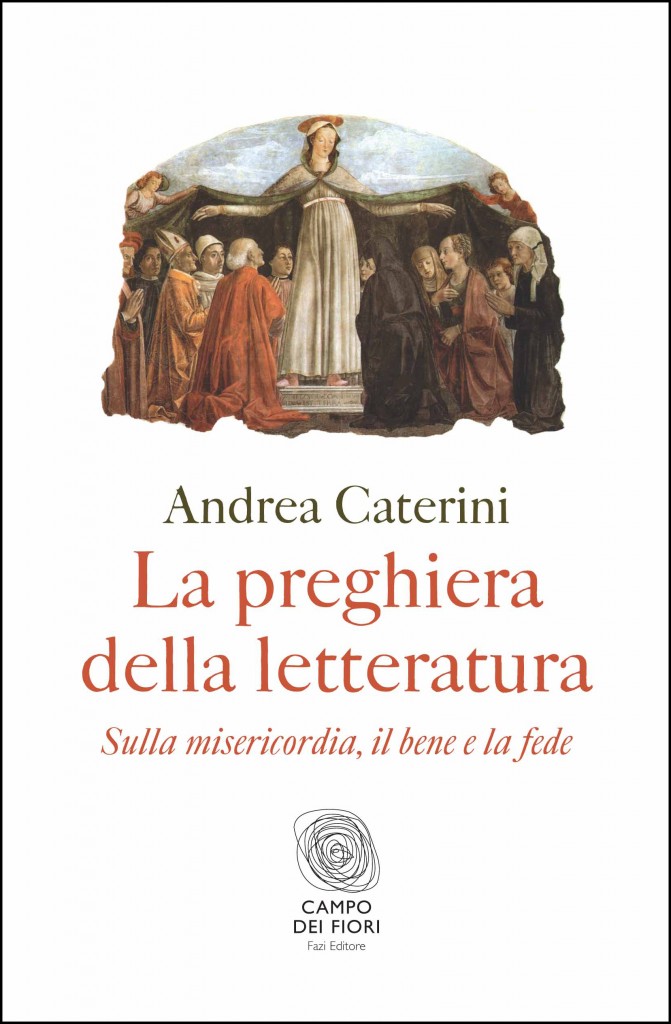 A differenza di Tolstoj, quel popolo, quegli uomini Čechov non può fare a meno di osservarli. Ne riconosce le miserie e le virtù – ma soprattutto le miserie. Perché solo riconoscendo le miserie degli altri come fossero nostre si può pensare di «diventare migliore» (e proprio di questo si parlerà più specificamente nel prossimo capitolo, dedicato alla «misericordia»). Ma appunto, il desiderio di Čechov è quello di far esprimere quelle miserie, vederle rivelate senza che la sua intercessione di autore si inserisca a decretare un giudizio ultimo sui comportamenti, sugli stati d’animo, sul modo di vivere. Dà voce a chi una voce non ce l’ha; o, pure l’avesse, non avrebbe il coraggio, o il talento, per renderla manifesta. Čechov in sostanza si sacrifica prestando la sua voce agli uomini, come aprendo uno spazio dentro se stesso per accoglierli e riconsegnare al mondo la loro vita fino a ora taciuta. La psicologia di Čechov è sottile, e forse attribuire il suo lavoro a una predisposizione psicologica è già riduttivo. Piuttosto si potrebbe parlare di una sensibilità che la sua biografia potrebbe meglio chiarire. Anton Čechov non è certo nato ricco e già a sedici anni dovette cavarsela da solo, dando ripetizioni e vendendo gli oggetti che trovava nella casa dove era nato ma che ora lo accoglieva solo come ospite (era stata venduta dai genitori a colui al quale fino a poco prima affittavano una camera) mandando soldi alla madre e ai fratelli, fino a diventare il capofamiglia (il padre – un uomo difficile, dedito all’arte e alla religione ma severo fino alla violenza – era già andato in rovina, coperto di debiti; quando scriverà il racconto Il padre, del 1887, emergerà il confronto tra un padre, ubriacone, lacrimoso e ipocrita e un figlio che parrebbe freddo, imperturbabile alla condizione del genitore ma che in realtà tace per non coprirlo di maggiore umiliazione, donandogli soldi, scarpe nuove, una compassione mai altezzosa e arrogante). Dunque il sacrificio, per Anton, è stato fin dall’infanzia e l’adolescenza un modo di vivere che aveva sviluppato nella sua persona un sentimento profondissimo che con tutta probabilità lo aveva reso intollerante all’umiliazione – lui, che di umiliazioni ne aveva subite già molte (la miseria, la povertà, le cinghiate del padre, i lamenti lacrimosi della madre, l’inconcludenza e l’inerzia dei suoi fratelli). Non la propria umiliazione – perché se si fosse trattato di un’intolleranza alla sua l’avremmo detto coperto di vanità – ma quella di chi amava. Ogni umiliazione, insomma, era per Čechov una ferita – lo feriva pure l’indifferenza degli uomini alle umiliazioni subite da altri. Per questo il sacrificio era a ben vedere una forma di pietas.
A differenza di Tolstoj, quel popolo, quegli uomini Čechov non può fare a meno di osservarli. Ne riconosce le miserie e le virtù – ma soprattutto le miserie. Perché solo riconoscendo le miserie degli altri come fossero nostre si può pensare di «diventare migliore» (e proprio di questo si parlerà più specificamente nel prossimo capitolo, dedicato alla «misericordia»). Ma appunto, il desiderio di Čechov è quello di far esprimere quelle miserie, vederle rivelate senza che la sua intercessione di autore si inserisca a decretare un giudizio ultimo sui comportamenti, sugli stati d’animo, sul modo di vivere. Dà voce a chi una voce non ce l’ha; o, pure l’avesse, non avrebbe il coraggio, o il talento, per renderla manifesta. Čechov in sostanza si sacrifica prestando la sua voce agli uomini, come aprendo uno spazio dentro se stesso per accoglierli e riconsegnare al mondo la loro vita fino a ora taciuta. La psicologia di Čechov è sottile, e forse attribuire il suo lavoro a una predisposizione psicologica è già riduttivo. Piuttosto si potrebbe parlare di una sensibilità che la sua biografia potrebbe meglio chiarire. Anton Čechov non è certo nato ricco e già a sedici anni dovette cavarsela da solo, dando ripetizioni e vendendo gli oggetti che trovava nella casa dove era nato ma che ora lo accoglieva solo come ospite (era stata venduta dai genitori a colui al quale fino a poco prima affittavano una camera) mandando soldi alla madre e ai fratelli, fino a diventare il capofamiglia (il padre – un uomo difficile, dedito all’arte e alla religione ma severo fino alla violenza – era già andato in rovina, coperto di debiti; quando scriverà il racconto Il padre, del 1887, emergerà il confronto tra un padre, ubriacone, lacrimoso e ipocrita e un figlio che parrebbe freddo, imperturbabile alla condizione del genitore ma che in realtà tace per non coprirlo di maggiore umiliazione, donandogli soldi, scarpe nuove, una compassione mai altezzosa e arrogante). Dunque il sacrificio, per Anton, è stato fin dall’infanzia e l’adolescenza un modo di vivere che aveva sviluppato nella sua persona un sentimento profondissimo che con tutta probabilità lo aveva reso intollerante all’umiliazione – lui, che di umiliazioni ne aveva subite già molte (la miseria, la povertà, le cinghiate del padre, i lamenti lacrimosi della madre, l’inconcludenza e l’inerzia dei suoi fratelli). Non la propria umiliazione – perché se si fosse trattato di un’intolleranza alla sua l’avremmo detto coperto di vanità – ma quella di chi amava. Ogni umiliazione, insomma, era per Čechov una ferita – lo feriva pure l’indifferenza degli uomini alle umiliazioni subite da altri. Per questo il sacrificio era a ben vedere una forma di pietas.
2.
Una parentesi cinematografica. John May deve aver letto a fondo Čechov, finendo per imitare non già i personaggi del russo ma il carattere sottile e misericordioso dello scrittore. Uberto Pasolini, regista e sceneggiatore di Still life (2013) – il film più umano del mondo –, definendo la sensibilità di May, un impiegato comunale impegnato a cercare parenti e amici che possano accompagnare quei morti che pare non abbiano più nessuno al mondo che li pianga e che preghi un’ultima volta per loro, ha compreso che per descrivere un uomo straordinario necessitava di scarni mezzi, ma di una sensibilità profondissima.
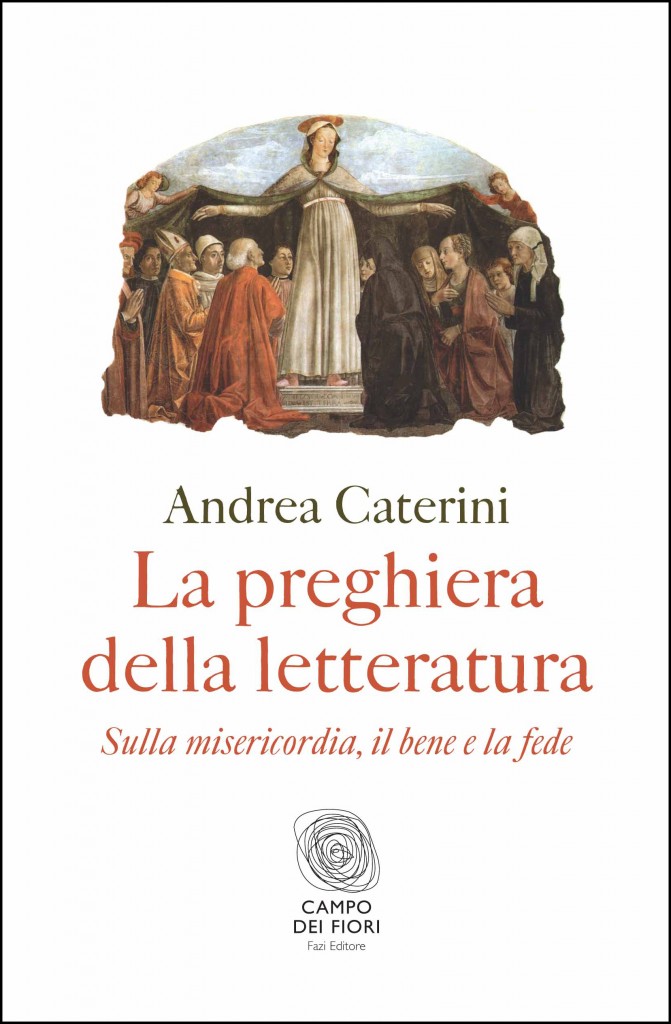 Perché May ha capito, insieme a Čechov, che anche nell’uomo più miserabile, anche nell’umanità più sudicia e corrotta non tutto può essere coperto di male. Ogni uomo deve necessariamente aver mantenuto e restituito un briciolo di bene sufficiente\ da meritarsi qualcuno accanto che lo ha conosciuto e lo ha amato, nel giorno in cui il corpo cade, a donargli un ultimo saluto, l’ultimo abbraccio, sussurrare per lui una preghiera. E se non c’è più nessuno è May stesso a salutare quei morti, come fosse l’uomo che più li ha amati, che meglio li ha conosciuti. Entra nelle loro case, raccoglie i loro oggetti personali – una collana di perle, un rossetto rosso –, qualche foto sbiadita, le lettere scritte e ricevute e dedica loro un’omelia reinventando la loro vita. Pure quando trova la figlia di Stoke, Kelly, la ragazza che potrebbe diventare la sua compagna, se May non morisse il giorno prima di incontrarla al funerale del padre investito da un autobus, John le lascia in eredità una famiglia, facendola incontrare con una donna che fu un’altra compagna del padre e la sua sorellastra. May è grande – già un santo –, si sacrifica per un’intera umanità desolata e sola, per donargli una possibilità di gioia. May è colui che consegna all’uomo la felicità, offrendosi per intero: la sua fratellanza, la sua misericordia.
Perché May ha capito, insieme a Čechov, che anche nell’uomo più miserabile, anche nell’umanità più sudicia e corrotta non tutto può essere coperto di male. Ogni uomo deve necessariamente aver mantenuto e restituito un briciolo di bene sufficiente\ da meritarsi qualcuno accanto che lo ha conosciuto e lo ha amato, nel giorno in cui il corpo cade, a donargli un ultimo saluto, l’ultimo abbraccio, sussurrare per lui una preghiera. E se non c’è più nessuno è May stesso a salutare quei morti, come fosse l’uomo che più li ha amati, che meglio li ha conosciuti. Entra nelle loro case, raccoglie i loro oggetti personali – una collana di perle, un rossetto rosso –, qualche foto sbiadita, le lettere scritte e ricevute e dedica loro un’omelia reinventando la loro vita. Pure quando trova la figlia di Stoke, Kelly, la ragazza che potrebbe diventare la sua compagna, se May non morisse il giorno prima di incontrarla al funerale del padre investito da un autobus, John le lascia in eredità una famiglia, facendola incontrare con una donna che fu un’altra compagna del padre e la sua sorellastra. May è grande – già un santo –, si sacrifica per un’intera umanità desolata e sola, per donargli una possibilità di gioia. May è colui che consegna all’uomo la felicità, offrendosi per intero: la sua fratellanza, la sua misericordia.
3.
In una pagina meravigliosa di Vita e destino di Vasilj Grossman, il romanzo epopea sulla battaglia di Stalingrado, uno degli ultimi capolavori del Novecento, troviamo, in un dialogo sulla letteratura, parole vere su Čechov che vale la pena citare
«[…] Čechov ha portato nel nostro immaginario tutta la Russia nella sua impotenza, tutte le sue classi, tutti i ceti sociali e le età… Ma non solo! Ce li ha portati tutti, milioni e milioni, democraticamente, lo capite? Da autentico democratico russo! E come nessuno aveva fatto prima di lui, nemmeno Tolstoj, ha detto: siamo prima di tutto esseri umani, lo capite?, esseri umani, uomini, persone! Lo ha detto come nessuno aveva mai fatto prima. Ha detto che l’importante è che gli uomini siano prima di tutto uomini, e solo poi arcipreti, russi, bottegai, tatari, operai. Lo capite? Non siamo buoni o cattivi perché siamo arcipreti o operai, tatari o ucraini. Siamo tutti uguali perché siamo tutti esseri umani. […]. Čechov ha detto: Dio si faccia da parte e si facciano da parte le cosiddette grandi idee progressiste. Partiamo dall’uomo, mostriamogli bontà e attenzioni chiunque egli sia, arciprete, contadino, industriale milionario, forzato di Sachalin, cameriere in un ristorante. Iniziamo compatendo, amando l’uomo, altrimenti non ne verrà nulla. È questa, la democrazia, la democrazia mai nata del popolo russo.»
Si prenda un racconto pubblicato nel 1888, La voglia di dormire. Una serva di tredici anni è costretta a lavorare per i suoi padroni notte e giorno. La notte poi, il neonato figlio dei padroni, al quale la ragazza fa da balia, cantandogli una ninna nanna e dondolandolo nella culla, continua a piangere e gridare non lasciandola dormire neppure per un attimo. Improvvisamente, presa da allucinazioni da sonno e stanchezza, Vàrka rivede le cose che la legano alla vita, «lo stradone fangoso, la gente con le bisacce, suo padre Efìm». Ma c’è una forza che la soffoca e la costringe alla schiavitù, ed è appunto quel bambino. Vàrka lo uccide soffocandolo e finalmente si addormenta felice. È un racconto fulminante, di una manciata di pagine, nel quale Čechov restituisce ogni tensione, umana e sociale. La relazione servo-padroni, l’angoscia individuale. Eppure, ciò che colpisce ogni volta nelle narrazioni di Čechov è il momento in cui i suoi personaggi improvvisamente raggiungono un apice che li porta alla lucidità, quello in cui si accorgono di chi sono o di cosa hanno fatto (come esempio, si pensi alla maestra di scuola Màrja Vasìlevna del racconto breve In carretta, del 1897: «E al vivo, allora, con impressionante limpidezza, per la prima volta in tutto il corso di questi tredici anni, vennero a prospettarlesi la mamma, il padre, il fratello, il loro appartamento a Mosca, l’acquario con quei pesciolini, tutto fino ai minimi particolari; improvvisamente le risonò il suono del pianoforte, la voce del padre, e si sentì, come a quei tempi, giovane, bella, ben vestita, in una luminosa, tepida stanza, nel circolo dei suoi cari; un’impressione di gioia e felicità la sopraffece d’un tratto, tanto che, dall’esultanza, si strinse le tempie fra le mani e le sfuggì di bocca, con tenerezza, supplichevolmente: – Mammina!»; o ancora a Il maestro, del 1886: «– Noi sappiamo apprezzare il merito – continuò il signor Bruni, prendendo un’espressione di serietà e abbassando la voce. – […] la famiglia di Fjòd Lukìč avrà l’avvenire assicurato […] –. Sysòjev, con gli occhi interroganti, sogguardò il tedesco, poi i colleghi, immerso in una specie di sconcerto: perché l’avvenire sarebbe stato assicurato alla famiglia, e non a lui stesso? […] Col viso sbiancato, sfigurato da una smorfia, d’improvviso balzò in piedi e si afferrò fra le mani la testa. Una decina di secondi rimase a quel modo, fissando innanzi a sé, con orrore, sempre in un punto, come se là si scorgesse di fronte questa morte imminente, a cui aveva accennato il Bruni; poi risedette, e scoppiò in lacrime.»; e impossibile non pensare al risveglio del direttore della clinica psichiatrica del racconto più celebre di Čechov, Il reparto n. 6 [1892], Andrèj Efìmyč Ràghin, il quale, spezzate le catene dell’ordinario, lo stesso ordinario di cui fino a poco prima era partecipe e responsabile, si trova ad essere schiacciato e accusato da un sistema che non è più in grado di accoglierlo e comprenderlo, chiudendolo e lasciandolo morire – per una legge del contrappasso – nella stessa sua clinica: «Ormai tutto, perfino il sincero interessamento dei miei amici, cospira a un sol fine: alla mia rovina. Io sto precipitando nell’abisso, e ho la virilità di rendermene conto.»). Una lucidità che gli fa compiere anche il gesto più terribile. Scrive di Vàrka: «Tutto le riesce comprensibile, tutti riconosce». Per Čechov ogni uomo riconosce se stesso nel momento in cui rivede – «riconosce» – il luogo da cui proviene. Quel luogo è certo un contenitore di memoria, una memoria che molto spesso ci è dato di conoscere attraverso i pochissimi tratti che lo scrittore ci restituisce. Ma quel luogo è anche un momento di riconciliazione. Un riconciliazione che certo non giustifica alcun omicidio, come quello di Vàrka. Eppure, la ragazza, scrive Čechov, osservandola dormire profondamente dopo aver ucciso il bambino, è «come morta» (queste le ultime due parole del racconto). Allora, se la ragazza si è liberata da quel senso di soffocamento che era il bambino riconciliandosi con i luoghi della sua vita, è vero pure che quella lucidità visiva che l’ha spinta all’omicidio, l’ha al contempo uccisa. Uccidendo il bambino Vàrka si è uccisa. Ma Čechov cosa pensa del gesto della ragazza, cosa della violenza dei padroni? Come sempre ogni giudizio morale è escluso dalla narrazione. È come se Čechov, scriveva a ragione Natalia Ginzburg introducendo il suo epistolario, Vita attraverso le lettere, «di colpo spalanchi una finestra o una porta: offrire così al lettore i tratti d’una figura umana, o di un gruppo di figure umane, farne udire il suono delle voci, darne a intuire i vari stati d’animo, il servilismo o il sussiego, la pazienza o la prepotenza, e poi di colpo richiudere quella porta o quella finestra dinanzi al lettore assorto, divertito e stupefatto». Ma appunto, se non c’è un giudizio morale, non significa certo che Čechov ne fosse sprovvisto. È vero invece il contrario. Il racconto, aprendo una finestra su uno spicchio di mondo, è un concentrato di attenzione. Cioè, tutto ciò che avviene, ogni sentimento umano espresso sulla pagina attraverso la vita dei personaggi, restituisce già un giudizio sul mondo e su ogni uomo che lo abita. Voglio dire che Čechov è fermamente convinto che sia la vita stessa a giudicare i nostri comportamenti, le nostre azioni, i nostri sentimenti di pietà o di odio, di misericordia o di invidia. La vita stessa è insomma un giudizio che mette alla prova, che interroga ogni individuo. Con questo non si pensi che la scrittura di Čechov sia nulla di più di una testimonianza. I suoi racconti non sono mai referti, o didascaliche descrizioni. Čechov, raccontando, non solo ha visto l’uomo nella sua interezza, ma lo ha accolto per intero; per questo Grossman poteva scrivere di lui: «Partiamo dall’uomo, mostriamogli bontà e attenzioni chiunque egli sia». Il sacrificio non consiste in altro che in questa capacità d’accoglimento dell’altro per cui sono necessarie «bontà e attenzione». Ma Čechov non sacrifica nulla a una divinità per ottenere, da quella stessa divinità, una grazia. Certo la sua scrittura è in tutto e per tutto un atto sacro. Ma se non c’è un oggetto o un corpo estraneo da donare a una divinità, è a se stessi che si rinuncia, è il proprio corpo che viene sacrificato – divenuto sacro perché donato all’umanità intera. Ma, l’abbiamo detto, sacrificando se stesso Čechov accoglie ogni uomo. Se il sacrificio è quindi un dono, è vero pure che nello stesso tempo è una riconciliazione, un ritorno all’unità. Čechov mentre scrive ha un corpo sacro perché riconcilia se stesso e l’intera umanità a un’origine che tutti accomuna in un’unità (a questo facevo riferimento all’inizio del capitolo, connettendo pace, creazione e sacrificio). Quell’origine è la vita di ognuno, è una nascita alla quale ogni uomo, pur nella miseria di ogni esistenza, tende, vuole ritornare. Čechov, sacrificando il suo corpo, permette di rendere sacra la vita di ognuno. Perché ogni uomo, come ha capito Jonh May, ha conservato un bene che è nostro compito riconoscere e restituire come la traccia del nostro passaggio sulla terra, come memoria della nostra primordiale ferita: la nostra nascita. Perché quel bene residuo è ciò che nessuno potrà mai strapparci via.
(Riproduzione riservata)
© Andrea Caterini – Fazi editore
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo





