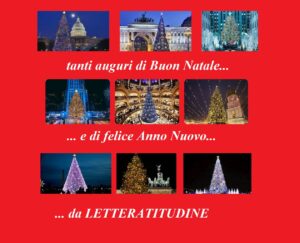Nel proposito di beffeggiare e irridere i libri di cavalleria, Cervantes ne rilanciò in realtà il gusto sostenendone anche il successo a teatro, dove l’epopea dei cavalieri erranti riebbe nel Seicento vigore soprattutto in Spagna. Contrario a quella vena letteraria che dal dodicesimo secolo e almeno per quattro secoli fino all’Orlando furioso aveva soggiogato il pubblico europeo con uno smisurato profluvio di opere su celate e velate, Cervantes si rivelò piuttosto il più accanito lettore del genere post-stilnovistico in un’epoca in cui quella svenevolezza per la cavalleria medievale era però cessata e da almeno centocinquant’anni non si vedevano cavalieri armati e ancor meno erranti: ciò dopo la diffusione delle armi da fuoco il cui uso in battaglia metteva fine al coraggio e all’ardore del singolo combattente, tale che don Chisciotte, come lo stesso Orlando ariostesco, trova che possa essere abbattuto anche da una palla sparata da un codardo e biasima il proprio tempo per «la spaventevole furia di queste indemoniate macchine dell’artiglieria».
Occorre partire da qui per guardare alle suggestioni del Don Chisciotte: il cavaliere “dalla Triste figura”, poi ribattezzato “dei Leoni”, che depreca il presente e si vanta di aver riportato in vita «l’esercizio della cavalleria di ventura ormai dimenticato» e il suo autore che condanna il lungo passato credulo e ingenuo ma dà un’opera che infiamma il tempo in cui vive proprio della seduzione per un genere letterario che con lui risorge anziché tramontare. Tuttavia il trasporto di Cervantes per le storie di fantasia, picaresche e di cappa e spada, non è tanto rivolto a un genere quanto alla letteratura in sé nel cui spirito parteggia dunque per le ragioni di don Chisciotte che, rendendo vera e reale l’epica romanzesca, si dichiara convinto della storicità dei cavalieri erranti esaltati nei libri di cavalleria e perciò della verità della letteratura. In un vertiginoso gioco combinatorio, in sostanza, Cervantes dà credito e fondamento alla letteratura, come mimesi aristotelica e fonte di riproduzione della realtà, immaginando un personaggio convinto dell’esistenza dei cavalieri romanzeschi di ventura, da Lancillotto ad Amadigi di Gaula, e quindi pazzo: di quella pazzia che è però epifanica della verità.
 Naturalmente Cervantes gioca quando insistentemente tiene a ricordare che sta raccontando una storia non solo grande ma anche veritiera, epperò costruisce la falotica impresa dell’hidalgo della Mancia secondo un procedimento che dalla fantasia va alla realtà: via via che gli episodi si succedono perdono infatti, molto più nella seconda parte, il fondo di irrealtà e il senso dell’assurdo che li forbiscono per acquisire verosimiglianza e tangibilità finché il cavaliere dei Leoni non rinsavisce e torna a essere Alonso Chisciano il Buono dismettendo del tutto la taccia del funambolico eroe a cavallo e lancia in resta. E allora, adottando la distinzione proposta da uno dei massimi cervantisti, Martin de Riquer, secondo cui un conto sono i libri di cavalleria, ispirati a un criterio di astrazione di luoghi e tempi, con meraviglie, incantesimi e magie, frutto della cosiddetta “materia di Bretagna”, e un altro conto sono i romanzi cavallereschi, più aderenti ai fatti reali, ai costumi sociali e privi di fughe verso l’immaginifico (la stessa differenza che la classicità faceva tra tragedia e commedia), il Don Chisciotte comincia come un libro di cavalleria e termina come un romanzo cavalleresco, facendo alla fine pensare che Cervantes voglia proprio il romanzo di denuncia: non tanto della vieta e corriva passione collettiva per la letteratura cavalleresca, oltretutto démodé – passione innanzitutto sua, perché li conosce tutti e bene i libri che il curato e il barbiere danno alle fiamme – quanto di alcune questioni che stanno a cuore alla coscienza spagnola e di cui si fa egli interprete quando nel 1614 scrive la seconda parte, nove anni dopo la pubblicazione della prima: il fenomeno del banditismo catalano, composto anche da gasconi e legato agli ugonotti francesi, e la minaccia turca.
Naturalmente Cervantes gioca quando insistentemente tiene a ricordare che sta raccontando una storia non solo grande ma anche veritiera, epperò costruisce la falotica impresa dell’hidalgo della Mancia secondo un procedimento che dalla fantasia va alla realtà: via via che gli episodi si succedono perdono infatti, molto più nella seconda parte, il fondo di irrealtà e il senso dell’assurdo che li forbiscono per acquisire verosimiglianza e tangibilità finché il cavaliere dei Leoni non rinsavisce e torna a essere Alonso Chisciano il Buono dismettendo del tutto la taccia del funambolico eroe a cavallo e lancia in resta. E allora, adottando la distinzione proposta da uno dei massimi cervantisti, Martin de Riquer, secondo cui un conto sono i libri di cavalleria, ispirati a un criterio di astrazione di luoghi e tempi, con meraviglie, incantesimi e magie, frutto della cosiddetta “materia di Bretagna”, e un altro conto sono i romanzi cavallereschi, più aderenti ai fatti reali, ai costumi sociali e privi di fughe verso l’immaginifico (la stessa differenza che la classicità faceva tra tragedia e commedia), il Don Chisciotte comincia come un libro di cavalleria e termina come un romanzo cavalleresco, facendo alla fine pensare che Cervantes voglia proprio il romanzo di denuncia: non tanto della vieta e corriva passione collettiva per la letteratura cavalleresca, oltretutto démodé – passione innanzitutto sua, perché li conosce tutti e bene i libri che il curato e il barbiere danno alle fiamme – quanto di alcune questioni che stanno a cuore alla coscienza spagnola e di cui si fa egli interprete quando nel 1614 scrive la seconda parte, nove anni dopo la pubblicazione della prima: il fenomeno del banditismo catalano, composto anche da gasconi e legato agli ugonotti francesi, e la minaccia turca.
Tutto lo scenario diventa di colpo reale: don Chisciotte va a Barcellona (su salvacondotto di un vero bandito conosciuto in vita e riportato nel romanzo) perché è lì che imperversa l’insorgenza criminale ed è attesa la flotta mora, proprio dove il cavaliere finisce di inseguire i suoi fantasmi e deve scontrarsi con la realtà. Sennonché Cervantes lo fa uscire di scena in occasione della battaglia navale, così come nella prima parte ha avuto sempre motivo per allontanarlo dai convivi creati per ascoltare e raccontare storie serie e anche drammatiche, mandandolo magari a dormire o a montare la guardia. L’autore non vuole infatti che il suo eroe diventi mai reale e perda la sua carica farsesca e grottesca non facendo più ridere: quindi lo isola ed estranea; ma non vuole neppure che il suo romanzo tenga sempre il tono del comico, per modo che fa morire don Chisciotte una volta riacquistato il senno: non solo perché un altro Avellaneda non riprenda il personaggio e ne continui a raccontare le gesta, sia pure apocrife, ma anche perché un Alonso il Buono restituito al mondo che non legga più libri di cavalleria non può tornare in groppa a un Ronzinante e andare in giro a raddrizzare torti e divertire villaggi e lettori, giacché non è contro la cavalleria come ordine nobiliare in sé che Cervantes polemizza ma sono i libri di cavalleria che lo tengono in fazione, cosicché il canonico può sostenere che non si tratta che di “favole milesie”, racconti stravaganti buoni per divertirsi e non per imparare com’è nel caso dei racconti apologhi, cioè dei romanzi storici.
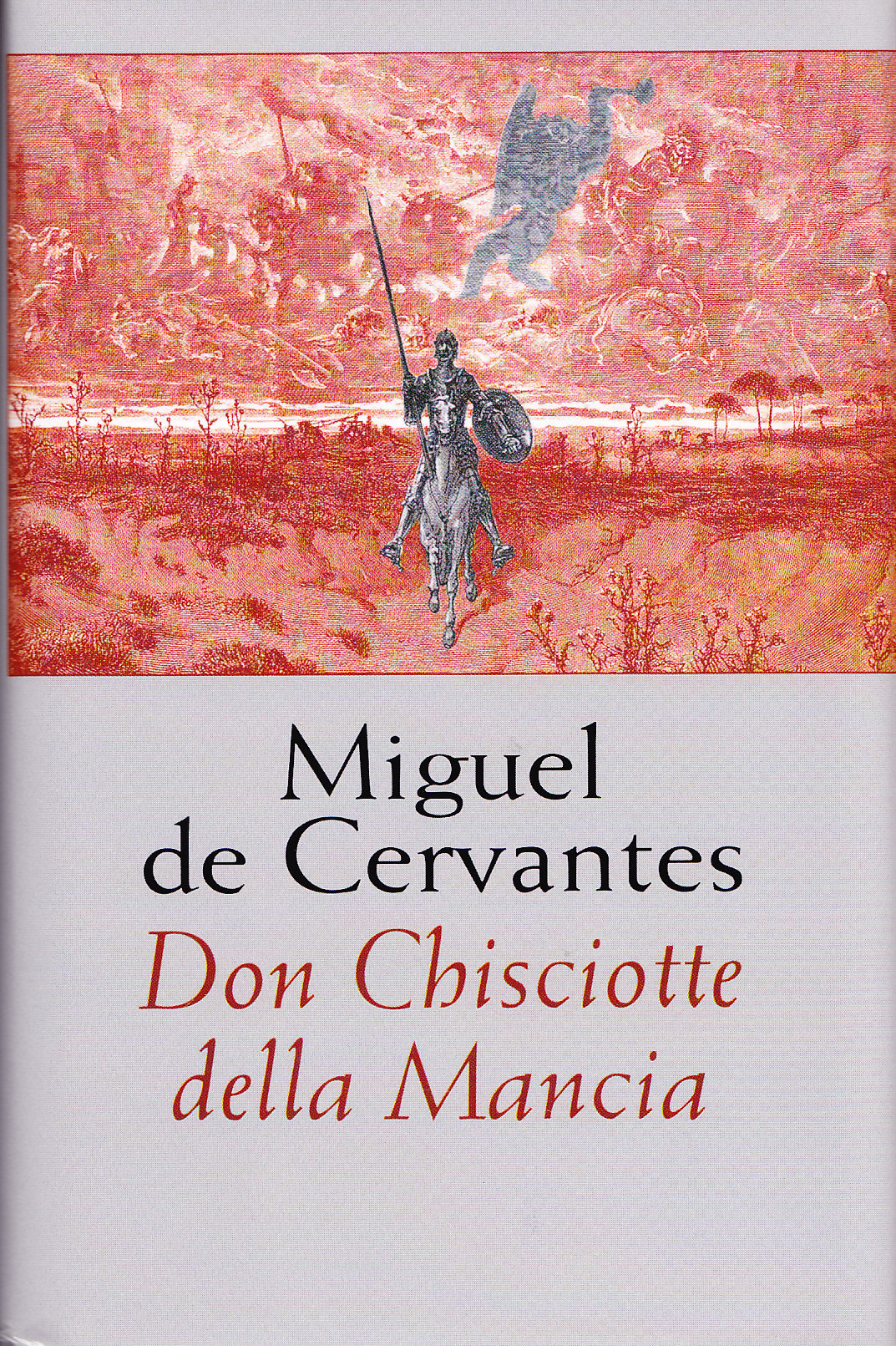 Pur di imprimere al suo romanzo un andamento dunque progressivamente realistico, Cervantes non esita a introdurre una delle più vistose contraddizioni (peraltro disseminate in abbondanza in tutta l’opera: famoso il caso dell’asino di Sancho Panza che scompare e poi ricompare, motivo sul quale lo stesso autore trova motivo per scherzare nel secondo tomo) laddove da un lato immagina che la terza uscita di don Chisciotte che occupa l’intero secondo tomo si abbia dopo un mese di riposo mentre da un altro riporta circostanze e date che comprovano come siano trascorsi quasi dieci anni: quando vuole che la prima parte sia stata letta, come in realtà è avvenuto, in tutta la Spagna, cosa impossibile in trenta giorni, e quando in calce alla lettera di Sancho alla moglie appone la data del 20 luglio 1614, così da tenersi aderente ai fatti di maggior momento politico e sociale che più lo interessano. Partito dunque per divertire, Miguel de Cervantes non si diverte più dopo che don Chisciotte e Sancho lasciano i duchi e intraprendono la via della realtà sulla quale la figura del cavaliere errante diventa sempre più evanescente fino a lasciare la scena alla storia vera e ritirarsi. Il romanzo è finito da duecento pagine, o almeno è finito il libro di cavalleria, che si è andato mutando piuttosto in un romanzo cavalleresco, ma senza più il suo cavaliere a fare da protagonista, perché messo definitivamente da parte quando le battaglie sono vere e il sangue scorre reale.
Pur di imprimere al suo romanzo un andamento dunque progressivamente realistico, Cervantes non esita a introdurre una delle più vistose contraddizioni (peraltro disseminate in abbondanza in tutta l’opera: famoso il caso dell’asino di Sancho Panza che scompare e poi ricompare, motivo sul quale lo stesso autore trova motivo per scherzare nel secondo tomo) laddove da un lato immagina che la terza uscita di don Chisciotte che occupa l’intero secondo tomo si abbia dopo un mese di riposo mentre da un altro riporta circostanze e date che comprovano come siano trascorsi quasi dieci anni: quando vuole che la prima parte sia stata letta, come in realtà è avvenuto, in tutta la Spagna, cosa impossibile in trenta giorni, e quando in calce alla lettera di Sancho alla moglie appone la data del 20 luglio 1614, così da tenersi aderente ai fatti di maggior momento politico e sociale che più lo interessano. Partito dunque per divertire, Miguel de Cervantes non si diverte più dopo che don Chisciotte e Sancho lasciano i duchi e intraprendono la via della realtà sulla quale la figura del cavaliere errante diventa sempre più evanescente fino a lasciare la scena alla storia vera e ritirarsi. Il romanzo è finito da duecento pagine, o almeno è finito il libro di cavalleria, che si è andato mutando piuttosto in un romanzo cavalleresco, ma senza più il suo cavaliere a fare da protagonista, perché messo definitivamente da parte quando le battaglie sono vere e il sangue scorre reale.
Cervantes può fare quel che gli pare della sua creatura perché don Chisciotte, pur essendo accostabile agli altri cavalieri da romanzo dell’epica medievale, anzi detenendo tra essi ancora oggi una posizione di assoluto rilievo, non fa parte della tradizione iconografica alla quale ogni autore poteva attingere per riplasmare a piacimento i vari eroi, da Artù a Merlino, ma appartiene al suo unico autore: che a buon motivo si decide a scrivere la seconda parte, pur malato e in gravi condizioni di povertà, dopo aver visto che il suo cavaliere è stato riportato in attività da Avellaneda come fosse stato un mito greco. Ma attenzione: non è un arbitrio quello che Cervantes si prende imprimendo al romanzo una direzione verso la realtà contro la linea dell’Ariosto intesa a cantare «le donne, i cavalier, l’arme e gli amori», non dunque la storia ufficiale e prorompente ma quella minima ed estenuata. Come ha notato il più grande, insieme con Jorge Luis Borges, esegeta cervantino, Miguel de Unamuno, autore della Vita di don Chisciotte e Sancho Panza (libro oltremodo appassionato che sin dal titolo dà come per vere e realmente esistite le due figure), la follia individuale finisce di essere tale quando diventa collettiva e cioè si addice a costituire una regola di costume o di legge. Sicché cosa fa Cervantes? Relega nell’ombra don Chisciotte negandogli avventure e pazzie mentre sulla ribalta porta gli eventi del suo tempo, facendosi portatore delle preoccupazioni dei suoi contemporanei per le follie della storia: dalla pirateria alla cacciata dei mori, dal banditismo alla Mezzaluna incombente ai fantasmi di Lepanto.
E occorre che sulla follia, tema portante del romanzo che inaugura la narrativa moderna europea riprendendolo dai versi ariosteschi, sia fatta ancora più attenzione, perché don Chisciotte è sì pazzo, ma non sciocco, dal momento che quanto dice è «coerente, elegante e ben esposto» mentre è ciò che fa che appare «assurdo, temerario e stupido». Con la sagace precisazione che «il personaggio più intelligente in una commedia è quello dello sciocco perché non può esserlo colui che deve far credere di esserlo».
Cervantes prende tanto sul serio don Chisciotte da far sì che col tempo, di avventura in avventura, anche Sancho si chisciottizzi, manifestando arguzia e stoltezza nonché mostrandosi nella specie di quel tipo di follia della quale, osserva Unamuno, anche Gesù fu bollato come folle dalla madre e dai fratelli che dissero «E’ fuor di sé» vedendolo tra la folla compiere stravaganze, che in realtà erano prodigi: a significare che sono i più vicini, compresi i familiari, a vedere la pazzia in quanti non osservano la maggioranza dei comportamenti.
Saggio pazzo o pazzo che tira a fare il saggio, come lo vede Sancho, l’hidalgo diventa trasposizione di Cervantes quando per esempio parla, sia pure con una punta antifrastica, ai cavalieri della locanda e ai caprai del primato delle armi sulle lettere ma si fa poi suo misirizzi quando prende un bacile per l’elmo di Mambrino e vede eserciti di mori nelle mandrie. Non c’è figura da romanzo più irreale e nello stesso tempo reale, una bipolarità questa che ne ha segnato l’eterna fortuna, perché molto richiama la personalità comune e ricava forza dall’uso eccessivo di un certo tipo di lettura fantastica ma fatta per essere creduta vera, come la ritiene anche l’oste quando al curato fornisce la prova del loro fondamento storico data dal fatto che tutti i libri di cavalleria erano stati pubblicati su autorizzazione delle autorità statali.
È perciò l’eterogeneità dei libri, il loro mistero, a determinare la salute mentale, sia individuale che collettiva. Il Don Chisciotte arriva tra l’Orlando furioso e La tempesta di Shakespeare, a cavallo di due secoli nei quali il libro, soprattutto finzionale, è visto come una oscura minaccia e un oggetto misterioso. Nel poema italiano del Cinquecento Bradamante affronta Atlante e gli strappa il libro con il quale lui la colpisce leggendone dei brani e suscitando in lei la meraviglia che possa costituire un’arma; nel dramma seicentesco inglese alla meraviglia si è sostituita la certezza circa la forza del libro: Calibano esorta a strappare di mano a Prospero il libro per privarlo dei suoi poteri. In mezzo c’è Don Chisciotte, perlomeno il tomo del 1605, dove il libro è motivo di disputa circa i suoi effetti: che sono quelli riscontrati nel cavaliere della Mancia, ora del tutto folle e ora uomo di grande acume intellettivo.
Per don Chisciotte il libro di cavalleria è “il solito rimedio” cui ricorrere di fronte a una decisione da prendere, ovvero un manuale di comportamento con tutte le risposte sulla vita. Che Cervantes conosce benissimo per averle anche lui lette, esattamente come don Chisciotte. Ma, per non apparire nella stessa veste, escogita una trovata molto in uso nel suo tempo, quella del manoscritto ritrovato. Al culmine del primo duello cavalleresco del suo cavaliere mancego con il biscaglino della signora della carrozza, Cervantes si ferma e rivela che tutta la storia dell’ingegnoso hidalgo l’ha letta in una traduzione dall’arabo commissionata a un volenteroso moro convertito dopo aver acquistato da un ragazzino tutti i fogli che narravano le imprese di don Chisciotte scritte dall’arabo Cite Hamete Benengeli. Da quel momento in poi il romanzo arabo tradotto in castigliano diventa una epitome a opera di Cervantes, che così può attribuire a Benengeli la passione per i libri di cavalleria che ha letto in abbondanza come don Chisciotte. Un infingimento, è chiaro, che ogni tanto Cervantes però dimentica riportando quanto legge in traduzione, dove è davvero implausibile che il “vero autore” si esprima in termini dispregiativi nei confronti dell’islam, scrivendo in celia di «una storia non più vera dei miracoli di Maometto» o «del precetto del suo falso profeta Maometto» o ancora parlando del «nostro don Chisciotte», né è credibile che Benengeli immagini che una musulmana ricca come Zoraida voglia lasciare la terra dei mori per andare in Occidente e farsi cristiana.
Zoraida è una delle tante figure che, come Carminio, Anselmo, Lotario, Camilla, Fernando, Marcela, Crisostomo e tante altre, sfiorano don Chisciotte che perlopiù è loro estraneo perché le loro storie non sono ridanciane e rispondono a una tecnica che, mutuata da Boccaccio, nella seconda parte viene tuttavia abbandonata perché il protagonista assoluto non lasci mai la scena, se non alla fine. Si tratta di storie che formano novelle probabilmente già scritte dall’autore e qui riportate in una sorta di mise en abyme che vuole celebrare l’amore travagliato e le sue pene, giacché si assomigliano tutte fino a ripetersi come anche a ritrovarsi, giusto il fatto che quasi tutte le coppie finalmente rappacificate e unite dopo le tribolazioni si incontrano in una locanda che è un po’ il palcoscenico centrale dell’intera rappresentazione e dove capita anche don Chisciotte per dichiararsi cavalier servente a una delle donzelle vista come una regina e in vena di farsi beffe di lui. Il quale dal canto suo mai si prende gioco degli altri, ma lo fa di sé.
Succede quando ride per la prima e unica volta: Sancho Panza, al momento di assumere l’attributo di “cavaliere dalla triste figura”, coniato dal «sapiente che ha il compito – dice l’hidalgo – di scrivere la storia delle mie imprese», ovvero Benengeli in astratto, gli dice che basta la sua faccia per identificarlo, non occorrendo disegnarne sullo scudo il simbolo, ed egli si lascia andare a una risata divertita. Può mai essere stupida una persona dotata di tanta autoironia? Ma soprattutto: un uomo che ad ogni sconfitta si rifugia nei libri può essere considerato folle? Tale non lo ritenne Unamuno che lanciò come un papa una santa crociata per la liberazione del sepolcro di don Chisciotte. Che è sempre stato libero invero e lo vediamo ogni giorno in mille persone che incontriamo e molte volte guardandoci allo specchio.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
[è appena uscito il nuovo romanzo di Gianni Bonina: “Ammatula” (Castelvecchi) – di recente in libreria anche il volume: “Fatti di mafia” (Theoria)]
* * *
[Tutte le puntate di Leggerenza sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo