Dopo l’esperienza fatta dieci anni prima come baleniere, Herman Melville scrive Moby Dick perché scopre – e lo precisa nel romanzo – che la caccia ai cetacei ne minaccia l’estinzione, sebbene a metà dell’Ottocento l’illuminazione pubblica e domestica vada sempre più servendosi non più dell’olio di balena ma del gas e presto a New York arriverà anche l’elettricità: ma specifica che la balena “non avrà una fine ingloriosa come i bufali dell’Illinois e del Missouri”, essendo essa immortale. Deificando così quello che pure molte volte chiama “mostro” e “Leviatano”, Melville lascia supporre che il suo capolavoro (tale verrà considerato però solo nel Novecento giacché all’uscita non riscuote il successo di Taipi e delude il mercato americano e inglese) nasca nell’intento non tanto di ricordare la disgrazia nel 1820 dell’Essex, affondato da un capodoglio, quanto soprattutto di affermare il primato della balena sull’uomo con l’esaltarne lo spirito di specie e dotandola di un’intelligenza non diversa da quella dei suoi cacciatori, se non maggiore.
 Era per esempio opinione anche di Melville, ignaro del sonar naturale di cui è dotata sulla testa, che la balena andasse affrontata frontalmente perché cieca avendo gli occhi molto distanti sui fianchi. E nella sua particolareggiata notomizzazione di ogni cetaceo descrive anche gli occhi (argomentando ingenuamente che è per l’impossibilità di vedere nello stesso momento due oggetti che la balena cade nel panico e si confonde), ma è poi costretto a lasciare senza spiegazione la circostanza per cui Moby Dick attacca proprio con la testa la nave colpendola nella prua, lasciandone semmai implicitamente immaginare la grande intelligenza. Qualità alla quale l’opinione pubblica in realtà si rifiuta di credere, tanto che il primo ufficiale Startbuck rimprovera al comandante l’infondatezza della sua vendetta contro “un bruto senza parola che ti ha colpito semplicemente per l’istinto più cieco! Pazzia! Essere adirato con una cosa muta! Sembra una bestemmia!”. Ma la ferocia, l’astuzia e la malignità mostrate nei secoli dal capodoglio rispetto alla balena, costate la vita a moltissimi marinai, sono le proprietà naturali che convincono Melville a supporre una capacità raziocinante nell’essere vivente più grande del mondo. Di qui un romanzo che è una sfida sul filo della volontà che si serve della forza, perciò con tutti gli ingredienti per riuscire emozionante e avvincente.
Era per esempio opinione anche di Melville, ignaro del sonar naturale di cui è dotata sulla testa, che la balena andasse affrontata frontalmente perché cieca avendo gli occhi molto distanti sui fianchi. E nella sua particolareggiata notomizzazione di ogni cetaceo descrive anche gli occhi (argomentando ingenuamente che è per l’impossibilità di vedere nello stesso momento due oggetti che la balena cade nel panico e si confonde), ma è poi costretto a lasciare senza spiegazione la circostanza per cui Moby Dick attacca proprio con la testa la nave colpendola nella prua, lasciandone semmai implicitamente immaginare la grande intelligenza. Qualità alla quale l’opinione pubblica in realtà si rifiuta di credere, tanto che il primo ufficiale Startbuck rimprovera al comandante l’infondatezza della sua vendetta contro “un bruto senza parola che ti ha colpito semplicemente per l’istinto più cieco! Pazzia! Essere adirato con una cosa muta! Sembra una bestemmia!”. Ma la ferocia, l’astuzia e la malignità mostrate nei secoli dal capodoglio rispetto alla balena, costate la vita a moltissimi marinai, sono le proprietà naturali che convincono Melville a supporre una capacità raziocinante nell’essere vivente più grande del mondo. Di qui un romanzo che è una sfida sul filo della volontà che si serve della forza, perciò con tutti gli ingredienti per riuscire emozionante e avvincente.
Moby Dick viene infatti ritenuto per ragazzi perché d’avventura, ma è notoriamente più citato che letto perché ostico per la sua struttura che ne fa anche uno specialistico trattato di cetologia. Più precisamente è un libro di storia che sembra scritto per conto delle balene da un suo cantore, che in particolare ne racconta una esemplare, protagonista un capodoglio di smisurata forza e bellezza, peraltro raro perché bianco, imbattibile in ogni mare, che nella sfida vittoriosa lanciata al suo nemico più acerrimo, il capitano Ahab, riscatta e vendica il martirio di milioni di esemplari. Al termine di tre giorni di furiosa battaglia, Moby Dick va via seppur ferita “con la velocità del fuoco” dopo avere squarciato la nave che affonderà mentre Ahab, strangolato dalla sua lenza, sparisce nelle onde come un fuscello davanti ai suoi uomini impotenti sulla lancia. Il contrasto è tra un’indomabile forza della natura colta nella sua grandezza e l’esile pochezza di un’umanità proterva e ostinata che nel creato vede il saccheggio e la sopraffazione.
Ahab (o anche Acab e Achab) è trasposizione del sovrano biblico che ripudiò il dio di Israele e perseguitò i suoi profeti per poi morire ucciso in battaglia. Simboleggia la violazione dell’ordine costituito, la perseveranza in una folle idea che si traduce in un progetto che non è possibile condividere, tuttavia portato a compimento in forza del proprio potere fino a un epilogo che appare allo stesso Ahab già segnato e funesto, ma come voluto e ricercato: esitando un finale tragico, in rottura con il genere letterario dell’avventura, giacché il lieto fine è solo quello del capodoglio trionfatore e sopravvissuto. “Io sono il luogotenente del Fato, agisco perché ho ricevuto degli ordini” declama Ahab contro gli inviti dei suoi ufficiali a desistere, dopo aver gridato “Dio vuole che io sia qui”, ma aver nondimeno domandato al cielo, come il Cristo morente sulla croce e in un momento di sconforto “Quale nascosto e ingannatore signore e padrone mi comanda contro tutti gli affetti e i desideri naturali?”. Ahab è un predestinato alla morte nella quale celebra il compimento di una profezia cui non vuole affatto sfuggire. Non è il Bene chiamato a combattere il Male incarnato nel “mostro” della balena bianca, perché in lui Melville vede il sembiante del vero mostro destinato a portare la propria opera alla distruzione, camminando contemporaneamente “sulla vita e sulla morte”, per modo che compie una trasgressione inattesa e sgradita come autore già di successo nel genere esotico che si è fatto un nome per il sostegno dato alla teoria della superiorità dell’uomo sulla wilderness.
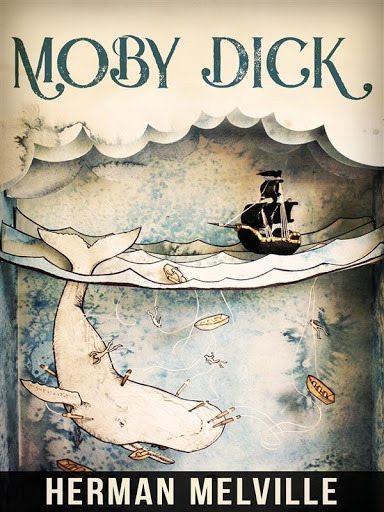 Il pubblico americano si aspetta perciò che Ahab uccida la balena al culmine di peripezie fatte per nobilitarne e magnificarne le gesta eroiche e intrepide, magari a risarcimento della disgrazia dell’Essex e della recentissima sventura capitata nel 1850 a un’altra baleniera attaccata da un capodoglio, ma trova piuttosto – dopo ripetuti segnali più infernali che divini (la caduta in acqua del primo marinaio che da una testa d’albero deve avvistare Moby Dick, gli aghi della bussola invertiti, il cadavere gettato in mare dalla Delizia che lancia spruzzi d’acqua contro la ciglia del Pequod, il falco marino che strappa il berretto ad Ahab e lo getta in acqua, lo stridio delle foche creduto grida di naufraghi…) e un’aria di ineluttabilità incombente sin dall’inizio – le spoglie irredenti di un uomo sconfitto nel quale riconoscere quell’America del progresso e del benessere votata dall’avamposto quacchero di Nantucket a dominare i quattro oceani e i suoi paurosi mostri mentre è invece costretta a fare i conti con un proclama di cui nel Novecento si farà tenace paladino Greenpeace fino a guidare il fronte “No whale” al divieto mondiale della caccia ai cetacei. Lo sconcerto decreta il disfavore comminato al romanzo, il più irriverente della letteratura americana dell’Ottocento nei confronti del sorgivo mito della frontiera tutto volto alla gloria dell’esplorazione, così nel Far West come nei lontani e altrettanto selvaggi Mari del Sud.
Il pubblico americano si aspetta perciò che Ahab uccida la balena al culmine di peripezie fatte per nobilitarne e magnificarne le gesta eroiche e intrepide, magari a risarcimento della disgrazia dell’Essex e della recentissima sventura capitata nel 1850 a un’altra baleniera attaccata da un capodoglio, ma trova piuttosto – dopo ripetuti segnali più infernali che divini (la caduta in acqua del primo marinaio che da una testa d’albero deve avvistare Moby Dick, gli aghi della bussola invertiti, il cadavere gettato in mare dalla Delizia che lancia spruzzi d’acqua contro la ciglia del Pequod, il falco marino che strappa il berretto ad Ahab e lo getta in acqua, lo stridio delle foche creduto grida di naufraghi…) e un’aria di ineluttabilità incombente sin dall’inizio – le spoglie irredenti di un uomo sconfitto nel quale riconoscere quell’America del progresso e del benessere votata dall’avamposto quacchero di Nantucket a dominare i quattro oceani e i suoi paurosi mostri mentre è invece costretta a fare i conti con un proclama di cui nel Novecento si farà tenace paladino Greenpeace fino a guidare il fronte “No whale” al divieto mondiale della caccia ai cetacei. Lo sconcerto decreta il disfavore comminato al romanzo, il più irriverente della letteratura americana dell’Ottocento nei confronti del sorgivo mito della frontiera tutto volto alla gloria dell’esplorazione, così nel Far West come nei lontani e altrettanto selvaggi Mari del Sud.
Melville tradisce tali attese e il senso patriottico della nazione invincibile, candidandosi ad ambientalista e animalista senza però averne coscienza essendo questo sentimento estraneo al suo tempo: nel rapporto uomo-natura parteggia infatti per la seconda non in risposta a uno spirito protezionistico ma nel proposito di denunciare l’ambizione del primo circa la smodatezza di un sogno che diventa delirio. Niente e nessuno può fermare Ahab o distoglierlo dalla sua “ossessione monomaniaca” nella quale trascina il Pequod, la baleniera eburnea che è del colore grevemente uniformante della sua gamba finta e del capodoglio d’avorio dal quale sarà inabbissato in circostanze apocalittiche ed escatologiche: l’ultimo uomo di vedetta sulla testa d’albero più alta, incaricato da Ahab di riattaccare la bandiera all’albero maestro, adempie infatti all’ordine conficcando col martello il chiodo nel momento in cui uno sparviero passa e rimane trafitto, affondando anch’esso negli abissi con il marinaio e la nave, restituendo in questo modo la scena più gravida di significati nel solo beffardo contentino di supremazia che l’uomo ottiene sulla natura. La rovina del Pequod si consuma per voluto contrasto in un mare azzurro e calmo sul quale “una giornata più bella non avrebbe potuto albeggiare”, contro dunque ogni più scontata disposizione di intemperie mosse in sintono dalla furia degli elementi naturali, bensì in una “quiete come rivestimento di uragani”, quiete che all’esagitazione di Ahab e dell’equipaggio oppone la maestosa serenità della balena, quasi che essa sia a conoscenza dell’esito della mortale battaglia, giacché “spande seduzioni” mentre dà prova della sua “malvagia intelligenza”, quella che la induce a colpire non più le lance più insidiose e vicine già duramente danneggiate ma direttamente la nave nella quale apre una falla fatale; quella che le fa sfiatare notte dopo notte spruzzi argentei come indicazioni alla nave perché prosegua la navigazione per attirarla nel suo mare; la stessa che, rivelandone il desiderio di vendetta, fa dire ad Ahab di non essere più il cacciatore ma la preda; quella ancora per cui “ogni morte e mutilazione che la balena provocava non veniva interamente considerata come inflitta da un essere irrazionale”.
Il destino del Pequod si compie a ben vedere nel segno dell’inesplicabile, aggettivo che fa da basso continuo al romanzo e molte volte ripetuto, a designare un clima dichiaratamente trascendentalista che mutua a piene mani le atmosfere del Vecchio Testamento, dal quale rimbalzano Ahab ma anche Elia, “lo strano profeta dei moli” che predice sventure ai marinai che si imbarcano, e poi Ismaele, l’io narrante e in parte alter ego dì Melville, metafora dell’uomo di scarto quale doppio del figlio della schiava di Abramo, come rimbalza pure la vasta planoplia di evocazioni mistiche, invocazioni soprannaturali, presagi di derelizione e dannazione, superstizioni del tipo di quella che ai marinai fanno credere Moby Dick dotata dei poteri dell’ubiquità e dell’immortalità: tutti fattori che connotano il romanzo in senso spiritualista perché fortemente pervaso di animosità religiosa, ma trovando più credenza che credo, più puritanesimo che cristianesimo.
Ismaele è la figura centrale nella quale Melville si confà e compiace, a volte agendo come autore e strappandogli quindi la parola e a volte lasciando che sia lui il narratore nella veste di io narrante. Questo è però un altro grosso limite dell’opera, rilevato già nell’Ottocento, insieme a uno stato di discontinuità e di sproporzioni che aduggia il testo, troppo insistito su scene irrilevanti ai fini della trama, come il sermone di padre Mapple o il racconto improbabile del Town-ho, nonché troppo accademico e scientifico nell’intento di descrivere la baleneria e ogni suo dettaglio, tanto da rischiare seriamente di togliere di mano al lettore il romanzo e metterci un trattato. In realtà il romanzo risente del suo allestimento a brani, dovuto alla fretta di Melville di consegnare al tipografo ogni capitolo appena completato, e proseguito abbandonando, perché non più dovute allo svolgimento, quelle parti concepite in un primo momento come prodromiche in vista di sviluppi poi in realtà mancati.
Delle preveggenze misteriose di Elia nessuna infatti si concretizza e il personaggio rimane “uno straccione sconosciuto” che sparisce con la partenza della nave, così come dileguano gli armatori Bildad e Peleg, figure solo di terra; allo stesso modo si perde sulla nave il rapporto di stretta amicizia nato a Nantucket tra Ismaele e Queenqueg e tale da fare pensare all’inizio a un fitto dipanarsi di vicissitudini in comune. Una volta che il Pequod prende il largo, altri diventano invece i comprimari: i tre ufficiali Stabuck, Stubb e Flask, alcuni ramponieri, il negretto Pip, il vecchio cuoco, il carpentiere e soprattutto il misterioso Felladah, che profetizza ad Ahab la morte in mare ma non prima che abbia visto due carri funebri, che si riveleranno il suo cadavere catafratto su un fianco della balena e la nave che affonda, scena questa che in verità nel racconto segue la morte meschina e niente affatto eroica dello stesso Ahab. Il quale appare sulla scena tardi, come in un film con un protagonista sovrastante, dopo che più voci si sono pronunciate sul suo conto volendone delineare il carattere e dopo che delle balene e delle baleniere Melville ci ha messo a parte di molti aspetti. Alta è la sua attesa da parte del lettore che si aspetta di vedere un gigante e sentirlo tuonare alla ciurma, mentre la prima cosa che il comandante dice, appena l’autore gli dà la parola sul ponte della nave, è una mesta prefigurazione della propria morte: “A un vecchio capitano come me dà l’impressione di calarsi nella propria tomba discendere per questo stretto boccaporto verso la cuccetta scavata come in un avello”.
Ahab rimarrà fino alla fine una figura che osserviamo indirettamente con gli occhi di Ismaele e che appare alquanto indistinta anche quando l’autore lo impegna in serrati e farneticanti monologhi interiori che, come gli altri, introducono inopinatamente il teatro nel romanzo contaminando i generi con trovate, come addirittura le didascalie, che lasciano non poco perplessi: i personaggi si mutano allora in attori e adottano da un lato un linguaggio ricercatamente scescipirano e da un altro un modello di racconto tipico della tragedia greca così facendosi essi stessi narratori di eventi che diventano di terza mano. Fatto è che Ismaele lascia spesso e senza avvertimento il posto a Melville che imbastisce siparietti grotteschi e fuori luogo, si profonde in dissertazioni erudite su ogni campo, incrocia in dialoghi muti i pensieri dei personaggi facendo metaletteratura, sperimenta approcci diretti con il lettore qui e là ammiccando, ammonendo, istruendo.
Insomma Moby Dick non poteva piacere al pubblico del suo tempo, sprovvisto com’era di quegli elementi di giudizio che soltanto il Novecento fornirà al lettore. Il trascendentalismo è negli Stati Uniti quello che in Europa è il romanticismo e richiede perciò che il romanzo sia realistico e analogico e che soprattutto sia davvero romanzo e non anche un manuale addirittura di frenologia e fisiognomica. Da Ismaele che si presenta subito nei panni dell’io narrante ci si aspetta dunque che racconti una storia avvincente di mare nella quale sia egli stesso quantomeno coprotagonista mentre, quando riesce a tenere la parola, si rende semplice testimone di fatti che osserva peraltro a distanza mostrandosi soltanto in un’occasione artefice di una propria azione non però esattamente edificante, quando al timone è preda di un disorientamento e minaccia di portare la nave fuori rotta dopo essersi addormentato.
Ma dal trascendentalismo di Melville non discende un modello romantico, quanto piuttosto un tono predicatorio, quasi quaresimalista, che ricopre il romanzo di una guazza nella quale la narrazione soccombe alla descrizione, lo spirito che aleggia è lo stesso dell’amico Hawthorne preso dalle Scritture, tutto divinazioni e maledizioni. Sennonché una volta fatta la tara al rivestimento rimane il miracolo della rappresentazione di un titanico scontro tra esseri remoti e irreali, entrambi bruti e copia uno dell’altro, l’uomo e la balena, soggetti espressi nella loro massima potenza e tale da far dire a Melville: “Per produrre un libro possente dovete scegliere una trama possente. Nessuna grande e durevole opera potrà mai essere scritta sulla pulce”.
Ha avuto ragione lui, se Moby Dick è oggi più che possente, la forza e la grandezza fatte libro, un libro nel quale le parti trattastiche, forse perché superate dalle nuove conoscenze cetologiche e assumendo ormai un interesse storico, si integrano sempre più con la narrazione a costituire il portato di un’epoca mirabolante, l’epica di una generazione e di una stagione votate al mare, il quadro di una guerra secolare combattuta da entrambi gli eserciti in campo con valore e sacrificio. Sicché più passa il tempo e più Moby Dick si avvicina all’Iliade tanto più che Melville ne ebbe qualche presentimento se della baleneria, comprendendo anche le balene, parlò nei termini di “una confraternita blasonata fatta di eroi e semidei”.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
[il nuovo romanzo di Gianni Bonina è: “Ammatula” (Castelvecchi) – di recente in libreria anche il volume: “Fatti di mafia” (Theoria)]
* * *
[Tutte le puntate di Leggerenza sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo
 di
di 


