
Insieme con i temi della malattia, della morte, dell’amore fatale, della memoria, della guerra, già frequentati in Diceria dell’untore (il romanzo inaugurale considerato il suo capolavoro, ma da molti ritenuto inferiore ad Argo il cieco), motivo centrale della ricerca di Bufalino è il tempo. Ed è il tempo che profila Argo il cieco come mezzo di contrasto dei cambiamenti che produce intus et in cute e come carico di mal-aimé. Un terreno questo sul quale ha particolarmente indugiato la cultura decadentista alla quale Bufalino fortemente ha voluto richiamarsi, sottraendosi a quella che Maria Corti chiamava “glaciazione neorealista” e alle illecebre del naturalismo per porsi in assoluto afelio rispetto al mainstream guidato da un suo confrére qual è Sciascia.
Entro questa prospettiva, Argo il cieco segna certamente un maggiore distacco dal realismo rispetto a Diceria dell’untore di cui pure non costituisce che un seguito in termini autobiografici ma soprattutto uno sviluppo in ambito letterario. E ne è superiore non perché accentua i primi ma perché accresce il secondo in una poetica più pura e spirituale. Del resto fu lo stesso Bufalino, richiesto di rivelare il suo titolo preferito, a indicare Argo il cieco, romanzo più decandestico a motivo proprio del ruolo che il tempo vi svolge.
 Come sacerdote del tempo, Bufalino va senza esitazioni accostato a Thomas Mann, voce supremantica del decandentismo europeo, che concepì La montagna incantata giustappunto in guisa di romanzo del tempo, come pure della malattia, così facendo da pendant tra Diceria dell’untore e Argo il cieco. A ben vedere La montagna e Diceria, pubblicati a distanza di oltre mezzo secolo l’uno dall’altro, osservano un andamento omologo costellato di diffuse analogie sui temi della tubercolosi e del sanatorio, epperò portano a un epilogo contrapposto, giacché entrambi i protagonisti guariscono, ma mentre Giovanni Castorp lascia il sanatorio per andare in guerra e probabilmente incontro alla morte, il protagonista di Diceria, reduce invece dalla guerra, lascia il sanatorio per tornare alla vita, portando con sé quella «educazione alla catastrofe» che se Mann ha inteso trasfondere nella «festa mondiale della morte» che è la guerra, Bufalino ha assimilato nella condizione di minorità esistenziale di cui Argo è prova valendosi del transeunte del tempo.
Come sacerdote del tempo, Bufalino va senza esitazioni accostato a Thomas Mann, voce supremantica del decandentismo europeo, che concepì La montagna incantata giustappunto in guisa di romanzo del tempo, come pure della malattia, così facendo da pendant tra Diceria dell’untore e Argo il cieco. A ben vedere La montagna e Diceria, pubblicati a distanza di oltre mezzo secolo l’uno dall’altro, osservano un andamento omologo costellato di diffuse analogie sui temi della tubercolosi e del sanatorio, epperò portano a un epilogo contrapposto, giacché entrambi i protagonisti guariscono, ma mentre Giovanni Castorp lascia il sanatorio per andare in guerra e probabilmente incontro alla morte, il protagonista di Diceria, reduce invece dalla guerra, lascia il sanatorio per tornare alla vita, portando con sé quella «educazione alla catastrofe» che se Mann ha inteso trasfondere nella «festa mondiale della morte» che è la guerra, Bufalino ha assimilato nella condizione di minorità esistenziale di cui Argo è prova valendosi del transeunte del tempo.
Ma è possibile raccontare il tempo? Per Baudelaire «siamo schiacciati dall’idea del tempo», che però «si può dimenticare servendosene». Cosa significa «servirsi» del tempo? Mann, da tenere come il più vicino modello di riferimento, assegna al tempo letterario la stessa funzione che riveste nella musica e può quindi dire che «la narrazione assomiglia alla musica in quanto riempie il tempo».
Il tempo (di cui quindi in tal senso ci si «serve») diventa elemento della narrazione come lo è della musica. Narrazione e musica possono allora fondersi assumendo il tempo al proprio «servizio». Ma per fare questo devono eludere la realtà, diventare evanescenza, in una parola onirismo. Coerentemente Argo il cieco porta come sottotitolo “I sogni della memoria”, perché in senso decadente il tempo integra il sogno ma anche la memoria e quindi il ricordo. Proust ha insegnato come raccontare il tempo, meglio come «riempire» il tempo passato: con la narrazione. È ciò che ha fatto Bufalino ricordandosi però di Mann, per il quale la narrazione del tempo è musica. In questo senso Argo il cieco è un testo carico di una musicalità talmente esorbitante da confinare in secondo piano la narrazione.
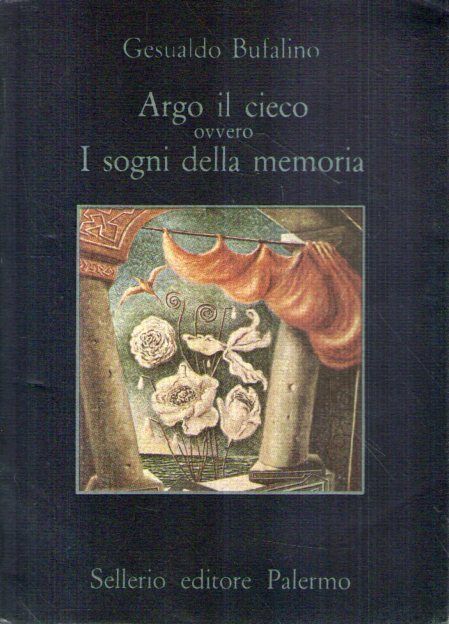 La trama, come ha notato a suo tempo la critica, non riesce infatti a stare al passo dello stile, tenuto com’è sui toni alti e lirici del Bufalino più baroccheggiante e versato nella sovrabbondanza lessicale. Correttamente è stato perciò osservato che «in questo sogno della memoria la trama va per conto suo mentre quel che conta, come all’opera, è la musica»: la musica, anzi la musicalità del tempo che passa, scandisce i tempi del romanzo e trasmuta la memoria non solo in sogno ma anche in malattia: «Coi minuti la memoria procede come il corpo davanti alle invasioni dei microbi. Appena l’infezione avvenga, saltano subito al contrattacco miliardi di globuli. Una forza di difesa isola i ricordi più micidiali».
La trama, come ha notato a suo tempo la critica, non riesce infatti a stare al passo dello stile, tenuto com’è sui toni alti e lirici del Bufalino più baroccheggiante e versato nella sovrabbondanza lessicale. Correttamente è stato perciò osservato che «in questo sogno della memoria la trama va per conto suo mentre quel che conta, come all’opera, è la musica»: la musica, anzi la musicalità del tempo che passa, scandisce i tempi del romanzo e trasmuta la memoria non solo in sogno ma anche in malattia: «Coi minuti la memoria procede come il corpo davanti alle invasioni dei microbi. Appena l’infezione avvenga, saltano subito al contrattacco miliardi di globuli. Una forza di difesa isola i ricordi più micidiali».
A questo punto il tempo invale come corruzione del corpo nonché, come dice Bufalino, degli «eventi» e quindi della vita, diventando vulnus dell’esistenza e perciò malattia, e involgendo un altro tema caro ad Argo: «Erano miliardi di miliardi le cellule nostre in marcia verso lo sfacelo finale, la cinerea perfezione del niente».
Nel solco della migliore tradizione decadentista e primonovecentesca, Bufalino aggancia, così come Mann, come Proust, come Svevo, il tema del tempo a quello della malattia e quindi reitera l’istanza esistenzialista. Il senso di caducità dell’esistenza, ciò che è «il deperibile Qui e l’effimero Ora», il sentimento eracliteo del panta rei, la consonanza della vita con il carpe diem («Minuto d’oro non te ne andare» sono le ultime parole di Argo il cieco in un desinit che richiama quello dell’Educazione sentimentale di Flaubert: «Non abbiamo avuto tempo migliore dopo»), l’ineluttabilità senechiana della morte, sono tutti cabs che conducono Bufalino a un nichilismo senza speranza e baudelairianamente inteso.
Ma come Ivan Ill’Ic, che va serenamente incontro alla morte («Finita la morte, non c’è più la morte») sostituendo il suo originario sentimento di odio verso la famiglia indifferente alla sua malattia con l’affermazione del primato dell’amore non egoistico, così Bufalino rintraccia negli amori della sua gioventù il prodromo e il contrappunto all’incombente senso di finis vitae che lo aduggia. Il Gesasim di Tolstoj echeggia Maria Venera, Isolina e Cecilia, modelli di sanità e di bellezza tanto più bramati quanto meno sensibili si mostrano alla sua malattia di giovane fatto vecchio. Non c’è fede nel futuro in Bufalino, non c’è speranza ultraterrena: per modo che finirà per dettare il noto epitaffio “Hic situs, luce finita”. Di ricordi si ammala e di ricordi si cura, ha già detto delle proprie sindromi lo scrittore che cerca linfa vitale (scrivendo Argo come «medicina geriatrica») nel suo solo passato, avallando il Dostoevskij delle Memorie dal sottosuolo per il quale l’uomo è impotente di fronte alla vita e alla realtà e per purificarsi ha bisogno di umiliarsi.
E la strada dell’umiliazione Bufalino l’ha percorsa tutta gabellandola, seppur barando con la «vita nova» di un’estate felice a Modica. Un’estate detta felice che felice però non è, perché a quell’estate del 1951 il «povero Gesualdo detto il Meschino», chiuso in un albergo romano in attesa di visite mediche, ripensa come a un antidoto contro la morte mentre ne fa uso di viatico. Dei tanti episodi di quell’estate non ce n’è infatti uno che possa dirsi davvero felice: Bufalino o il suo alter ego, come un Rubè, passa da un fallimento a un altro, da un amore non corrisposto (per Maria Venera) a un altro ottenuto di contrabbando (da Cecilia) a un terzo non compreso (con Isolina). Ed è sempre solo, i suoi amici Iaccarino, Licausi, Sasà Trubia, Liborio Galfo essendo preda di un amor fati che insegna loro che «vivere significa qualcosa» mentre egli rimane in balia di un cupio dissolvi che lo spinge a vedere nella vita una «bambolina truccata, che nulla ha fatto per persuaderlo di essere vera».
La vita come complesso di valori irrisolti, dove l’amore nulla dà a chi vive ma molto aiuta chi aspira invece a morire, evoca il principe Andrej di Guerra e pace che solo nell’agonia pone l’amore per Nastasa sotto una luce contemplativa, cioè eterna, o meglio ancora in una linea di superamento di ogni relatività. Così Bufalino, «nel canovaccio dell’inevitabile vita», scopre di aver recitato l’amore e di poter guardare alle sue donne amate e innamorate come «compagne di una stagione di giro». La rivelazione in Andrej e nel giovane Bufalino matura a seguito della reciproca presa di coscienza di essere estranei al loro ambiente e di non sapere più comunicare con esso. E per questa via il principe Andrej, sospeso tra due mondi in successione, porta con mano Bufalino in casa del principe di Salina. Sicché Argo il cieco è romanzo sorprendentemente consentaneo al Gattopardo in ciò che soprattutto è il progressivo esaurimento del «fluido vitale» e l’inclinazione a «essere per la morte».
L’ineludibile fluire e morire delle cose e della vita, giocato tra rimpianto del passato e rifiuto del presente, visto con lirica contemplazione, ma anche con ironia consolatoria, l’assunzione del tema dell’amore a paradigma della vita consociano Lampedusa e Bufalino e fanno di don Alvise Salabba un altro don Fabrizio Corbera e di don Nitto Barreca il doppio di Calogero Sedara. Come don Fabrizio, don Alvise muore al culmine di un ballo di gala, che nel Gattopardo come in Argo il cieco costituisce la spannung dove le due fabulae si sciolgono e a cui appropriatamente è dedicata una parte preponderante. Alla loro morte un senso di sopravvivenza intride le figlie di Salina e la nipote di don Alvise mentre segna la rottura in Lampedusa di due epoche storiche e in Bufalino di una vita in due. E infatti è solo dopo la morte di don Alvise, proprio durante il suo funerale, che Bufalino scopre di non aver amato Maria Venera ma di averla voluta amare. Il senso di sfacelo che intrama Il Gattopardo non è soltanto lo sgretolamento di un’era che prepara quella nuova ma sottende anche quella «compiaciuta attesa del nulla» che è la sigla sotto la quale va inscritto Argo il cieco. Dove il tema della Sicilia abbandonata «alla deriva nei meandri del lento fiume pragmatistico» è non meno presente che nel Gattopardo.
Bufalino fa allora dire a Iaccarino quanto Lampedusa ha fatto dire con altre parole a Salina: «Venera è una parossistica, come tanti siciliani sono. Noi amiamo fabbricarci valori e onorarli al posto di Dio. Valori e controvalori. Quando un valore ci fa cilecca, ci buttiamo su quello contrario, ne facciamo idolo e merce. Così in ogni coppia d’estremi il mezzo non ci sta bene, ci piacciono l’uno e l’altro: la devozione e il rancore, la fede e il sospetto, la chiacchiera e l’omertà, la norma e lo scandalo, l’onore e il disonore». Che è la logica ossimorica che scalda – o raffredda – la cultura siciliana la cui spinta parossistica Lampedusa ha rappresentato con la superba figura retorica dei siciliani come sale della terra.
Ma opera ben diversa del Gattopardo è Argo il cieco nell’accostamento al lettore che Bufalino stabilisce servendosi da un lato del dettato baudelairiano con i suoi capitoli «a parte» e da un altro del monologo interiore di derivazione sveviana che, sconfinando nel flusso di coscienza di richiamo jocyano, conferisce al romanzo un carattere di sperimentalismo e di maturo novecentismo che risponde al gusto emergente ponendolo al fianco di libri riconducibili all’insegnamento calviniano molto sentito negli anni Settanta e Ottanta.
Ma come romanzo di amori, laddove Diceria dell’untore è stato romanzo di un amore, Argo il cieco ha una sua struttura che ne fa anche romanzo di un paese. La dépense che attraversa carsicamente le storie d’amore del Bufalino trentenne (in gran parte placcate di fantasia com’è nel costume del Bufalino conteur) si amalgama con la città barocca colta nel momento storico in cui esprime il massimo struggimento e forse la maggiore bellezza, quasi che l’estate del ’51 sia stata felice per Modica anziché per Bufalino. Una Modica che sa di «mostarda calda», che evoca l’attimo «caldo e buono» del minuto di gioventù, che rimanda il «tepore dei suoi cortili», i «carrubi affettuosi, i muri di sasso lampanti come verbi di Dio». Un luogo dell’anima insomma, sicché il Circolo dei civili, via Carreri, il Caffé Buonaiuto, «il Salone», la Sorda sono estenuati topoi di bellezza; ma anche un luogo estraneo, dove è impossibile a un forestiero non sentire «alitare attorno un’aura di sottile incorporea alienità» e non essere toccato dalla «macchia innocente» dell’inconterraneità, che come tiene lontana Maria Venera così tiene a distanza Modica, l’una e l’altra essendo per Bufalino oggetto d’amore e quindi preclusi a un cuore refoulé e déraciné. Un cuore che pulsa seguendo le cadenze d’inganno della coazione a fare della propria vita un reperto di studio sociopsicopedagogico, perché Bufalino è narratore di sé stesso e spalma il proprio io sulla propria circostanza per risalire a una teoria della condizione umana vista come universale e senza tempo.
Il tempo infatti, il cronotopo bachtiniano che stabilisce le distanze, che misura i mutamenti diacronici sia corporali che mentali, che trasmuta le epoche in nuove stagioni, che accende e spegne amori e che illude e delude. Il tempo per Bufalino è un corruttore. «Questo è ora – scrive perciò in chiusura in un lamento da Comiso – guardatelo, il ragazzo di cento pagine fa». Per poi rivolgere alla vita una finale ed esiziale “Preghiera, dietro le quinte”. Sono le ultime righe di Argo, il cieco reso tale dal tempo: «Vita, il tuo fuoco langue più l’amo. Gocciola di miele, non cadere. Minuto d’oro, non te ne andare». D’oro sì, ma effimero il tempo di Bufalino.
Il tempo, soprattutto quello minimo, è stato decisivo anche nella vita dello scrittore che diceva sempre: «Basta un minuto in più o in meno e si prende l’appuntamento con la morte». Lui lo prese un giorno per strada su un’auto che doveva percorrere, in un altro momento, una provinciale e non una statale, un’auto che venne investita da un’altra auto guidata da una donna il cui nome era lo stesso di una figura del suo primo libro intitolato Il tempo in posa. Avvenne in un giorno di pioggia, il tempo meteo che aveva sempre amato, tanto da avere appena scritto così all’inizio del suo ultimo Tommaso e il fotografo cieco (altro sogno della memoria e altro stato di cecità): «Da ragazzo mi piaceva il rumore della pioggia».
Bufalino ha raccontato il tempo calcolandolo dentro di sé e ne ha fatto uno strumento per rilevare la propria entropia e confrontarla con quella dell’umanità. Argo il cieco è dunque il rilevatore di questo processo di derelizione e costituisce il libro che contiene tutti gli altri o li richiama. Persino Diceria dell’untore può essere visto alla stregua di una prova in vista di esso, talché Bufalino non vede più il mondo in sé stesso ma sé stesso nel mondo, “gettato” heideggerianamente nel mondo.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
[i nuovi libri di Gianni Bonina sono: “Un cuore per la signora Chimento” (Marlin editore); “Ammatula” (Castelvecchi); “Fatti di mafia” (Theoria)]
* * *
[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo




