
Sorprende come nel 1915 un giovane praghese di 32 anni possa sentire più urgente la questione della giustizia che non l’orrore della guerra e scrivere un romanzo che non completa e non pubblica a ridosso di un altro appena uscito su un motivo ancora più elusivo qual è la perdita d’identità fino alla mutazione genetica. Il processo, uscito solo nel 1925, è un romanzo più escapista che disforico: l’autore sfugge il suo presente per sottrarsi alla realtà ma si ferma nei dintorni inestricabili e omologhi di un tema che tuttavia sottende un significato di giustizia da intendersi anche nel senso di giustizia umana, quindi di pace sociale. Nell’arresto immotivato e senza un perché di Josef K. (dove l’iniziale adombrerebbe l’autore) traluce l’insensatezza di una “guerra europea” che viene sostenuta e combattuta con lo stesso animo dell’accusato sottoposto a un processo privo di un’accusa, da vincere ma senza chiedersi il motivo per cui battersi e le cause che lo hanno determinato. Epperò invece della vittoria prevale via via la rassegnazione nel cui ambito la lotta contro la sopraffazione non è che una volontaria discesa agli inferi, tra disperazione e disumanità, non diversamente dal corso degli eventi bellici che culminano nella perdita di venti milioni di vite umane.
Il tisico Franz Kafka ingaggia la sua guerra personale e solitaria contro l’ingiustizia nel mondo immaginando non più un uomo che improvvisamente e irrazionalmente si trasforma una mattina in un ragno come Gregor Samsa in La metamorfosi, metafora delle incognite della vita e delle prospettive angoscianti che essa tende, ma supponendo un uomo – l’uomo contemporaneo messo di fronte all’assurdità di una guerra mondiale – al quale una mattina qualunque viene notificato un ordine di arresto (dunque, nel traslato, di sequestro della coscienza) per una colpa che però gli è taciuta, per modo che il fatto nuovo che cambia di colpo la vita non arriva più da un fenomeno naturale, quanto si voglia metafisico, bensì da una volontà umana ispirata a un criterio altrettanto stocastico di sorte funesta ma da comprendere anch’essa nell’ordine degli accadimenti possibili e quindi fisici.
 Per rappresentare la visione dell’uomo alla mercé delle forze cosmiche, ineluttabili quanto incoercibili e indecifrabili, Kafka eleva la questione della giustizia a paradigma del destino umano e indica una regola di fondo: la determinazione di qual è l’accusa è di ordine secondario rispetto al titolare di essa, contando di più chi la muove che non il suo contenuto. Quello che Sciascia chiamerà “ingranaggio” nel quale chiunque può cadere e che si preciserà nella transustanziazione della legge per cui la giustizia si compie sempre, a dispetto del suo amministratore e celebrante, in Kafka la troviamo anticipata in un’idea di giustizia che si muove su automatismi immodificabili che riconoscono la forma e non la sostanza: così come non vale la fattispecie di reato, a sconfessione del principio romano “nulla pena sine lege”, ma solo il laticlavio di giudice, allo stesso modo per l’imputato rileva la sua veste di accusato e non la qualificazione della colpa, sicché la difesa non può esercitarsi che sulla persona e la sua condotta, né si ha un’inversione dell’onere della prova per la quale spetti all’imputato dimostrare la propria innocenza, giacché a rilevare non è il fatto in sé, se commesso o meno, ma la vita nel suo insieme.
Per rappresentare la visione dell’uomo alla mercé delle forze cosmiche, ineluttabili quanto incoercibili e indecifrabili, Kafka eleva la questione della giustizia a paradigma del destino umano e indica una regola di fondo: la determinazione di qual è l’accusa è di ordine secondario rispetto al titolare di essa, contando di più chi la muove che non il suo contenuto. Quello che Sciascia chiamerà “ingranaggio” nel quale chiunque può cadere e che si preciserà nella transustanziazione della legge per cui la giustizia si compie sempre, a dispetto del suo amministratore e celebrante, in Kafka la troviamo anticipata in un’idea di giustizia che si muove su automatismi immodificabili che riconoscono la forma e non la sostanza: così come non vale la fattispecie di reato, a sconfessione del principio romano “nulla pena sine lege”, ma solo il laticlavio di giudice, allo stesso modo per l’imputato rileva la sua veste di accusato e non la qualificazione della colpa, sicché la difesa non può esercitarsi che sulla persona e la sua condotta, né si ha un’inversione dell’onere della prova per la quale spetti all’imputato dimostrare la propria innocenza, giacché a rilevare non è il fatto in sé, se commesso o meno, ma la vita nel suo insieme.
Josef K. pensa dunque di presentare una memoria difensiva che, dando conto di ogni suo comportamento, non potrà che essere necessariamente lunghissima, un memoriale “che sarebbe stato infinito, riguardando tutta quanta la propria vita, con le azioni e gli avvenimenti più insignificanti”: e su di esso lavora anche il suo avvocato, nella certezza tuttavia che non solo non verrà letto dai giudici ma che è del tutto inutile, visto che gli atti del processo e l’atto d’accusa sono inaccessibili sia alla difesa che all’imputato. K. allora esonera l’avvocato per dedicarsi egli stesso alla stesura del memoriale, ma non sappiamo se lo deposita in tribunale mancando la parte che Kafka avrebbe dovuto scrivere a seguito dell’incontro con il suo legale. Sappiamo invece che non gli gioverà perché l’esito del processo è segnato, tanto che K. alla fine si ritrova in mano ai suoi carnefici nell’accettazione di una condanna che ritiene inevitabile e alla quale non può sfuggire perché, come gli dice Leni, la segretaria dell’avvocato, solo quando si è confessata la colpa si ha la possibilità di scongiurare la pena, colpa che però non può essere ammessa perché l’accusa è sconosciuta.
K. finisce perciò giustiziato, preda per giunta di una esiziale e prototipica sindrome di Stoccolma, senza alcun dibattimento, interrogatorio in aula, confronto tra le parti, deposito di atti ed escussione di testi. Quel che K. sa è solo che il suo non è un processo comune ma speciale, il che postulerebbe un’accusa più grave e un collegio giudicante più autorevole, sennonché il solo giudice al quale viene chiamato a presentarsi è il giudice istruttore, un quadro di base nel novero di figure giudiziarie che comprende i “guardiani”, “l’ispettore”, “la commissione d’inchiesta” e imprecisati “impiegati”, tutti anch’essi di grado minore, ma fondamentali nel merito del processo, perché “il valore principale della difesa” è costituito non dagli argomenti di prova ma dai “rapporti personali” che gli avvocati riescono a instaurare proprio con giudici e impiegati, cui provano a riuscire graditi in un canonico tentativo di captatio benevolentiae dando loro anche consigli peraltro richiesti e intramando contatti fuori dal processo, nei corridoi, negli studi legali e persino negli atelier dei pittori: come capita infatti a K. che viene indirizzato da un artista dal nome d’arte italiano (omaggio dell’autore all’arte italiana, ripetuto nella figura del corrispondente di banca italiano in visita per conoscere i monumenti della città, che è sicuramente Praga), Titorelli, ritrattista ufficiale dei giudici anche più elevati, il quale si dice pronto ad aiutarlo come confidente del tribunale solo se è innocente e se è concreta la possibilità di un’assoluzione, condizioni queste che sono piuttosto tutte da verificare appunto nel processo.
In base agli intrecci extra ordinem delle relazioni personali, Josef K. può aspirare come tutti gli imputati a una delle tre forme di assoluzione possibili: quella reale, quella apparente e quella che comporta il rinvio. La prima è impossibile perché una vera assoluzione richiede di essere innocenti e l’innocenza non può essere provata, né può essere riconosciuta senza un vero processo e nel rispetto di quel sistema che Josef K. richiama quando al momento dell’arresto dice a se stesso di vivere in uno Stato di diritto dove la pace regna ovunque e tutte le leggi sono in vigore; la seconda forma di assoluzione porta di fatto a uno stato permanente di libertà interrotto solo da periodici arresti formali e riprese apparenti del processo senza mai arrivare alla sentenza; la terza consente di tenere con cavilli e sottigliezze il processo sempre allo stadio iniziale.
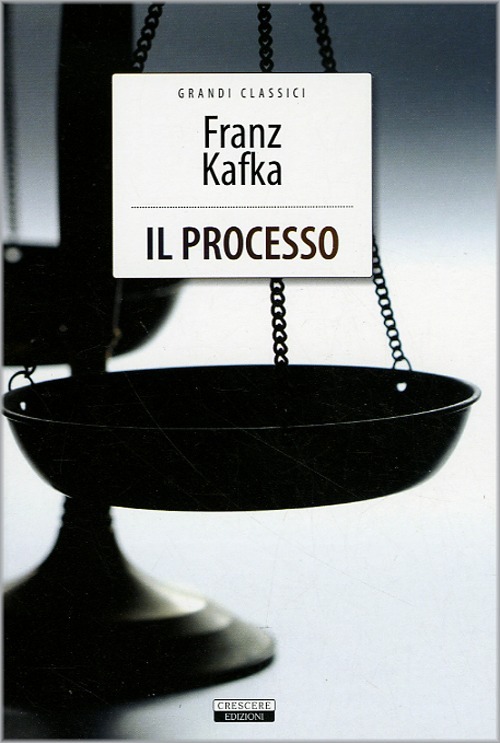 Ma Josef K., procuratore di una grande banca e prossimo vicedirettore, scapolo e affittuario di una stanza ammobiliata in un pensionato misto, non ha speranza di ottenere alcuna delle tre assoluzioni. Affronta il processo partendo da logiche realistiche e chiede perché sia dichiarato in arresto, senza però avere risposta dall’ispettore se non che in realtà rimane a piede libero, ma poi si conforma allo spirito del processo che diventa per lui uno stato esistenziale entro il quale assumere un nuovo modo d’essere fino a ragionare nei modi degli impiegati e degli avvocati, ammettendo di trovarsi sotto accusa e riconoscendo che essa è grave. Alla speranza iniziale, fatta anche di volitiva reazione al processo e scontri pubblici per cambiarne la procedura, segue la disperazione di chi è prossimo alla confessione, ormai annichilito e reso un automa: nel rifiuto a incontrarlo che la signorina Bürstner, compagna di pensionato, gli fa notificare da una compagna di stanza, K. vede la propria sconfitta, uguale al declino che la sua posizione di prestigio registra in banca, segno di un decadimento che da un supposto e oscuro singolo atto illegale si estende all’isterilimento della vita e alla mortificazione della propria personalità.
Ma Josef K., procuratore di una grande banca e prossimo vicedirettore, scapolo e affittuario di una stanza ammobiliata in un pensionato misto, non ha speranza di ottenere alcuna delle tre assoluzioni. Affronta il processo partendo da logiche realistiche e chiede perché sia dichiarato in arresto, senza però avere risposta dall’ispettore se non che in realtà rimane a piede libero, ma poi si conforma allo spirito del processo che diventa per lui uno stato esistenziale entro il quale assumere un nuovo modo d’essere fino a ragionare nei modi degli impiegati e degli avvocati, ammettendo di trovarsi sotto accusa e riconoscendo che essa è grave. Alla speranza iniziale, fatta anche di volitiva reazione al processo e scontri pubblici per cambiarne la procedura, segue la disperazione di chi è prossimo alla confessione, ormai annichilito e reso un automa: nel rifiuto a incontrarlo che la signorina Bürstner, compagna di pensionato, gli fa notificare da una compagna di stanza, K. vede la propria sconfitta, uguale al declino che la sua posizione di prestigio registra in banca, segno di un decadimento che da un supposto e oscuro singolo atto illegale si estende all’isterilimento della vita e alla mortificazione della propria personalità.
Lo zio che, appresa la notizia dell’arresto, accorre trafelato e preoccupato in aiuto a K., è in pensiero più per le ricadute negative del processo sulla famiglia e dice al nipote che non vorrebbe che dall’essere stato un loro punto di orgoglio diventasse la loro vergogna, ma quel che vuole sapere è il tipo di processo cui è sottoposto e non l’accusa di cui deve rispondere. Guardando K. dimagrito e come assente, gli dice che forse è vero il proverbio secondo cui essere accusati è già una condanna, perciò lo incita a difendersi e lo accompagna in casa dell’avvocato Huld, malato ma attivo al punto da ricevere clienti persino di notte e di farli aspettare anche tre giorni dietro la porta. La giustizia per Huld è uno scontro di forze e un incontro di sforzi intesi a compromessi basati sui soli “rapporti personali” che possono nascere da simpatie, opportunismi, giochi di potere, avversioni di pancia. I giudici hanno licenza assoluta e occupano gerarchie che sono in correlato con quelle degli avvocati, distinti in “grandi avvocati”, pochi e pressoché irraggiungibili, “piccoli avvocati”, la gran parte, e “legulei”, tenuti in disprezzo anche dagli impiegati. In questo assetto nel quale i gradi giudiziari bassi non conoscono gli sviluppi di un processo e gli avvocati non vi hanno accesso se non in relazione allo stadio cui il processo è giunto e al giudice che lo istruisce, “la legge non va in cerca della colpa, ma è attratta da essa”. È questo il principio fondante dell’intero sistema immaginato da Kafka: l’azione penale non è né obbligatoria né necessaria, perché non è la polizia che va a caccia dei colpevoli ma sono i colpevoli che sono attratti come falene dalla polizia e cadono nella sua rete. Quando una domenica mattina Josef k. deve raggiungere il tribunale per il primo interrogatorio davanti alla commissione d’inchiesta e si trova in un complesso residenziale dove si aprono più scale interne senza sapere quale porta agli uffici giudiziari, ne prende una a caso sapendo che è quella giusta, perché è attratto da essa e dunque si riconosce già in partenza colpevole.
La rassegnazione alla condanna arriva nel duomo dove incontra un predicatore membro del tribunale col quale finisce per convenire circa l’interpretazione della storia che egli gli racconta, il famoso apologo già pubblicato da Kafka in precedenti occasioni e intitolato “Davanti alla legge”: è il guardiano posto davanti alla porta della legge e non “l’uomo di campagna” a essere ingannato e ad avere ragione. La storia viene presentata sotto la definizione di “scritti introduttivi alla legge”, al pari di un testo sacro soggetto a interpretazioni varie da parte dei commentatori che si riferiscono alla “Scrittura” quale fonte esegetica: l’uomo di campagna vuole entrare nella legge ma il guardiano gli dice che deve aspettare. Nell’attesa trascorre tutta la vita fin quando in punto di morte l’uomo chiede al guardiano perché nessun altro ha chiesto come lui di entrare e si sente rispondere che la porta della legge è stata aperta solo per lui e che, dopo la sua morte, sarà chiusa.
Il processo si sostanzia in questo lungo e articolato teorema, dove Kafka dimostra di avere della legge una concezione relazionale ispirata al paradosso dell’inattingibilità: al servizio e appannaggio di ogni uomo, non può tuttavia essere fruita personalmente, valendo come regola generale astratta ma non come mezzo per ottenere giustizia. Il guardiano posto a sua custodia, anzi a suo servizio, è un rappresentante dello Stato che a sua volta non ha neppure lui la libertà di entrare nella legge dentro la quale altri guardiani, sconosciuti e irraggiungibili, si ergono a sua difesa. Una legge autoreferenziale e apodittica dunque, imperscrutabile e insindacabile, un totem che onora una Giustizia ingiudicabile cui impetrare solo grazie e pietà. Quando Josef K. si reca in casa di Titorelli e vede il ritratto di un giudice al quale il pittore sta lavorando, ha l’impressione che la raffigurazione vada assumendo “un risalto particolare” non ricordando più la dea della Giustizia ma nemmeno quella della Vittoria, perché assomiglia sempre più alla dea della Caccia. La preda è lui stesso e invece di scappare si addice ad andarle incontro, attratto dalla legge come un colpevole. Allo stesso modo l’uomo del tempo di Kafka è attratto dal demone della guerra nelle cui spire si getta in nome di ideali che come le porte della legge sono astratti e inaccessibili. Kafka ha lasciato il suo capolavoro deliberatamente incompleto, pur essendo vissuto altri nove anni. Voleva che il manoscritto fosse bruciato, prova di un probabile ripensamento circa le teorie espresse sulla giustizia. Forse, terminata la Grande guerra, ha visto venire meno le ragioni alla base della sua visione allegorica, guardando a un futuro non più popolato di mostri, senza però immaginare che il peggio sarebbe arrivato di lì a presto. Non a caso infatti il romanzo è assurto ad archetipo del nostro tempo dopo la Seconda guerra mondiale, diventando anzi più attuale e vero.
Lo scrittore ceco ha lasciato il libro incompiuto, ma anche sei brani chiamati successivamente “Frammenti” che avrebbero dovuto essere integrati nel corpo del testo. Troviamo dunque nomi di personaggi come Wolfahrt, accostato a Titorelli, e “il signor Kühne” che segnalano come il romanzo fosse più esteso almeno nelle intenzioni dell’autore e nei suoi cartoni preparatori. Chiedendone la distruzione, Kafka non pensò a rifinire il testo, che presenta non poche contraddizioni e avrebbe richiesto un editing accurato per eliminare ripetizioni, cadute di stile e incongruenze. Una si ha quando leggiamo: “Meglio non rivelare per il momento particolari che potrebbero avere un’influenza sfavorevole su K. ispirandogli troppa speranza o troppa paura”. A scrivere è l’autore in persona e lo fa per la prima e unica volta in un romanzo che appare rigorosamente eterodiegetico e privo di concessioni e ammiccamenti al lettore, entro un tono alto di solennità e puntiglio. È solo una menda in un’opera che sottende un antivangelo laico, un appello civile all’uomo e alla sua coscienza che oggi sentiamo quanto mai forte e ravvicinato. Kafka senza saperlo è a noi che parlava più che ai suoi contemporanei.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
[è appena uscito il nuovo romanzo di Gianni Bonina: “Ammatula” (Castelvecchi) – di recente in libreria anche il volume: “Fatti di mafia” (Theoria)]
* * *
[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo




