
Rileggere La peste dopo il coronavirus è come farlo per la prima volta. Pur ammirando la forte precisione del quadro generale quanto soprattutto agli effetti psicologici sia individuali che collettivi, tali da far sembrare che Camus abbia vissuto una vera epidemia, mentre non si è che documentato su quelle passate, se ne colgono tuttavia lacune che prima sarebbe stato difficile trovare: non tanto le inesattezze scientifiche circa la differenza tra peste bubbonica e polmonare, da Camus confuse nelle manifestazioni fisiche e la seconda posta come complicanza della prima, quanto le misure di contenimento che abbiamo imparato oggi a comprendere in termini di “lockdown”. Benché la peste polmonare si diffonda attraverso saliva, sudore e particelle di sternuto e tosse, le autorità prefettizie di Orano (la città algerina di Camus dove la pestilenza divampa) non prescrivono alcuna quarantena, ma al culmine dei contagi e del conseguente pericolo per l’ordine pubblico ordinano il coprifuoco dopo le ventitré (provvedimento esorbitante dopo aver parlato di semplice febbre perniciosa sui manifesti affissi nelle sole strade secondarie) e intanto dispongono che la città sia chiusa e considerata una “zona rossa” dalla quale non si possa uscire e nella quale sia proibito entrare.
Ma dentro la città blindata “i prigionieri della peste” sono liberi durante il giorno di frequentare bar e ristoranti senza alcun distanziamento, affollare autobus con la sola cautela di darsi le spalle, andare a teatro e magari assistere alla morte sulla scena dell’attore protagonista, gremire i cinema solo per vedere lo stesso film ripetuto ogni giorno. L’isolamento non è degli abitanti di Orano ma della città in sé, priva anche di approvvigionamenti che non siano provento del mercato nero, dove però i giornali continuano ad uscire, i tipografi stampano testi di maghi e santi della Chiesa, le persone circolano senza mascherine sterili né tantomeno guanti, i preti possono evocare dai pulpiti la punizione divina su centinaia di fedeli assembrati al chiuso e la gente può toccarsi, stringersi la mano, accarezzare infettati e abbracciarsi senza precauzione alcuna.
 Queste dissonanze che Camus forse nemmeno immaginò, perché la storia della peste non indugia sulla profilassi, conferiscono al romanzo un senso di quella “astrazione” dal reale che in diversa cotta Camus indica come il fondamento del modello di vita collettiva cui cinicamente costringe la peste in contrasto con la felicità personale ricercata da ogni individuo. È questo il punctum individuationis del romanzo. Mentre noi oggi lo rileggiamo come un apologo sociale e non come un rapporto realistico, l’autore lo intese in guisa di un dostoevskjano dissidio psicomachico, del singolo come della società, tra la ragione dei propri sentimenti e l’obbligo del dovere morale che diviene etico: l’astrazione integra dunque il sacrificio che ogni individuo fa dei propri bisogni e dunque della realtà del proprio essere a favore di una condizione generale che assurge – astrattamente, astrusamente – a prioritaria. Tutti i personaggi possono invero tirarsi fuori e salvarsi, ma nessuno lascia gli appestati: non lo fa il giornalista Raymond Rambert che come forestiero progetta di scappare ma poi si sente chiamato da quella astrazione dal cuore a scegliere di restare piuttosto che riabbracciare la fidanzata, né lo fa il misterioso e anch’egli non oranese Jean Tarrou che di peste finisce pure per morire proprio quando l’epidemia è quasi cessata, così come muore padre Paneloux, impotente testimone di centinaia di morti e quaresimalista di una teodicea affranta. Neppure Bernard Rieux, il medico più impegnato sul fronte sanitario, pensa mai di lasciare la città per raggiungere la moglie andata in un lontano sanatorio dove morirà di tubercolosi (il morbo di cui già da ragazzo è affetto Camus), convinto che ci sia un solo modo per essere santi senza Dio ed è quello di fare il proprio dovere.
Queste dissonanze che Camus forse nemmeno immaginò, perché la storia della peste non indugia sulla profilassi, conferiscono al romanzo un senso di quella “astrazione” dal reale che in diversa cotta Camus indica come il fondamento del modello di vita collettiva cui cinicamente costringe la peste in contrasto con la felicità personale ricercata da ogni individuo. È questo il punctum individuationis del romanzo. Mentre noi oggi lo rileggiamo come un apologo sociale e non come un rapporto realistico, l’autore lo intese in guisa di un dostoevskjano dissidio psicomachico, del singolo come della società, tra la ragione dei propri sentimenti e l’obbligo del dovere morale che diviene etico: l’astrazione integra dunque il sacrificio che ogni individuo fa dei propri bisogni e dunque della realtà del proprio essere a favore di una condizione generale che assurge – astrattamente, astrusamente – a prioritaria. Tutti i personaggi possono invero tirarsi fuori e salvarsi, ma nessuno lascia gli appestati: non lo fa il giornalista Raymond Rambert che come forestiero progetta di scappare ma poi si sente chiamato da quella astrazione dal cuore a scegliere di restare piuttosto che riabbracciare la fidanzata, né lo fa il misterioso e anch’egli non oranese Jean Tarrou che di peste finisce pure per morire proprio quando l’epidemia è quasi cessata, così come muore padre Paneloux, impotente testimone di centinaia di morti e quaresimalista di una teodicea affranta. Neppure Bernard Rieux, il medico più impegnato sul fronte sanitario, pensa mai di lasciare la città per raggiungere la moglie andata in un lontano sanatorio dove morirà di tubercolosi (il morbo di cui già da ragazzo è affetto Camus), convinto che ci sia un solo modo per essere santi senza Dio ed è quello di fare il proprio dovere.
Si delinea qui un aspetto dell’“uomo in rivolta” che costituirà presto il tema del pensiero camusiano fondato sulla coscienza contro ogni dogma o imperativo politico e religioso. Sicché la peste sottende il banco di prova che misura la vera natura umana e mette di fronte alla scelta tra la ricerca della felicità, che vuol dire scappare, e il richiamo del dovere, che vuol dire restare, anche a morire come in una guerra. Scrive Camus: «Così non c’erano più destini individuali, ma una storia comune costituita dalla peste e sentimenti condivisi da tutti. Il più forte era quello della separazione e dell’esilio, con tutto ciò che comportava in termini di paura e di rivolta». E allora quando Rambert, in procinto di andare via, dice a Rieux che il bene comune è fatto della felicità di ognuno, appare evidente nella condotta di Rieux come degli altri che, sebbene il giornalista dica il vero, è la rinuncia ad essa a formare quel bene. Di qui l’astrazione, che è cinica perché involge un rovescio della verità e una rivolta morale: se Rambert vuole che gli uomini vivano e muoiano per ciò che amano, la peste (dalla quale per Rieux l’uomo può uscire elevato) dimostra invece, ribaltando il teorema, che si debba vivere e morire per ciò in cui si crede, per un ideale dunque e non per un amore. Se il pubblico viene prima del privato, è la sfera pubblica che la peste colpisce, giuste le ultime parole del romanzo, che sono pari a una preconizzazione: «La peste avrebbe svegliato i suoi topi e li avrebbe mandati a morire in una città felice». Per renderla infelice. Ecco allora l’equazione camusiana: il dovere morale è un imperativo kantiano che è in contrasto con la felicità, per modo che lo si può adempiere a costo dell’infelicità.
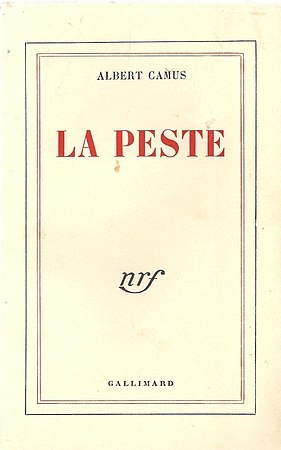 Ma, detto tutto ciò, La peste non manca di predittività: i “campi di isolamento” dove concentrare contagiati e primi sintomatici, le “formazioni sanitarie” di volontari simili a “guardie civiche” di assistenza e di controllo, l’idea di immunità di gregge che forse può spiegare la libertà di movimento in città, la fase di plateau uguale al picco, il calcolo quotidiano di contagi e decessi (che la prefettura sceglie di divulgare quotidianamente e non più ogni settimana così da fornire numeri più bassi), la presenza di uomini come gli infermieri e i seppellitori sempre disposti a sfidare la morte, gli autobus trasformati in mezzi per trasportare all’incenerimento i cadaveri, i funerali di fretta e di massa con la sola benedizione del prete nelle fosse comuni, le maggiori preoccupazioni per il calo dell’economia per cui «la miseria si dimostrò sempre più forte della paura», la comune sensazione che sotto il flagello dell’epidemia si viva confinati nel passato e che immaginare il futuro significhi infliggersi ferite – sono tutti elementi che l’esperienza del coronavirus ha riproposto all’umanità.
Ma, detto tutto ciò, La peste non manca di predittività: i “campi di isolamento” dove concentrare contagiati e primi sintomatici, le “formazioni sanitarie” di volontari simili a “guardie civiche” di assistenza e di controllo, l’idea di immunità di gregge che forse può spiegare la libertà di movimento in città, la fase di plateau uguale al picco, il calcolo quotidiano di contagi e decessi (che la prefettura sceglie di divulgare quotidianamente e non più ogni settimana così da fornire numeri più bassi), la presenza di uomini come gli infermieri e i seppellitori sempre disposti a sfidare la morte, gli autobus trasformati in mezzi per trasportare all’incenerimento i cadaveri, i funerali di fretta e di massa con la sola benedizione del prete nelle fosse comuni, le maggiori preoccupazioni per il calo dell’economia per cui «la miseria si dimostrò sempre più forte della paura», la comune sensazione che sotto il flagello dell’epidemia si viva confinati nel passato e che immaginare il futuro significhi infliggersi ferite – sono tutti elementi che l’esperienza del coronavirus ha riproposto all’umanità.
Insieme con essi abbiamo anche fatto prova di alcune grandi intuizioni avute da Camus: il progressivo contrasto tra l’incalzare della tragedia e l’interesse per le singole vite quotidiane, l’evenienza di una bella giornata per suscitare ottimismo, il pensiero più di galleggiare che di vivere, l’angustia dell’isolamento, l’indifferenza di fronte al sentimento della morte e l’incapacità di concepire un’ecatombe, tale da indurre Camus a suggerire di immaginare, perché si comprenda quanti siano diecimila cadaveri, una piazza piena di persone che escano da cinque cinema e che vengano uccise tutte insieme. E poi la più grande di tutte le intuizioni: la monotonia della peste, le cui “terribili giornate” sono simili a un “interminabile scalpiccio che annientava tutto al suo passaggio” e non a “fiammate sontuose e crudeli”, giornate fatte non di eroi né di fatti straordinari ma di un continuum senza storia, perché privo di vita, del quale non si vuole parlare né durante né soprattutto dopo, troppo acuto essendo il trauma da doverlo solo esorcizzare.
Ecco allora che uno dei personaggi centrali, Cottard il rentier, il solo contento della peste perché si arricchisce con il contrabbando, dice a Tarrou che la peste non viene a chi è già malato: «Supponga di avere un cancro serio o una bella tubercolosi, è impossibile che si prenda anche la peste o il tifo», per poi aggiungere: «Non si è mai visto un malato di cancro morire in un incidente d’auto». Uno scongiuro divinatorio e un paradosso elucubratorio: sennonché proprio Camus, malato di tubercolosi, morirà giusto in un incidente automobilistico, caso di cui per tutta la vita ha avuto angoscioso timore, laddove scrive che il caso (sul quale i suoi oranesi scommettono per scongiurare la peste) non appartiene a nessuno perché può colpire chiunque.
Gli oranesi sono quelli che Camus chiama “concittadini”, residenti di una città di cui egli non perde occasione per dire il male possibile e che sceglie come unico teatro della pestilenza, giacché nulla si sa di quanto accade nel mondo. Ma la “cronaca”, come la chiama, dei mesi dell’epidemia è riferita da un autore che è Camus, il quale affida il racconto a un secondo narratore solo alla fine rivelato in Rieux e indicato come la propria fonte. Un virtuosismo letterario quello di Camus: che si esprime in veste di autore rivolto ai suoi concittadini per riportare loro quanto il narratore ha lasciato scritto servendosi a sua volta di un’altra fonte, costituita dai taccuini lasciati da Tarrou (carnets che per conto suo Camus va da oltre dieci anni riempiendo di note e appunti destinati a essere pubblicati postumi), necessari perché Rieux possa dare conto di avvenimenti di cui non ha contezza diretta.
Il farraginoso espediente torna utile a Camus per sottrarsi a un’accusa di anticampanilismo che forse sente per i cattivi giudizi espressi sulla città e soprattutto dopo avere scritto un romanzo come Lo straniero dove certamente Orano non è apparsa neanche allora sotto una buona luce, avendo un narratore fittizio raccontato in prima persona di aver ucciso un arabo senza alcuna ragione, così allargando polemicamente il divario tra le due razze costrette a dividersi la stessa città. In La peste gli arabi non ci sono se non nel vago proposito di Rambert di descrivere la loro condizione sociale, perché evidente indice di una minorità o di una diversità. Ma c’è ancor meglio Orano, topograficamente più definita e richiamata intatta negli stessi atteggiamenti culturali come quello, proprio anche di Camus, di stare per lunghe ore affacciati al balcone per vedere la vita in strada. In La peste ci sono anche le terrazze panoramiche da dove osservare l’intera città anziché uno scorcio sotto casa, con in più l’immagine di un Rieux che si affaccia per verificare se la peste ha stravolto anche l’aspetto della città come ha cambiato i suoi abitanti. Quel che vede e sente è quanto Camus ha più volte vissuto da sé: Orano raggiunge Rieux «con i suoi mormorii, sentori di carne alla griglia, il brusio allegro e odoroso della libertà che piano piano riempiva la strada invasa da una gioventù chiassosa». La propria città si conosce quindi dal balcone di casa, sentimento che è di Rieux come è stato di Meursault, l’io narrante di Lo straniero, libro uscito cinque anni prima, nel 1942, e che con La peste forma un dittico oranese.
Lo stesso Camus li collega esplicitamente. Come autore rivolto ai suoi concittadini scrive infatti della peste avvenuta settant’anni prima a Canton e indica la data del 1871. Settant’anni dopo si arriva al 1941, l’anno che precede l’uscita de Lo straniero. Benché completato nel 1946 durante un viaggio negli Stati Uniti, La peste può essere stato dunque iniziato a ridosso del precedente romanzo, ma quel che è certo è la sua ambientazione nella Orano dello stesso anno. C’è il riscontro nella tabaccaia che parla di «un recente arresto che aveva fatto scalpore ad Algeri. Si trattava di un giovane impiegato che aveva ucciso un arabo in spiaggia». L’impiegato è Meursault, che è stato arrestato ma non ancora giustiziato, segno che nella finzione narrativa la peste si ha a Orano poco tempo dopo il delitto, tra l’arresto e la condanna a morte. La tabaccaia parla infatti di “recente arresto”, cosa che fa pensare che il processo (cioè la seconda parte de Lo straniero) non si è ancora aperto. Non può esserlo, perché comincia dopo undici mesi di istruttoria. Camus è stato molto attento nel rendere coerenti i due romanzi, ciò che porta a supporre che la peste appaia ad Orano nella primavera successiva al delitto sulla spiaggia (il quale cade in estate) ed esploda con il nuovo caldo. Da un’estate all’altra allora e da una canicola all’altra.
E come il caldo è stato il movente addotto da Meursault per spiegare l’”assurdo” delitto commesso, ancora il caldo è il propellente che scatena l’epidemia nel gioco di effetti del “pensiero meridiano” che regge la visione camusiana del mondo entro la quale ogni cosa succede, principalmente se negativa, per colpa del solleone. «Tutta colpa del clima» stabilisce il commissario de La peste per spiegare l’epidemia. E l’autore gli fa eco: «Il sole inseguiva i nostri concittadini ovunque e, se solo si fermavano, li colpiva». Il “sole della peste” alimenta «un fiume di caldo che scorre inarrestabile lungo gli alti edifici grigi» e «alle quattro del pomeriggio la città cuoceva a fuoco lento sotto un cielo opprimente. Era una di quelle ore in cui la peste diventava invisibile. Il silenzio, la morte dei colori e dei movimenti potevano essere quelli dell’estate come del flagello. Non si capiva se l’aria era densa di minacce o di polvere e di calore».
E forse a contrario è il caldo che culmina con l’epidemia in una sinestesia tragica, estenuante e ossessiva che non offre spiragli se non uno, quasi miracoloso: è il caso di Joseph Grand, il vecchio impiegato del Comune, sofferente di cuore e incaricato di tenere il conto dei decessi, che trascorre le sue sere solitarie provando a scrivere un libro e riscrivendone l’inizio come una Penelope alla tela, insoddisfatto delle parole. Il “narratore” lo elegge unico eroe della “cronaca”, perché pur a contatto con gli appestati e faccia a faccia con la peste non ha pensiero che per il suo romanzo e chiede consigli a tutti sui migliori termini da trovare perché un giorno i critici possano fargli “tanto di cappello”. Nel mondo che va in rovina, nel trionfo della morte, il vecchio Grand pensa alla letteratura ed è fermo alle prime parole. Camus non poteva immaginare antidoto migliore o vaccino più efficace: perché quando si ammala e Rieux lo dà per spacciato, il buon Grand è tra i pochi a guarire spontaneamente e torna al suo incipit. Ha vissuto l’infelicità per dare il suo contributo alla lotta contro la peste e rinunciato alla felicità perché vicino alla morte chiede che il manoscritto sia buttato nelle fiamme, ma la forza in un amore che è anche un ideale lo salva. Forse la scena più bella del romanzo è quella nella quale Grand legge a Riuex il suo manoscritto di una sola frase, quasi solfeggiando, mentre il dottore presta anche «orecchio a una specie di vago ronzio che in città sembrava rispondere al fischio del flagello». Il rumore di fondo e terrificante della peste che si alza contro il suono ispirato di un romanzo che nasce.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
[il nuovo romanzo di Gianni Bonina è: “Ammatula” (Castelvecchi) – di recente in libreria anche il volume: “Fatti di mafia” (Theoria)]
* * *
[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo



