
Delle Anime morte di Nikolàj Vasìl’evič Gogol’ non c’è epoca che manchi di parlare di capolavoro e che però sia concorde sul perché della sua grandezza. Sin dalla pubblicazione, il libro fu già in patria oggetto di dispute per via soprattutto dell’immagine che della Russia veniva offerta tra dileggio e denigrazione, fino al lapidario giudizio espresso dal potente critico Vissarion Grigor’evič Belinskij che ne negò – sbagliando clamorosamente – le possibilità di successo fuori dal Paese e ne vide le potenzialità solo in un contesto nazionale unicamente entro il quale fossero comprensibili logiche politiche e dinamiche di un tempo circoscritto e di una società chiusa: proprio alla quale in verità Gogol’ intese rivolgersi chiamandola allo specchio nei modi di un appello alla rinascenza, implicandosi personalmente con l’insistere per esempio in espressioni del tipo “da noi in Russia” e con l’assumere un ricorrente e persino rutilante tono moralista e tirtaico culminante al termine della prima parte nella figura della Russia trasfigurata in un “uccello trojka” che spicca un nuovo volo nel cielo nazionale. Volendo mostrare ai suoi connazionali la Russia messa a nudo, Gogol’ guadagnò invece l’attenzione dell’Europa rivelando all’estero non tanto un mondo poco conosciuto e tenuto in sospetto quanto uno stato sociale e una condizione storica appartenenti all’uomo nuovo nato dopo lo smaltimento della febbre napoleonica.
 La polemica riguardò anche la determinazione del genere letterario, che lo stesso Gogol’ contribuì invero a confondere scegliendo di chiamare “poema” quello che nei fatti è un romanzo: naturalista, si è detto, realista, ma anche picaresco, odeporico, allegorico, di denuncia, satirico, omerico, simbolista. Forse è tutto questo insieme, trattandosi di un libro mainstream che non si accontenta di una sola chiave, pretendendo di fornire ogni risposta alle domande del suo tempo e ponendo una questione relativa anche alle nuove forme narrative da adottare circa il superamento delle remore classiciste e la strada migliore da intraprendere nel percorso romantico appena inaugurato.
La polemica riguardò anche la determinazione del genere letterario, che lo stesso Gogol’ contribuì invero a confondere scegliendo di chiamare “poema” quello che nei fatti è un romanzo: naturalista, si è detto, realista, ma anche picaresco, odeporico, allegorico, di denuncia, satirico, omerico, simbolista. Forse è tutto questo insieme, trattandosi di un libro mainstream che non si accontenta di una sola chiave, pretendendo di fornire ogni risposta alle domande del suo tempo e ponendo una questione relativa anche alle nuove forme narrative da adottare circa il superamento delle remore classiciste e la strada migliore da intraprendere nel percorso romantico appena inaugurato.
Soltanto quando quasi un secolo dopo il connazionale Marc Chagall, illustrandone l’edizione francese, realizza acqueforti che stabiliscono a mezzo tra sogno e verità, evanescenza e concretezza, la prevalente natura delle Anime morte, l’opera gogoliana acquisisce finalmente il senso di apologo morale senza più pastoie naturalistiche e può liberarsi dell’egida russa che ancora oggi però continua a ipotecare il testo nel quale, contro davvero ogni prassi, tutte le traduzioni preferiscono mantenere le accezioni originali, cosicché abbondano termini come mužìk, kopejka, brička, bàtjuška, činovnik e molti altri che pure vantano congrui corrispettivi stranieri. Gogol’ continua perciò a pagare alla madrelingua (proprio lui che si diceva convinto di potere scrivere della Russia solo standone lontano) un pegno che più tardi nemmeno Tolstoj e Dostoevskij saranno chiamati a tributare, rimanendo nondimeno profondamente russi ma facendosi tuttavia universali: originalità di un autore che subito dopo Puskin apre la grande stagione letteraria russa e pur influenza anche la cultura europea, facendo proprie le principali istanze e le questioni che nel Vecchio continente aprono a metà dell’Ottocento orizzonti nuovi e inquietanti nel quadro di una contrapposizione di classe che presto il nascente socialismo esalterà in scontro. Ma l’idea di realismo di cui Gogol’ è portatore non ha nulla di drammatico, dal momento che attinge dai modi classici di Aristofane gli strumenti per stingere nella commedia le tensioni di una realtà che ha certamente tutti i motivi per apparire tragica. Una realtà che guardiamo come russa e vediamo come europea.
Si prenda in questa prospettiva un tema centrale nella ricerca gogoliana: l’arricchimento quale sinonimo di accaparramento e avidità materiale, che è l’odioso effetto del sistema di divisioni di classe in Russia ma anche il fomite della ribollente insorgenza proletaria. I possidenti che lo spregiudicato Pavel Ivànovič Čìčikov avvicina per avere in proprietà le loro “anime morte” (ovvero i nomi dei contadini che sebbene defunti risultano ancora iscritti nel registro del censimento da rinnovare e come tali provento di vantaggi da richiedere allo Stato in termini di finanziamenti e assegnazione di terre) integrano il modello di proprietario che è comune all’intero continente e che si ritrova anche in Italia. Nella novella di Verga “La roba” vediamo infatti ripetersi in Sicilia la stessa identica scena delle ampie terre coltivate, dei giardini e dei boschi che nella campagna russa vengono incontro a chi viaggia in carrozza e si chiede di chi siano. “Di Tentètnikov” è la pronta e replicante risposta in Gogol’, uguale a quella che in Verga rimanda più volte a Mazzarò, valendo a entrambe le latitudini e per tutt’e due gli autori così distanti la stessa cultura della proprietà latifondista cresciuta sul sacrificio innanzitutto dei contadini, servi della gleba in Russia e servi dei baroni in Sicilia.
E come Verga guarda la povera gente dall’alto della sua condizione sociale di privilegiato, concedendosi tutt’al più quell’“artificio della regressione” con il quale mutua il linguaggio dei “vinti” senza andare oltre l’umana commiserazione, anche Gogol’ si mantiene bene a distanza dai mužìki cui mai dà intenzionalmente e deliberatamente voce o offre una speranza di emancipazione, non indulgendo che a mera pietà nella sola occasione in cui Čìčikov presta loro attenzione ricordandoli in vita come essere umani. Ben lontano è allora il realismo russo prima maniera, auspice Gogol’, tutto votato alla conservazione dell’assetto sociale assolutista, da quello che in Francia e in Inghilterra, con Balzac, Zola e Dickens, dà nello stesso tempo tutt’altra prova sceverando in maniera sentita e partecipe il “ventre” delle città in mano capitalista: con la differenza che Gogol’, da buon raznočincy qual è, intellettuale non aristocratico della generazione anti-integralista ma filo-zarista pronta ad assumere il controllo culturale del Paese, non è ai nobili di Pietroburgo e Mosca che si unisce, bensì ai signorotti borghesi della sterminata steppa russa, i proprietari dei capoluoghi di governatorato che scimmiottano sì le mode delle grandi città ma si guardano bene dal rinunciare alla propria identità e diversità. Per Gogol’, non indifferente ai suoi natali di ucraino appartenente a una famiglia di nobili minori della “Piccola Russia”, la grande e santa Russia è nella sua campagna popolata di villaggi ognuno con un proprietario a capo di una corte di povere isbà traboccanti di braccianti al suo servizio. Nel confronto tra città e campagna sul quale Gogol’ prende posizione a favore della vita appartata, contemplativa e laboriosa, grazie alla quale il Paese prospera, la scelta coraggiosissima di ambientare una tale scomoda storia nell’entroterra depone da un lato per la prevalenza della tradizione ma da un altro per l’equivalenza di due sistemi sociali entrambi marci.
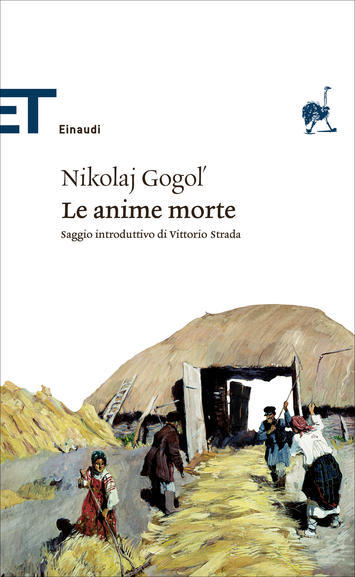 Di fatto è proprio nella sterminata pianura che la monarchia zarista cui Gogol’ è votato, tanto da predire l’inevitabile declino degli Stati Uniti d’America perché retti su basi democratiche, perpetua i fondamenti del proprio regime reazionario, sicché è solo nella sua dimensione storica e sociale che Čìčikov può mettere a segno lo stolido progetto di farsi dal niente anch’egli proprietario di un villaggio, lontano dall’ipotizzare un ideale programma di miglioramento della qualità della vita rurale che non sia finalizzato a un ulteriore incremento della propria ricchezza. In un romanzo realista francese, dove il lieto fine assicura l’espiazione delle colpe commesse, così ristabilendo l’ordine sociale turbato dall’ingiustizia, Čìčikov avrebbe pagato duramente le sue scellerate ambizioni, ma Gogol’ alla fine del primo volume lo lascia scappare perché in altre piccole città di provincia possa ancora reiterare i suoi misfatti, mentre al termine del secondo, nel superstite capitolo conclusivo, lascia che sfugga a una condanna già comminata alla deportazione in Siberia avvalendosi dei buoni uffici umanitari di galantuomini animati da un malposto spirito di redenzione non meno che delle brighe corruttive di un manigoldo della sua stessa pasta.
Di fatto è proprio nella sterminata pianura che la monarchia zarista cui Gogol’ è votato, tanto da predire l’inevitabile declino degli Stati Uniti d’America perché retti su basi democratiche, perpetua i fondamenti del proprio regime reazionario, sicché è solo nella sua dimensione storica e sociale che Čìčikov può mettere a segno lo stolido progetto di farsi dal niente anch’egli proprietario di un villaggio, lontano dall’ipotizzare un ideale programma di miglioramento della qualità della vita rurale che non sia finalizzato a un ulteriore incremento della propria ricchezza. In un romanzo realista francese, dove il lieto fine assicura l’espiazione delle colpe commesse, così ristabilendo l’ordine sociale turbato dall’ingiustizia, Čìčikov avrebbe pagato duramente le sue scellerate ambizioni, ma Gogol’ alla fine del primo volume lo lascia scappare perché in altre piccole città di provincia possa ancora reiterare i suoi misfatti, mentre al termine del secondo, nel superstite capitolo conclusivo, lascia che sfugga a una condanna già comminata alla deportazione in Siberia avvalendosi dei buoni uffici umanitari di galantuomini animati da un malposto spirito di redenzione non meno che delle brighe corruttive di un manigoldo della sua stessa pasta.
Gogol’ dunque insegna a Dostoevskij che un romanzo non deve essere edificante ed educativo e che, proprio come fa lui, un individuo losco come Čìčikov può assumere il ruolo di “nostro eroe” al di là di ogni significato antifrastico. Per Gogol’ l’eroe del suo poema è proprio un delinquente incallito e impunito, senza famiglia e senza scrupoli, proposto non come modello emulativo ma perché protagonista di “avventure” – secondo il titolo originario – chiamate a offrire una mappa dal vivo della Russia interna, dedita all’affarismo e preda della corruttela, attraverso la vicenda di un furfante (di qui l’elemento picaresco) che può realizzare il suo piano truffaldino solo perché si trova a che fare con autorità pubbliche e personalità private disposte ad essere gabbate, compiacenti e corrive. Non è dunque “l’eroe” del romanzo a profilare dei segni del decadimento una Russia che nessuno vuole vedere osservandola dalle grandi città, perché responsabile di esso è la classe provinciale al potere, così cinica, ottusa, perbenista e connivente.
La facilità (tutt’altro che verosimile e perciò voluta come mezzo di contrasto) con la quale Čìčikov avvicina i notabili, i cosiddetti činovniki, guadagnandone in molti casi l’amicizia e la collaborazione, è la volta dove Gogol’ associa lo sconosciuto forestiero alla cerchia dei migliori nomi dell’enigmatica città di N., salvo poi isolarlo e inimicargli l’intera società dabbene non perché smascherato dalla giustizia ma perché finito – ed ecco tutto Gogol’ – sulla bocca delle gentildonne che prima lo blandiscono e poi lo dileggiano avendolo visto in fregola per una ragazzina da collegio. Tra le due accuse che serpeggiano in città e consigliano infine Čìčikov a prendere il largo, quella falsa del rapimento della giovane fiamma sostenuta dalle dame e l’altra vera del malaffare delle anime morte ventilata dai gentiluomini, è la prima ad avere maggiore credito, mostrandoci così il Gogol’ dell’impresagito e del paradossale che nella sua interezza si fa riconoscere grazie a precisi elementi: il tagliente misoginismo (quello che spinge le donne «a mettere in subbuglio la città», riuscendo nell’impresa «in poco più di mezz’ora»); la caustica osservazione del provincialismo frutto del chiacchiericcio più pettegolo; l’invettiva contro il perbenismo ipocrita che induce certa società a preferire non conoscere la verità piuttosto che doverci fare i conti; il gusto dell’astrazione e l’iperbole nel quale anche i cavalli possono esprimere pensieri; la licenza della digressione che arriva ad accogliere il dettaglio anche irrilevante di una scena, come vista in un film (estremamente gogoliana la penna di gallina sulla schiena del registratore di collegio e statutiva l’enunciazione «L’autore ama essere circostanziato in ogni cosa»); l’uso del racconto onnisciente che permette di dominare i personaggi penetrandone la coscienza; e soprattutto il gioco combinatorio delle strutture narrative che fa delle Anime morte un metaromanzo direttamente riconducibile alla tradizione settecentesca di Fielding, Sterne e prima ancora di Rabelais e meglio di Cervantes.
Col Don Chisciotte i debiti sono più che scoperti: l’incastro ad episodi dell’intreccio, il viaggio senza meta lungo terre di periferia, il legame stretto tra narratore e lettori, sempre chiamati in essere, la sospensione del racconto a vantaggio della divagazione in occasione di un evento da compiersi e inutile da riportare, come nel caso in cui Čìčikov e Malanov percorrono un andito e Gogol’ ne approfitta per tracciare la figura del nuovo personaggio, la trasposizione dello scudiero Sancho Panza nel cocchiere altrettanto sciocco Selifàn, l’infatuazione inverosimile per la piccola figlia del governatore che ricorda Dulcinea e non ultima l’idea di comporre un poema in più volumi con spirito faceto, propositi cosmogonici e supponenza documentaristica, laddove Gogol’ si presenta come «storico degli eventi qui presentati».
Gioco tipicamente gogoliano di inganni è anche la commistione tra sincerità e motteggio, cosicché da un alto leggiamo che «l’autore si fa gran scrupolo di tenere occupati così a lungo i lettori con persone appartenenti a una classe bassa, sapendo per esperienza con quanta poca voglia essi facciano conoscenza coi ceti inferiori», così da spiegare l’attenzione indebita posta sui servi della gleba, e da un altro troviamo che «il giudizio contemporaneo non riconosce che sono egualmente meravigliose le lenti che contemplano gli astri e quelle che restituiscono i movimenti di invisibili insetti», affermazione che vuole giustificare la descrizione di scene riprovevoli e figure esecrabili come Čìčikov: prima preterisce l’argomento tabù della gleba e poi nobilita la stessa infima materia della miseria umana azionando uno spettro nel quale è difficile trovare il centro.
Nondimeno Gogol’ non può evitare il problema di coscienza che la figura di Čìčikov gli pone, dal momento che si chiede se fa bene a rivelarne ogni recesso più torbido dell’animo anziché limitarsi a raccontarne le azioni, in base alle quali in realtà apparirebbe a tutti un gentiluomo senza alcuna macchia, un vero eroe da romanzo romantico. Il problema lo risolve quando, alla fine del primo volume, si decide a raccontare la vita di Čìčikov e rivelare le ragioni per le quali compra anime morte, interrogativo che rimane per tutto il tempo sospeso tanto che lo solleva anche Anna Grigor’evna, moglie del procuratore. La decisione di Gogol’ è drastica: «È tempo alfine di attaccare al carro anche la canaglia. E dunque attacchiamola, questa canaglia».
La teoria per cui anche l’essere più abbietto merita il titolo di “eroe” e la sua dignità letteraria, ciò che significa che il brutto è artisticamente e aristotelicamente comunque bello, consente a Gogol’ di affrontare di petto un tema di fronte al quale la censura russa interviene con mano incerta, cassando per esempio l’intera storia del capitano Kopejkin, poi rifatta e recuperata dall’autore, epperò permettendo che sia reso pubblico un malcostume, quello della truffa allo Stato sui contadini censiti, che costituisce una grave colpa dello zar e mette la Russia sotto la peggiore luce. Gogol’ se ne rende conto giacché si chiede nello stesso romanzo cosa diranno gli stranieri, ma rimane fermo nel principio rousseauiano che la verità va detta tutta e non va fatta credere o taciuta. Quel che fa è di edificare un vasto e complesso teorema sulla natura dell’uomo virtuoso servendosi di elementi che conosciamo come pirandelliani nella differenza tra essere e apparire, vita e forma, maschera e nudità. Ma lo fa prima, scegliendo gli stessi strumenti dell’ironia e del paradosso, volgendo la tragedia in commedia e indicando la vis comica come rimedio contro i mali del mondo.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
[i nuovi libri di Gianni Bonina sono: “Un cuore per la signora Chimento” (Marlin editore); “Ammatula” (Castelvecchi); “Fatti di mafia” (Theoria)]
* * *
[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo



