
Per essere un romanzo destinato ai ragazzi, L’isola del tesoro conta troppi morti ammazzati e molti in circostanze volute per suscitare impressione. Il fondo splatter non aduggia tuttavia un libro che, come gli omologhi ambientati in un Settecento aperto alla conoscenza e alla Wilderness (da Robinson Crusoe a I viaggi di Gulliver a L’isola misteriosa, tutti intesi a esplorare il mondo, trovare terre nuove e isolate, mettere alla prova il coraggio e lo spirito di avventura), è un classico che offre ad ogni età e ad ogni rilettura nuove suggestioni. Letto da ragazzi, ci si identifica con Jim Hawkins, il giovane protagonista e io narrante, impavido e simpatico, mentre da adulti sono altri i motivi di interesse: i rapporti di forza tra il “partito della cabina” e quello della tolda, i rovesciamenti di ruolo, la condotta dei pirati, la caccia al tesoro sepolto, la morfologia dell’isola che Robert Louis Stevenson descrive nei dettagli, in ogni anfratto e ansa, nelle caverne e nelle colline, tanto da farsi a volte dispersivo e stucchevole solo per riuscire più credibile.
 Nondimeno chi non ha voluto essere su quell’isola, provando magari a immaginare dove sia, e trovarsi nella locanda dell’Admiral Benbow sulla costa inglese vicino Bristol, ancor più perché entrambe frutto della fantasia dell’autore, eppure così realistiche? Il segreto del romanzo è nella miscela che suggerisce di elementi spirituali e materiali: l’esplorazione del mistero terracqueo ai confini del mondo in un viaggio di tipo conradiano e la scoperta di una fortuna che cambia la vita. La prima è condotta nel segno dell’unità e del concorso di forze, sicché Long John Silver, il capo dei rivoltosi, può contenere l’ammutinamento fino all’approdo sull’isola, mentre la seconda si dipana in una corsa mortale e feroce alla ricerca del tesoro: al punto che alla fine il piccolo Jim, benché divenuto ricco e avuta la sua parte di oro, chiama maledetta l’isola e giura che non ci tornerà «nemmeno trascinato da un carro di buoi»: un modo piuttosto maldestro per deplorare la cupidigia umana, una volta che è stata soddisfatta.
Nondimeno chi non ha voluto essere su quell’isola, provando magari a immaginare dove sia, e trovarsi nella locanda dell’Admiral Benbow sulla costa inglese vicino Bristol, ancor più perché entrambe frutto della fantasia dell’autore, eppure così realistiche? Il segreto del romanzo è nella miscela che suggerisce di elementi spirituali e materiali: l’esplorazione del mistero terracqueo ai confini del mondo in un viaggio di tipo conradiano e la scoperta di una fortuna che cambia la vita. La prima è condotta nel segno dell’unità e del concorso di forze, sicché Long John Silver, il capo dei rivoltosi, può contenere l’ammutinamento fino all’approdo sull’isola, mentre la seconda si dipana in una corsa mortale e feroce alla ricerca del tesoro: al punto che alla fine il piccolo Jim, benché divenuto ricco e avuta la sua parte di oro, chiama maledetta l’isola e giura che non ci tornerà «nemmeno trascinato da un carro di buoi»: un modo piuttosto maldestro per deplorare la cupidigia umana, una volta che è stata soddisfatta.
La differenza con i romanzi di Defoe e di Swift di un secolo prima e con quello pressoché concomitante di Verne, tutti legati a navi che salpano e arrivano in isole sconosciute affrontando peripezie nell’ignoto, è nella natura del nemico da fronteggiare. In L’isola del tesoro il nemico non è un estraneo – l’arcano naturalistico trovato da Crusoe, l’immaginifica popolazione di lillipuziani, gli enigmi nascosti ai coloni dell’isola Lincoln – ma il lato oscuro della stessa comunità, la parte rovesciata dell’uomo che si ribella alla coscienza civile, al patto sociale, alla legge, per perseguire un vantaggio terreno, il fine della ricchezza.
Questo dissidio pone la lotta sottesa al viaggio di ricerca o di scoperta non tra civilizzazione e primitivismo ma tra bene e male, all’interno quindi della stessa condizione umana, vista come teatro di lacerazioni e fonte del Doppelgänger in presenza di un’utilità da fare propria. Il romanzo d’avventura destinato ai ragazzi, capace di spronare le migliori intenzioni e fortificare il carattere, diventa così un testo di riflessione e di denuncia circa il divenire umano e il progresso civile in un’epoca segnata da grandi conquiste scientifiche, alle quali non a caso Jules Verne ha appena dedicato la trilogia del capitano Nemo culminata ne L’isola misteriosa; diventa cioè un mezzo d’indagine che da vicino richiama il romanzo forse maggiore di Stevenson e di qualche anno successivo, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, dove lo sdoppiamento di personalità costituisce l’estrema ratio dell’infingardaggine del capitano Silver, cuoco e pirata, e della sua ciurma viscida e malfidata.
Probabilmente Stevenson, recuperando racconti di mare del padre e trovandosi a vivere a Bristol, mitico porto per grandi traversate, non si rese nemmeno conto – visto lo stile elementare del romanzo – di scrivere un libro che, narrando una storia di pirati e gentiluomini tutti assetati di ricchezza, in realtà componeva un apologo morale e filosofico sulle bassezze dell’uomo di ogni ceto attratto dall’oro e pronto a sopraffare il suo simile pur di averlo. Il pirata è per Stevenson il lupo di Hobbes, il predatore che il lusso rende incivile. Forse per questo, pur scrivendo quasi alla fine dell’Ottocento, Stevenson sceglie il Settecento più esotico e selvaggio dei corsari e dei filibustieri e non tiene conto di alcuna political correcteness nella sua visione manichea che divide buoni e cattivi: da un lato i pirati che tali si rivelano in vista del tesoro e da un altro i gentiluomini che, pur motivati dalla stessa bramosia e in viaggio per dissotterrare il tesoro di capitan Flint, sembrano mossi da intenti fatti per realizzare ideali edificanti di affermazione sociale mentre non rispondono in verità che agli stessi infimi istinti dei bucanieri da loro assoldati.
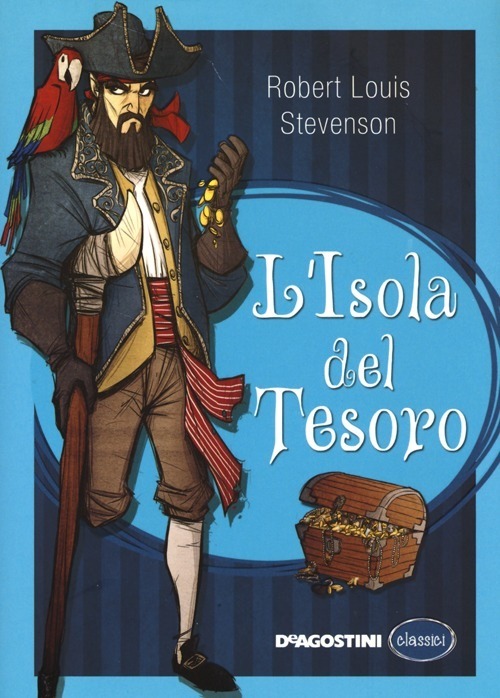 Il cavaliere Trelawney, il dottor Livesey e il comandante Smollet formano il partito al potere, del tutto legittimati perciò a mettere le mani sulla “cassa del morto”, contrariamente ai pirati che pure sono stati al servizio di Flint, il capo che ha nascosto il tesoro sull’isola: e legittimati perché quella che compiono in nome della società civilizzata è una confisca di beni rapinati alla stessa società dabbene da manigoldi buoni per la forca e indegni di qualsiasi considerazione. Alla fine, quando John Silver si consegna e poi sparisce con una manciata di oro, quel che Jim scrive è che tutti furono «contenti di essersi sbarazzati di lui così a buon mercato». Il patto sarebbe stato di non consegnarlo al carnefice ma di lasciarlo andare libero, cosicché per non mantenerlo e non votarsi all’impunità del misfatto scellerato Stevenson lo fa scappare di soppiatto, non mancando però di sottolineare, a sua definitiva condanna morale, che avrebbe avuto «poche probabilità di trovare la felicità in un altro mondo».
Il cavaliere Trelawney, il dottor Livesey e il comandante Smollet formano il partito al potere, del tutto legittimati perciò a mettere le mani sulla “cassa del morto”, contrariamente ai pirati che pure sono stati al servizio di Flint, il capo che ha nascosto il tesoro sull’isola: e legittimati perché quella che compiono in nome della società civilizzata è una confisca di beni rapinati alla stessa società dabbene da manigoldi buoni per la forca e indegni di qualsiasi considerazione. Alla fine, quando John Silver si consegna e poi sparisce con una manciata di oro, quel che Jim scrive è che tutti furono «contenti di essersi sbarazzati di lui così a buon mercato». Il patto sarebbe stato di non consegnarlo al carnefice ma di lasciarlo andare libero, cosicché per non mantenerlo e non votarsi all’impunità del misfatto scellerato Stevenson lo fa scappare di soppiatto, non mancando però di sottolineare, a sua definitiva condanna morale, che avrebbe avuto «poche probabilità di trovare la felicità in un altro mondo».
L’autore non vuole minimamente derogare al codice vigente della supremazia della classe borghese ispirata alla migliore coscienza perbenista e dà al suo romanzo “per ragazzi” uno svolgimento che oggi definiremmo diseducativo e che non ritroveremmo in nessun film né in un racconto: anziché fallire nell’intento di trovare il tesoro e arricchirsi, così da mostrare vano ogni misero tentativo di trovare facile e rapace fortuna nella vita, i gentiluomini tornano straricchi e, quel che è peggio, incassando e dividendo tra loro fino all’ultima moneta, mentre di «una abbondante parte del tesoro» gode anche Jim Hawkins che però non ci dice l’uso che ne farà. Il giovane lettore, nell’ottica stevensoniana, è chiamato perciò a rallegrarsi del “lieto fine” dell’avventura ed è autorizzato a sognare di viverla quando una buona formazione lo indurrebbe a imparare come rifuggire occasioni propizie accaparrando refurtiva.
Quando Stevenson si addice ad esaltare le nobili gesta dei gentiluomini di Bristol – un armatore, un medico-magistrato e un probo comandante di golette – si pone la questione di chi debba essere il narratore che racconti l’avventura. Pensando a un romanzo per ragazzi, com’è chiaro nella dedicatoria iniziale al “saggio giovanetto”, trova che la voce narrante debba essere quella del più piccolo della compagine, il figlio dei locandieri dell’Admiral Benbow che viene imbarcato come mozzo quando, dopo la morte del padre, la sua presenza nella locanda sarebbe indispensabile alla madre frastornata. Scelta astuta: l’io narrante libera l’autore da ogni responsabilità diretta e i fatti sono affidati a un diario terzo; inoltre la testimonianza bianca rende non solo più vera la storia ma soprattutto la legittima, sebbene appaia evidente che l’avventura sia narrata a distanza di tempo da un Jim probabilmente diventato adulto e resipiscente, giacché per giustificare gli spropositi commessi scrive: «Ero soltanto un ragazzo e avevo preso la mia decisione» e ancora: «Ero sciocco e stavo per compiere un gesto stolto e imprudente».
Tuttavia non è al tempo della scrittura che rifacciamo la nostra immedesimazione di lettori giovani, ma a quello della narrazione, così da condividere le emozioni dello spericolato adolescente, mentre da lettori maturi siamo attenti a cogliere imperfezioni e superficialità che ci pongono in un atteggiamento critico nei confronti di Stevenson e delle sue ingenue trovate narrative. Quelle che da ragazzi ci erano infatti sembrate scene mozzafiato, tali da impedirci di condividere con l’autore l’opinione che si trattasse di “idee pazze”, in realtà si mostrano negli anni della rilettura come grossolane banalità: il piccolo Jim che scopre il complotto solo perché si trova nel fondo del barile delle mele e poi nella radura ascolta per caso quanto a distanza si dicono Silver e Tom, finché da solo sulla piroga finisce in balia della marea che lo porta nottetempo alla goletta di cui riesce persino a impossessarsi, nonché il Jim delle altre circostanze fortuite (il possesso della mappa, l’incontro con Ben Gunn, il rientro nel fortino occupato dai pirati, la rocambolesca salvezza…) che lo vedono ammirabile protagonista, non esita che ingenuità narrative di cui lo stesso Stevenson si rende ben conto se parla di “idee non del tutto sane” riferendosi alle intraprese del mozzo. Ma non può fare diversamente dopo aver deciso di raccontare l’avventura tenendo Jim sempre sulla scena. Sennonché a un certo punto si trova nell’impasse: Jim ha lasciato la nave e si trova sull’isola dove incontra Ben Gunn, un pirata abbandonato da Flint e sopravvissuto per tre anni. Non può dunque conoscere i rivolgimenti a bordo, lo sbarco a terra e il riparo nel vecchio fortino, ma Stevenson ha bisogno di raccontarli, anche per preparare la sorpresa che nel finale attende proprio Jim, ignaro degli sviluppi circa l’accordo con i pirati, la cessione a loro della mappa, il recupero già avvenuto del tesoro. E allora cosa fa? Cambia voce narrante e per i primi tre capitoli della quarta parte lascia che il narratore non sia più Jim ma il dottore Livesey. Il quale non si capisce quando scrive, né sappiamo come il suo racconto finisca per integrare quello del mozzo che pure proprio all’inizio è stato chiaro: «Richiesto dal cavalier Trelawney, dal dottor Livesey e dal resto della compagnia di narrare dal principio alla fine tutto ciò che si riferisce all’isola del tesoro…». Non siamo quindi nell’ambito del manoscritto ritrovato che può prestarsi a più voci, ma del diario di bordo a voce unica per modo che non si spiega come quanto narrato dal principio alla fine da Jim comprenda anche il testo di Livesey, annunciato nondimeno da epigrafi del tipo “Il racconto è proseguito dal dottore” e “Continua il racconto del dottore”. In realtà il racconto non continua perché il dottore ne comincia un altro, complementare al primo.
A Stevenson viene concessa simile incongruenza in forza del genere per ragazzi cui appartiene il romanzo. Che però si espone a un severo sindacato di coerenza e verosimiglianza. Così acribitico nella descrizione della nave tra ombrinali e impavesata, altrettanto dell’isola di baie e paludi, l’autore si fa del tutto superficiale nella strutturazione del romanzo, ciò che suppone una stesura estemporanea non organizzata né fondata su una sinossi stabilita. Robinson scrive a vista di scena e quel che in realtà richiede al suo lettore-modello è di esercitare la sospensione dell’incredulità, che cioè si renda credulo e insieme con le inverosimiglianze di fatto consideri romanzesche anche quelle di forma, da accettare al pari di altrettante “idee pazze”. Il procedimento invenzionale di scena dopo scena risponde comunque a una composizione che tiene conto di due sfere: quella di terra e l’altra di mare. L’avventura parte, secondo il canone, dai preparativi della spedizione e ancor prima dalle movimentate schermaglie attorno alla locanda dell’Admiral Benbow per il recupero della mappa del tesoro, dopodiché continua sulla Hispaniola per svolgersi poi nuovamente sulla terraferma entro il perimetro dell’isola. Nel passaggio da un teatro all’altro Stevenson è attento a dosare gli sviluppi nella logica dell’intrigo e l’evoluzione dei caratteri in funzione dei cambiamenti: il comandante Smollet, che dapprima non convince l’armatore, si rivela anche a lui un valente navigatore e un’autorità affidabile; il dottor Livesey dà prova di abile stratega; il cavaliere Trelawney passa da chiacchierone e facilone proprietario di nave ad accorto capo-spedizione e pugnace combattente; la ciurma si va dividendo tra fedeli e ribelli nella prospettiva che i primi sono marinai e i secondi pirati; Long John da fido capo cuoco si trasforma nel primo dei pirati per poi tornare ad essere arrendevole e inerme servo; Ben Gunn da impenitente selvaggio diviene collaborativo e generoso alleato contro i vecchi compagni di corsa; e infine Jim Hawkins da aiuto locandiere si fa mozzo circospetto e curioso, poi solitario trapper in un’isola sconosciuta, quindi intrepido ranger e infine meticoloso scrittore. A lui è affidato il compito di tenere uniti i campi, godendo della benevolenza dei gentiluomini come della simpatia dei pirati, in maniera che, stando in mezzo, toglie agli uni e agli altri parte della loro natura per cui questi e quelli ci appaiono in qualche modo sfigurati, i gentiluomini in taccia di avidi rapaci e i pirati nelle grinze di monelli ubriaconi che fanno meno paura come minore stima adducono i signori della cabina.
Jim è il giovincello di scoglio attaccato alla sottana della madre che il mare aperto tramuta in uomo pronto a rischiare la vita per mettere le mani sul tesoro del valore di settecentomila sterline d’oro, per nulla colto dallo scrupolo di aver commesso un atto che è anch’esso di pirateria. Né Stevenson dà peso a questi aspetti. Ha già deciso che il tesoro deve finire nelle tasche dei ricchi, così condannando all’insuccesso la pirateria e con essa en travesti l’illegalità del proprio tempo. Se ne prende anche gioco canzonando i bucanieri quando, a due passi dal nascondiglio vuoto, li atterrisce con una voce che essi credono dell’oltretomba e li rende preda di impresagiti spettri davanti a uno scheletro e a una Bibbia malauguratamente strappata. Da eroi tratta invece i vincitori e i possessori del tesoro, che fa salpare dall’isola con la bandiera britannica pavesata e in Messico fa incontrare piacevolmente a cena con gli ufficiali di una nave da guerra inglese per poi farli tornare in festa e tutti vivi finalmente a Bristol. Quanto ai pirati, ne sono rimasti in vita solo tre e sono stati lasciati dai gentiluomini a marcire sull’isola con qualche scorta di viveri. Esattamente come la ciurma del capitano Flint aveva fatto con Ben Gunn: a chiudere un cerchio entro il quale buoni e cattivi sono alla fine la stessa cosa.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
* * *
[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo



