
Il naufragio di Robinson Crusoe è il più desiderabile, tale da poter essere considerato l’antecedente storico delle odierne trasmissioni Tv di survival dove i concorrenti sono chiamati ad affrontare prove di sopravvivenza nella certezza di ogni comfort. Robinson capita in un’isola lussureggiante, ricca di acqua e di risorse, priva di belve feroci e di ogni tipo di insidia naturale, dotata di un clima tropicale che la preserva dal freddo, tanto grande da potere essere percorsa a piedi e comodissima per le numerose opportunità che offre, compreso un terreno dove coltivare addirittura il grano. Non solo: ha l’impagabile fortuna che la nave naufragata si areni con tutto il suo carico a portata di zattera e che una seconda nave faccia la stessa fine e gli consenta così nuovi approvvigionamenti. Ha armi e polveri con cui cacciare, derrate alimentari, conserve, liquori, utensili, tessuti, vestiti e ogni altro mezzo necessario a chi debba vivere in un luogo non antropizzato: ciò che non riesce ai naufraghi spagnoli finiti in un’isola vicina e, perché privi di tutto, soggetti al dominio dei selvaggi in un impronosticato rovesciamento di poteri.
Un naufragio tipicamente inglese quello di Robinson che piacque infatti molto ai connazionali di Daniel Defoe, determinato a mettere i lettori di fronte alla natura meno minacciosa e oscura, anzi la più irenica ed edenica, testimoniale della creazione divina. L’autore che, esattamente trecento anni fa, inaugurò il romanzo moderno come oggi lo conosciamo intese non terrorizzare i lettori britannici rappresentando l’incubo di una morte lenta e inesorabile che giungesse per le privazioni indotte dalla forza primordiale della natura, ma al contrario volle dimostrare loro quanto la stessa natura risulti benigna all’uomo che si affidi alla Provvidenza. Il tema al centro del dibattito filosofico settecentesco circa lo “stato di natura” nel quale l’uomo sia visto agire senza i condizionamenti moderni viene da Defoe affrontato con un romanzo che, indulgendo a un tono a volte predicatorio e un po’ quaresimalista, più esattamente intriso di quel puritanesimo che l’autore professò in atteggiamento anti-cattolico, dà una risposta soterica nella prospettiva di una salvezza celeste e di una regolazione cosmica del destino umano che guarda non allo stato di natura illuministico come esperimento teista delle qualità innate nell’uomo, ma alla natura dell’uomo nel rapporto di scambio con Dio. «Invocami nel giorno del dolore e io ti libererò e tu mi glorificherai» è il passo biblico che Robinson assume come un credo nelle proprie azioni e motivo della sua condizione.
 Defoe dota il suo eroe di tutti i caratteri necessari alla redenzione entro una linea ascensionale che lo porta da uno stato di disinteresse verso Dio alla sua progressiva scoperta e accettazione fino a una totale immedesimazione in esso: e ciò in una chiave spinoziana, dello Spinoza cioè che nell’invocazione dell’uomo a Dio vede il soccorso nel momento del bisogno, tant’è che Crusoe pensa per la prima volta a Dio e ne chiede l’aiuto quando si ammala e teme di morire. Sennonché quella che per Spinoza è sola superstizione, per Defoe diventa Provvidenza, prova ontologica. Non si può invero leggere il romanzo fuori dalla vena trascendentalistica che lo irrora e lo giustifica, ignorando il fondo teofanico che lo sostiene insieme con la polemica anti-cattolica.
Defoe dota il suo eroe di tutti i caratteri necessari alla redenzione entro una linea ascensionale che lo porta da uno stato di disinteresse verso Dio alla sua progressiva scoperta e accettazione fino a una totale immedesimazione in esso: e ciò in una chiave spinoziana, dello Spinoza cioè che nell’invocazione dell’uomo a Dio vede il soccorso nel momento del bisogno, tant’è che Crusoe pensa per la prima volta a Dio e ne chiede l’aiuto quando si ammala e teme di morire. Sennonché quella che per Spinoza è sola superstizione, per Defoe diventa Provvidenza, prova ontologica. Non si può invero leggere il romanzo fuori dalla vena trascendentalistica che lo irrora e lo giustifica, ignorando il fondo teofanico che lo sostiene insieme con la polemica anti-cattolica.
Alla fine del suo lunghissimo naufragio, Crusoe rinuncia infatti a vivere in Brasile dove pure possiede una ricca piantagione, che finisce anche per vendere, solo perché non è cattolico, sicché sceglie di stabilirsi nella sua “dissenziente” Inghilterra. Si intestardisce a convertire al cristianesimo Venerdì, il selvaggio che adotta e che obbliga a chiamarlo “padrone”, ma in direzione del suo protestantesimo. E senz’altro è lo spirito calvinista a fondare La vita e le strane sorprendenti avventure di Robinson Crusoe di York, marinaio, nell’ottica severissima di una distinzione di classe, di una vita retta sulla laboriosità, l’operatività, i meriti, l’attività industre e ogni negazione di qualsivoglia idea di politcal correcteness. Quando si decide ad attaccare i cannibali, che sulla spiaggia si preparano a uccidere e mangiare un prigioniero, prima ci ripensa in nome di una libertà di costumi che riconosce ai selvaggi incolpevoli per cui affida a Dio il compito di punirli, ma poi diventa una furia alla scoperta che il prigioniero è un bianco come lui e compie una strage di indigeni.
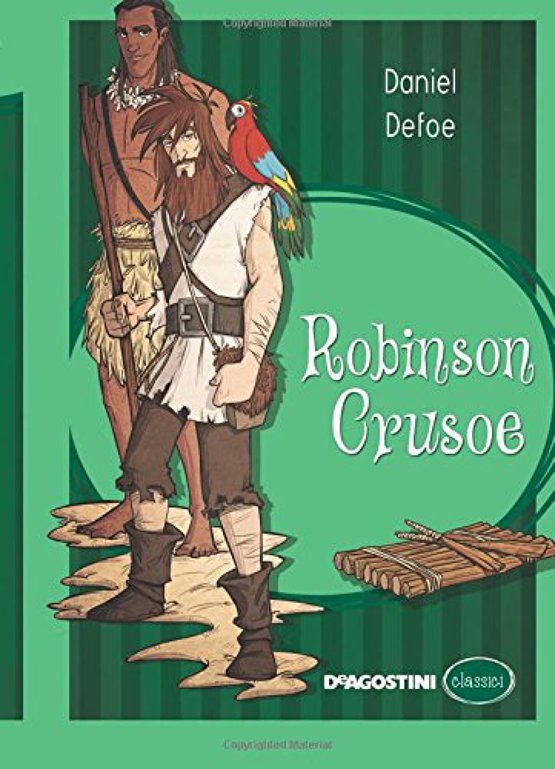 Romanzo perciò calvinista fino all’approvazione dello schiavismo e del razzismo, Robinson Crusoe è tutt’altro che un libro per ragazzi. Insegna a non usare eufemismi (mai “eliminare” o “abbattere” ma sempre “ammazzare”), a sterminare gatti, a uccidere animali secondo la loro commestibilità e non seguendo principi ecologici – dunque capretti cacciati a volontà e testuggini sparate per avere le loro uova) – a chiamare “selvaggi” gli indigeni, a vituperare le scelleratezze dei conquistadores spagnoli anche perché “cattolicissimi”, a vedere il cristianesimo nelle forme di una religione messianica ed epifanica della Rivelazione, senza Chiesa né santi né Madonne di cui impetrare l’intercessione. Nei ventotto anni che trascorre sull’isola caraibica, arcipelago oggi meta di un turismo d’élite che esalta quelle bellezze paesaggistiche e naturalistiche da Robinson del tutto ignorate (dalle spiagge dorate al mare cristallino, dai tramonti infuocati alle albe radiose: fenomeni che Defoe non poteva descrivere non avendoli visti, ma che non si sforzò nemmeno di immaginare), il naufrago inglese dà prova che l’uomo allo stato di natura («Io ero ridotto a uno vero stato di natura» scrive a un certo punto il narratore, ovvero lo stesso Robinson una volta salvo) può riuscire a realizzare forme di vita accettabili e surrogato di quelle civili, ma può farcela solo con l’assistenza di Dio: proprio alla cui opera Crusoe attribuisce il miracolo del germoglio del grano dopo che accidentalmente, ovvero guidato da Dio, aveva gettato via dei semi. Robinson definisce la sua vita «un mosaico della Provvidenza» e non esita mai a parlare di miracoli, a vedere in ogni gesto e in ogni evento la mano del Signore e a professare una dottrina della fede che è nel suo caso anche di salvezza fisica.
Romanzo perciò calvinista fino all’approvazione dello schiavismo e del razzismo, Robinson Crusoe è tutt’altro che un libro per ragazzi. Insegna a non usare eufemismi (mai “eliminare” o “abbattere” ma sempre “ammazzare”), a sterminare gatti, a uccidere animali secondo la loro commestibilità e non seguendo principi ecologici – dunque capretti cacciati a volontà e testuggini sparate per avere le loro uova) – a chiamare “selvaggi” gli indigeni, a vituperare le scelleratezze dei conquistadores spagnoli anche perché “cattolicissimi”, a vedere il cristianesimo nelle forme di una religione messianica ed epifanica della Rivelazione, senza Chiesa né santi né Madonne di cui impetrare l’intercessione. Nei ventotto anni che trascorre sull’isola caraibica, arcipelago oggi meta di un turismo d’élite che esalta quelle bellezze paesaggistiche e naturalistiche da Robinson del tutto ignorate (dalle spiagge dorate al mare cristallino, dai tramonti infuocati alle albe radiose: fenomeni che Defoe non poteva descrivere non avendoli visti, ma che non si sforzò nemmeno di immaginare), il naufrago inglese dà prova che l’uomo allo stato di natura («Io ero ridotto a uno vero stato di natura» scrive a un certo punto il narratore, ovvero lo stesso Robinson una volta salvo) può riuscire a realizzare forme di vita accettabili e surrogato di quelle civili, ma può farcela solo con l’assistenza di Dio: proprio alla cui opera Crusoe attribuisce il miracolo del germoglio del grano dopo che accidentalmente, ovvero guidato da Dio, aveva gettato via dei semi. Robinson definisce la sua vita «un mosaico della Provvidenza» e non esita mai a parlare di miracoli, a vedere in ogni gesto e in ogni evento la mano del Signore e a professare una dottrina della fede che è nel suo caso anche di salvezza fisica.
A una coscienza illuminista questa ottica non può piacere che a metà, per la parte che rende l’uomo capace di ricostruire da solo il mondo, ma a una cultura protestante fa da fertilizzante perché riecheggia le predicazioni dei pastori che indicano nell’affidamento a Dio il solo mezzo dato all’uomo per salvarsi. Defoe soddisfa entrambe le istanze e coglie perciò il gradimento degli ambienti più avvertiti della società del suo tempo, ma la sua azione è dimezzata: quanto all’aspetto religioso accende un’avversione del tutto indebita contro il cattolicesimo (dopotutto è nelle acque brasiliane che trova la sua isola ed è in Brasile che porta Crusoe a fare fortuna) e quanto all’uomo primitivo di tipo rousseauiano, riportato allo stato di natura, il mondo che ricrea Robinson è un analogon di quello che ha lasciato: sin dal primo momento è l’apparato della civiltà europea, particolarmente inglese, che il naufrago vuole rifare, procedendo secondo un criterio che è alla base della cultura economica: parte dal provvedersi del necessario, quindi passa a dotarsi dell’utile e infine pensa al voluttuario.
Invece di dedicarsi a una vita contemplativa, fatta magari di raccoglimento e di riflessione, scrivendo magari un libro (ma il giornale che compila, fino a quando ha inchiostro disponibile, è pressoché un diario), si dà a determinare condizioni di vita che non siano quelle dell’isola: anziché confarsi ad essa assimilandosi alla natura, è l’isola che si impegna morfologicamente a modificare costringendola ad assumere un modello di cultura occidentale. Del quale conserva sia i giudizi che i pregiudizi. Sa per esempio che quelle regioni sono infestate di selvaggi e ne ha dunque il terrore, dichiarandoli nemici mortali. Quando dopo quindici anni scopre sulla sabbia un’impronta umana e capisce che non è solo nell’isola, la sua placida esistenza cambia. In peggio anziché in meglio. Se non fosse gravido di preconcetti verso i nativi, andrebbe alla loro ricerca con animo fiducioso, come farebbe certamente al suo posto uno dei tanti missionari cattolici che percorrono il continente per evangelizzare, invece scappa e si prepara alla guerra: che farà eccome, esattamente come il più brutale armigero spagnolo. Piuttosto che cercare di conoscere anche quel dato di natura costituito dalla presenza umana, si rintana nella sua condizione di occidentale prevenuto, pronto a una sortita nella tribù dei selvaggi al solo scopo di catturarne qualcuno e farlo proprio schiavo, cosa che gli riuscirà salvando Venerdì dall’essere arrostito, senza però renderlo libero né tantomeno farselo amico.
Si ricrederà quando Venerdì lo rassicurerà che il suo popolo non lo divorerà, scoprendo nello stesso tempo che anche i selvaggi hanno sentimenti, emozioni, idee e una loro cultura: ma ciò non basterà a Defoe per fare del suo eroe un uomo nuovo, aperto al Terzo mondo. Non può dopotutto perché tempus regit actum. Il romanzo va infatti giudicato in base al tempo in cui fu scritto e non a quello in cui viene letto. E tuttavia oggi continua tutt’oggi ad essere ritenuto un apologo della simbiosi tra uomo e natura che in verità non c’è nell’avventura di Robinson, il quale da occidentale irriducibile il problema che si pone e che risolve è quello di assoggettare la natura al suo servizio.
Privo di ogni ideale ambientalista, Robinson appare dunque a noi nel sembiante di un selvaggio non diverso da quelli che egli disdegna, un uomo del suo tempo, fatto di sortilegi e inquisizioni, barbarie e divisioni razziali, nulla affatto “ridotto in un vero stato di natura” perché non inventa alcunché di quanto appartenga al suo arsenale di mezzi materiali e al patrimonio di manufatti, ma tutto rifà ricordando come procedere o intuendone il modo. E lo fa come un vero uomo primitivo, sia pure privilegiato: comincia come raccoglitore-cacciatore e poi si muta in allevatore-agricoltore, evoluzione documentata nell’uomo delle caverne ma del tutto improbabile in un uomo del Settecento che, trovandosi in un’isola deserta sapendo di doverci rimanere, non fa trascorrere una decina di anni prima di pensare di addomesticare le capre e di coltivare un terreno certamente ubertoso. Si è che Defoe vuole vedere all’opera il borghese del suo tempo, rappresentante della classe media mercantile ed emergente, perché possa dimostrare di sapere padroneggiare anche un mondo ostile qual è quello a trazione aristocratica in cui si dibatte e che nel romanzo prende i contorni di un’isola selvaggia e “orribile”.
Anche Robinson è dunque un “civilizzatore”, meglio un conquistatore, tant’è che si dichiara “governatore” dell’isola e si atteggia a suo signore anche quando la lascia in circostanze fatte perché sia restaurato il sistema dominante occidentale, ovvero in occasione dell’ammutinamento di una nave ovviamente inglese e della battaglia per riconquistarla al fianco del comandante, come sarà del resto per L’isola del tesoro. Va via e abbandona il gruppo di spagnoli nonché il padre di Venerdì cui ha pur promesso la liberazione, i primi perché spagnoli e l’altro perché selvaggio, tornando così ad essere il tipico europeo, peraltro ricco, che altri obiettivi non persegue se non i propri, per nulla pentito in ventotto anni di avere accettato di guidare una spedizione per nave in Africa, causa del naufragio, nel proposito di comprare schiavi per il Sudamerica.
Ma prima di essere il padrone dell’isola, comando che conquista negli ultimi tre anni dopo l’incontro con Venerdì, Robinson è per un quarto di secolo un costruttore, anzi un ricostruttore del mondo che ha perduto. Quando scopre l’impronta umana che gli cambia la vita, perché dal vagheggiare progetti voluttuari, per ultimo la produzione di birra dopo aver appena finito di costruire un tavolo e una sedia per mangiare e scrivere comodamente, passa a concepire solo disegni che riguardino la sua sicurezza dallo straniero (ancorché il vero straniero sia proprio lui), Crusoe è un uomo per nulla contrario a vivere per sempre nella sua isola, se solo riuscisse ad avere con sé un altro essere umano con cui parlare. Lo trova, ma è un selvaggio, che schiavizza e porterà con sé al momento in cui ha l’opportunità di tornare nel mondo civile, dimentico del progetto di rimanere nel suo regno. Che fa conoscere, anche nelle fasi della sua realizzazione, ai soli signori connazionali e non anche al mercante spagnolo che pure ha salvato, perché è agli occhi inglesi che vuole brillare, che è quanto in fondo lo stesso autore si prefigge nella sua vorticosa e chiacchierata vita politicamente ondivaga e moralmente spregiudicata. Defoe incassa a questo modo il plauso anche di Virginia Woolf che parla di capolavoro e di capostipite e che pure coglie gli aspetti materiali del romanzo giacché propone di Robinson e dunque di Defoe l’immagine di un avventuriero cui interessa solo “la pignatta di terracotta”, per dire dell’intento tutto concreto e realistico posto alla base di ogni intrapresa.
È stata questa natura sospesa tra Dio e Satana, bene e male, un po’ gnostica e molto puritana, ad avere conquistato i lettori di ogni tempo, non solo illuministico ma anche romantico: per ogni stagione il romanzo si offre infatti nella sua veste congeniale, pur con le sue incognite e le perplessità. Visto il successo, nello stesso 1719 Defoe pubblica currenti calamo il seguito che intitola “Ulteriori avventure”, ma il pubblico non vuole più sapere di Crusoe tornato per mare, perché era la sua condizione di naufrago solo e remoto che lo aveva entusiasmato e non quella di ricco borghese appassionato di viaggi. Il primo romanzo non termina infatti con il ritorno a Londra, il rocambolesco attraversamento dei Pirenei innevati e la battaglia con i lupi, ma con la partenza dall’isola. Non c’è stato lettore che in ogni epoca non sia rimasto tra le “pignatte di terracotta”, la “casa di campagna”, il recinto delle capre, il muro di cinta, e non abbia visto Robinson prendere il largo. Chiunque ha sognato di essere non lui ma al suo posto, magari per fare tutto il contrario.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
[è da poco uscito il nuovo libro di Gianni Bonina: “Fatti di mafia” (Theoria)]
* * *
[Tutte le puntate di I Capolavori sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo




