 Sono convinto che la grande Letteratura (il maiuscolo non è casuale), quella che rimane nel tempo, si possa leggere con immutato interesse… oggi come ieri. E oggi come ieri ritengo che possa fornire spunti di riflessioni.
Sono convinto che la grande Letteratura (il maiuscolo non è casuale), quella che rimane nel tempo, si possa leggere con immutato interesse… oggi come ieri. E oggi come ieri ritengo che possa fornire spunti di riflessioni.
Credo che sia così anche per la “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso.
Ha senso parlarne oggi, in Internet, nel contesto di un blog letterario? Io dico di sì.
Ecco a voi una nuova puntata di “Ritorno ai classici”, incentrata – per l’appunto - sulla figura di Tasso e sull’opera principale di questo grande autore.
Vi invito a discuterne partendo dal bel pezzo offertoci da Sergio Sozi.
Com’è noto “Gerusalemme liberata” narra della prima crociata ponendosi due obiettivi principali:
- raccontare la lotta tra pagani e cristiani
- raccontarla seguendo il filone della tradizione epico-cavalleresca.
Vi lancio una sfida…
Secondo voi “Gerusalemme liberata” è un’opera ancora attuale?
Se sì, perché?
Provate a tracciare delle connessioni con i “nostri tempi”.
È questa la sfida (e non credo sia una sfida particolarmente difficile da vincere, vero?)
Cominciamo…
Canto l’arme pietose e ‘l capitano
che ‘l gran sepolcro liberò di Cristo.
Molto egli oprò co ‘l senno e con la mano,
molto soffrì nel glorioso acquisto;
e in van l’Inferno vi s’oppose, e in vano
s’armò d’Asia e di Libia il popol misto.
Il ciel gli diè favore, e sotto ai santi
segni ridusse i suoi compagni erranti.
Bello, eh?
Massimo Maugeri
______________
La rabbia delle stelle – piccole notazioni tassiane in ritardo
di Sergio Sozi
Come vede talor torbidi sogni
Ne’ brevi sonni suoi l’egro e l’insano;
Pargli ch’al corso avidamente agogni
Stender le membra, e che s’affanni invano;
Che ne’ maggior sforzi a’ suoi bisogni
Non corrisponde il piè stanco e la mano;
Scioglier talor la lingua e parlar vuole,
Ma non segue la voce o le parole: (…)
(Visioni dell’Arabo Solimano in procinto di morire per mano di Rinaldo, La Gerusalemme liberata, canto XX, st. 105)
 Ho finito qualche pomeriggio fa di studiare, con passione lentezza e rigore, La Gerusalemme liberata. Prima l’avevo solo assaggiata (e fatta assaggiare) a piccole dosi in ambienti scolastici, poi niente piú per anni: la voce diretta di Torquato era sparita dal mio orecchio, eccetto citazioni e rimandi altrui, frammenti e accenni, dipinti del Guercino, del Domenichino, del Tiepolo, del Delacroix e di molti altri, visti chissà dove e come – ma questa è un’altra faccenda e la taglio subito, perché una voce come quella del Tasso ha in sé tutte le tonalità per vivere da sola in un timpano umano, quantunque moderno.
Ho finito qualche pomeriggio fa di studiare, con passione lentezza e rigore, La Gerusalemme liberata. Prima l’avevo solo assaggiata (e fatta assaggiare) a piccole dosi in ambienti scolastici, poi niente piú per anni: la voce diretta di Torquato era sparita dal mio orecchio, eccetto citazioni e rimandi altrui, frammenti e accenni, dipinti del Guercino, del Domenichino, del Tiepolo, del Delacroix e di molti altri, visti chissà dove e come – ma questa è un’altra faccenda e la taglio subito, perché una voce come quella del Tasso ha in sé tutte le tonalità per vivere da sola in un timpano umano, quantunque moderno.
Chiusa dunque l’ultima pagina, non so come mai, invece di riandare con la memoria e con le emozioni ai commoventi episodi di Olindo e Sofronia, Tancredi e Clorinda, Rinaldo e Armida, mi vengono stranamente in testa, a mo’ di consuntivo, dei numeri: io ho quarantatré anni e questa opera ne compirebbe quattrocentotrentatré (la stesura finale è del 1575), ora siamo nell’Anno Domini MMVIII e la storia è ambientata attorno al 1096, poiché narra della prima Crociata iniziata da Goffredo di Buglione in quell’anno e terminata nel 1099 con la conquista di Gerusalemme.
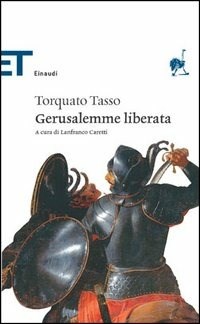 Cifre, queste, che esprimono delle dissonanze esplicite ed incrociate: una dissonanza esiste, anche se minuscola, già fra me e il 2008; un’altra, ben maggiore, fra il 2008 e il 1575; l’ultima è fra il 1096 e tutte le altre date, ed è quella piú evidente.
Cifre, queste, che esprimono delle dissonanze esplicite ed incrociate: una dissonanza esiste, anche se minuscola, già fra me e il 2008; un’altra, ben maggiore, fra il 2008 e il 1575; l’ultima è fra il 1096 e tutte le altre date, ed è quella piú evidente.
Ci sono dei veri e propri abissi cronologici fra gli elementi che si relazionano in tutto ciò – mi dico – come ad inanellarsi in una catena di forzature delle quali l’ultima è rappresentata dalla mia ostinazione all’esame del poema, con l’ausilio di note scarne e senza apparati critici. Uno strano gioco, il mio, chissà da dove scaturito, dentro o fuori di me.
Già: perché voglio riconquistare il Tasso, chi me lo suggerisce, chi mi obbliga ad inchiodarmi sulla sua opera principale pur senza ammanettarmi entro scadenze esteriori o necessità interiori?
Poi però penso ai due maghi, contrapposti, del poema: Ismeno (musulmano, infernale, ovvero Pagano secondo la terminologia dell’autore e dell’epoca) ed Ascalona (cristiano, celestiale) e alla fugace apparizione della dea Fortuna – pagana tout court ma qui stante dalla parte dei cristiani, poiché salvifica nei confronti di Rinaldo, eroe cristianissimo lasciatosi traviare dagli incantesimi erotici della strega/fata Armida. Una Fortuna del tutto moderna, questa, che, lontana anni luce dal significato originario, porta la buona sorte a chi vuole il Creatore Unico.
Inoltre, a controbilanciare l’aiuto che l’Arcangelo Gabriele offre (Hermes cristiano dotato di armi invisibili) al campo di Goffredo, vedo la forsennata furia Aletto, altro alleato delle potenze demoniache strappato alla mitologia classica, che qui, prese le sembianze del vecchio Araspe, stuzzica l’onor islamico del condottiero arabo Solimano: Ardisci, ardisci: entro ai ripari suoi / Di notte opprimi il barbaro tiranno (attenzione: il barbaro tiranno da opprimere entro ai ripari suoi è Goffredo di Buglione).
In sovrappiú Idraote, un ennesimo mago oggi poco notato, invia la seduzione per antonomasia ad indebolire le armi cristiane, nei panni e nelle tornite carni della stupenda maga Armida (forse il personaggio piú riuscito dell’intero poema, anche perché vicina alla Didone virgiliana e come ella strumentalizzata per una sorta di ragion di Stato, qui vista col prisma della biblica missione spirituale e dunque infine graziata dall’artefice, Dio o Tasso che sia).
A rappresentare una guida spirituale in diretta comunicazione col Dio cristiano ed affiancata ad un già angelico Goffredo, troviamo inoltre Pietro l’Eremita, i cui consigli spesso sono vaticini e rimedi contro gli incantesimi avversi – fra i quali certamente i piú temibili sono la zizzania, o meglio il sospetto reciproco, e la seduzione erotica femminile. L’Eremita, Goffredo e Ascalona sostituiscono, credo, completandosi a vicenda nell’assolverla, la funzione che nella poesia classica avevano i re, gli aedi e gli oracoli.
Ma tali interventi magici, cioè a dir meglio ultraterreni, sempre puntualmente motivati secondo la contrapposizione dottrinale Bene/Male ed Inferno/Paradiso nonché accuratamente portati entro una visione controriformistica dell’arte (il Concilio di Trento si era chiuso nel 1563), non bastano: ancora troppo profano, per le esigenze dell’autore, verrebbe cosí a configurarsi il racconto in ottave; dunque l’Inferno e il Paradiso stessi, visti con geografico-realistico sguardo e anticlassicistico zelo, vengono portati a partecipare direttamente all’agone in Terrasanta mostrando i due Sommi Protagonisti stessi in prima persona: Il Diavolo, Plutone, Gran nemico delle umane genti, da perfetto re della cittadella ínfera, si comporta infatti come segue, irato per la buona sorte cristiana: Contra i Cristiani i lividi occhi torse; / E lor veggendo omai lieti e contenti, / Ambo le labbra per furor si morse; / E, qual tauro ferito, il suo dolore / Versò mugghiando e sospirando fuore. (Canto IV).
Descritto direi con tratti michelangioleschi, Plutone poi, con fare da condottiero, aduna nella propria reggia sotterranea il suo mostruoso e orrido popolo-bestiario (composto di dèmoni ed esseri dalle orribil forme: Idre, Chimere, Polifemi, Scille, Gorgoni e quant’altro di tolto al mondo pagano) e arringa quei sudditi spronandoli ad andare in aiuto dei musulmani assediati. Si tratta di una replica in evidente polemica con Dio stesso, il quale, all’inizio del poema, era intervenuto per legittimare ed avviare la missione di Pietro l’Eremita (braccio spirituale) e Goffredo (braccio anche secolare): Dio, visti gli eroi cristiani inattivi, Chiama a sé da gli angelici splendori / Gabriel, che ne’ primi era secondo. / (…) / Giú i decreti del Ciel porta, ed al Cielo / Riporta de’ mortali i preghi e il zelo. / Disse al suo nunzio Dio: Goffredo trova, / E in mio nome di’ lui: perché si cessa? / Perché la guerra omai non si rinnova / A liberar Gerusalemme oppressa? (Canto I).
Tutto ciò finora esemplificato sta, non solo ma pure, a dimostrare quanto diversa, rispetto al periodo pre-tridentino dell’Umanesimo italiano (uno per tutti: l’Ariosto), fosse qui la progettualità morale e letteraria di fondo di un poeta dopotutto pur sempre calato nell’Umanesimo, ma i cui ben diversi intenti vengono dichiarati sin dai primi versi, i quali espongono una ben strana invocazione: O Musa, tu che di caduchi allori / Non circondi la fronte in Elicona, / Ma su nel Cielo infra i beati cori / Hai di stelle immortali aurea corona. Sí, strana invocazione, perché scopertamente rivolta non a Calliope (la musa della poesia epica) ma alla Madonna stessa (con lo pseudonimo di Musa, vero?), alla quale il Tasso annuncia chiaramente piú oltre, scusandosene, la sua ferma volontà di edulcorare, in modo strumentale, il messaggio cristiano unendolo a delle dolcezze parnassiane, perché (…) Il vero condito in molli versi, / I piú schivi allettando ha persuaso.
Allora la Gerusalemme liberata nasce con la funzione sinceramente apostolica di recuperare alla Vera Fede gli incerti, i dubbiosi e gli agnostici, ma in punta di piedi, col guanto di velluto, insomma senza che essi se ne accorgano: Cosí all’egro fanciul porgiamo aspersi / Di soave licor gli orli del vaso: / Succhi amari ingannato intanto ei beve, / E da l’inganno suo vita riceve.
Il modernissimo (Collodi lo porterà nel suo Pinocchio) paragone del bambino ammalato (egro fanciul) che rifiuta di bere lo sciroppo amaro (qui metafora di Messaggio Cristiano) e dunque rischia di morire (cioè di dare in pasto l’anima al Diavolo) è sufficiente motivo per il Tasso di concepire e sviluppare, senza ambiguità nòtasi, un intero poema che, sotto una superficie epico-cavalleresca, contenesse un apologetico ingannare per fini religiosi il lettore suo coevo, il quale, malato di profanità, rischiava altrimenti di restare nell’ignavia rappresentata dalla Letteratura umanistica precedente – il cui atteggiamento liberale e filopagano Tasso rigetta dal profondo dell’anima.
Naturalmente i destinatari dell’opera restano confinati nella cerchia degli uomini di cultura, vista la palese noncuranza dell’autore per ogni manifestazione plebea e l’accettazione dei dettami stilistici petrarcheschi, l’eloquio cortigiano ed aristocratico, l’aristotelismo integrale, la sua fiducia indirizzata (almeno nei suoi risvolti terreni) unicamente al sovrano assoluto, cioè al Dio Sovrano in Terra.
Sí, sappiamo tutto questo e non possiamo non considerarlo malato, egro, questo furore missionario; frutto di un’anima instabile e bambina, o quanto meno profondamente decontestualizzata, persa nel deserto delle mutazioni epocali – e la sua fu una di quelle piú dure del nostro Paese. Ma sappiamo anche quanto la Gerusalemme Liberata sia penetrata a fondo nel cuore e nella memoria individuale e collettiva degli Italiani e degli Europei, interclassisticamente diremmo, cosí sviluppando in straordinaria autonomia una fortuna tutta sua, andante ben al di là della stilistica barocca, di cui anticipa molte peculiarità formali, e soprattutto ben oltre gli intenti missionari del Tasso stesso. Non per niente Leopardi ne fu un estimatore e Goethe nel 1790 scrisse il suo noto dramma Torquato Tasso. Eh sí: l’incessante fama popolare lo predisponeva all’arrembaggio unilaterale delle fazioni che fossero di volta in volta à la page. Comunque, anche se tirato per la giacca e cosí misinterpretato da romantici e positivisti, inserito fra gli odiati poeti classicisti dai pittori francesi eccetera, il poeta puro Tasso, negli anni Settanta del Novecento, credo abbia avuto tuttavia una piccola rivincita personale, facendosi commentare dal critico Mario Pazzaglia come segue: ”Il tentativo tassiano (…) cerca di attuarsi sullo sfondo delle due istituzioni del suo tempo nelle quali il poeta credette fino a illudersi sul loro effettivo valore: la corte e l’accademia. La prima era per lui un’aristocratica accolta di spiriti eletti, di cui si sentiva chiamato a celebrare le virtú magnanime, sollecitandola ad alti ideali e a nobili imprese; l’accademia gli offriva l’insegnamento di un’arte eletta e rara, adatta ad esprimere quel nobile ideale di vita.”Inutile precisare che, proprio come prosegue il Pazzaglia nello stesso brano ”Il tentativo del Tasso si infranse nell’urto contro una società spoglia di dignità e grandezza; e fu per lui una sconfitta sul piano poetico (la Conquistata) e su quello umano.”
A giudicare dal Pazzaglia (1979) ci sono voluti quattrocento anni, a noi Italiani, per capire che i numeri non contano nulla. Ed io, be’, non l’ho capito mica subito; l’ho capito solo grazie ai maghi di cui il capolavoro è disseminato che per sentirsi in familiarità col Tasso (non lo stesso sarebbe per altri, pur altrettanto grandi) bisogna annullare tali dissonanze stupidamente epocali sciogliendole nel miracolo di un’opera realmente magica, sofferta e scomoda: magica per la capacità che ha insita di unire tutto il Medioevo (ed oltre) in un solo racconto; sofferta perché mai essa fu, è o sarà, affermazione adeguata al candido desiderio d’ortodossia cristiana del suo autore e scomoda per tutti, cristiani e non. Scomoda all’ennesima potenza, inevitabilmente, per il Tasso, che divenne pazzo a voglia di riscriverla – già: anche nella stesura del 1575 vediamo quanto egli non avrebbe potuto esprimersi senza ”Abusare di minuziosità, di giuochi di parole, di concettini, di contrasti artificiosi, di lungaggini”, come disse il critico Enrico Bianchi negli anni Sessanta; espressione già chiara, questa, credo, di un travaglio interiore ai limiti dell’umanamente tollerabile. Scomoda per l’Occidente, che ci si rispecchia al di là dei falsi moralismi che lo hanno sempre accompagnato durante l’era cristiana. Scomoda, infine, per chiunque sia sincero o cerchi la sincerità scavando sempre piú nel profondo di ogni cosa.
Dunque non mi chiedo piú che senso abbia leggere, oggi, l’edizione integrale di un poema epico cavalleresco che probabilmente era stato già di molto sorpassato, per modernità complessiva e struttura narrativa, dall’Orlando furioso dell’Ariosto diversi decenni prima (l’ultima stesura dell’Orlando è del 1532). No, non me lo chiedo piú: eh, ce ne sono di atti inconsulti, nella vita: fra i quali anche l’anelito a Vincer la rabbia de le stelle e il fato (Canto XIII, st. 80) nonostante la propria ed altrui debole umanità.
Sergio Sozi (Lubiana, 29 VI 2008)
Credo che Firmino si sia conquistato, in breve, il titolo di topo più celebre delle nostre librerie. Un topo da biblioteca? Senza dubbio. Ma anche un topo capace di far tanti bei quattrini, dato che il romanzo omonimo – di Sam Savage - (“Firmino”, Einaudi, 2008, euro 14, pag. 179), staziona da parecchio tempo ai vertici delle classifiche dei libri più venduti. Un libro che ha fatto discutere anche per via dell’ipotesi di plagio (dettagli qui).
 “Io sono stato sgravato, deposto e allattato sulla carcassa defoliata del capolavoro più non-letto del mondo” (Finnegans Wake di Joyce).
“Io sono stato sgravato, deposto e allattato sulla carcassa defoliata del capolavoro più non-letto del mondo” (Finnegans Wake di Joyce).








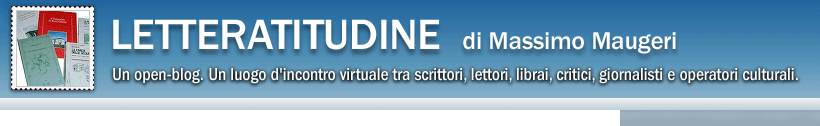
 Il titolo di questo post non si riferisce a un romanzo erotico o a un film spinto.
Il titolo di questo post non si riferisce a un romanzo erotico o a un film spinto.

 Ci sono albe che si somigliano. Che si sovrappongono. Che ci appartengono anche se le chiamiamo con nomi diversi.
Ci sono albe che si somigliano. Che si sovrappongono. Che ci appartengono anche se le chiamiamo con nomi diversi.















 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI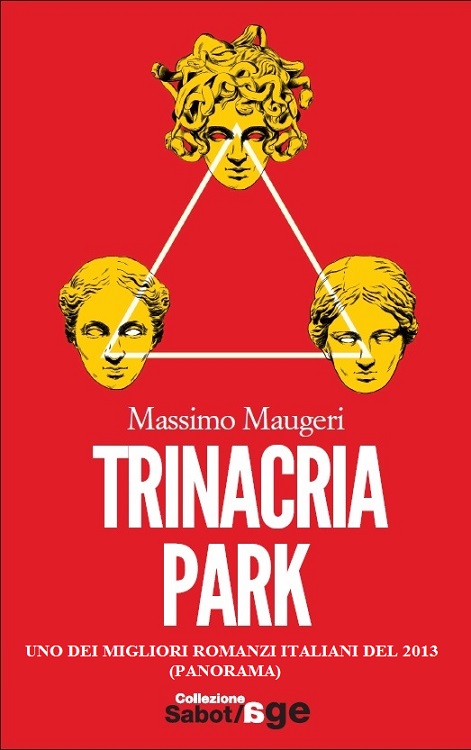
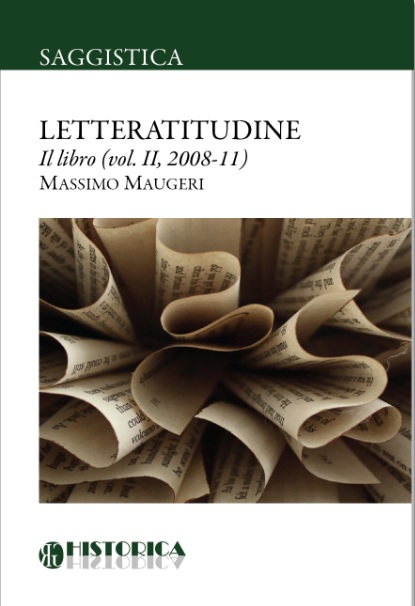


Commenti recenti