lunedì, 29 ottobre 2007
PARLIAMO DI RIVISTE. A VOI “PORTOSEPOLTO”
Vi invito a parlare di riviste.
Principalmente di riviste letterarie e culturali… ma non solo.
L’occasione ce la fornisce Gordiano Lupi che ci presenta una “nuova nata”: Portosepolto. Noi di Letteratitudine facciamo tanti in bocca al lupo (un milione di questi numeri!) a Portosepolto, ma ne approfittiamo per confrontarci anche in quest’ambito: quello, appunto, della lettura di riviste.
Così vi domando: che riviste acquistate, leggete, consigliate?
Volete promuoverne qualcuna? Bene. È l’occasione giusta.
Ci sono riviste che vi hanno deluso? Spiegatene il motivo.
Mi raccomando: massima sincerità (su, chi è che legge gossip tra noi?) e il solito rispetto reciproco. È anche questo un modo per conoscerci meglio… non trovate?
Massimo Maugeri
____________________________________________
____________________________________________
 PORTOSEPOLTO – Taccuino letterario
PORTOSEPOLTO – Taccuino letterario
————————-

Gordiano Lupi
giovedì, 25 ottobre 2007
PUZZLE… UN GIOCO (“FURORE” DI JOHN STEINBECK)
Vi propongo un giochino. È da tanto che non lo facevo, quindi non lamentatevi!
Di seguito riporterò due brevissimi brani estrapolati da un noto libro. Come avrete modo di constatare mi sono divertito a “mischiare” le parole.
Le parole ci sono tutte, ma disposte in ordine casuale. Troverete la punteggiatura tra parentesi. Insomma, vi fornisco tutti gli elementi. Non manca nulla.
Voi dovete:
1- Ricomporre i brani.
2- Individuare il libro da cui sono stati estrapolati.
3- Discutere del libro.
Ci state? È un modo divertente per “stare insieme”. Insieme tra noi e con i nostri amati libri.
Non dite di no!
Partecipate tutti, eh?
Ecco i due brani dopo la “centrifuga”.
A) bruciarlo non come sono bisogna vivere fa cose senza nostro passato vita del niente è possibile che la nostra non le spogli ci riconosciamo c’è posto lasciarlo
(punteggiatura: n. 1 punto interrogativo – n. 3 virgole – n. 2 punti “finali”).
-
B) occhi superstiti e nella loro memoria sugli sgabelli lo guardavano il loro passato con donne sognanti e le bruciavano
(punteggiatura: n. 1 punto “finale”).
Su… provate! È un esperimento.
_________________________________________________
AGGIORNAMENTO del 27 ottobre 2007
Il gioco è durato poco. Un po’ meno del previsto.
A questo punto non mi rimane che dedicare qualche riga al romanzo protagonista del gioco medesimo. Si tratta di Furore di John Steinbeck, scritto nel 1939; romanzo che valse all’autore americano l’attribuzione del premio Nobel per la letteratura nel 1962.
A mio avviso “Furore” è uno dei più grandi romanzi sociali della storia della letteratura del Novecento. Un grande affresco realista pubblicato quando il New Deal di Roosevelt ha quasi del tutto corretto le angosce e le distorsioni della Grande Depressione. Un libro forte, drammatico, che dipinge senza veli la penosa odissea di numerose famiglie di contadini e mezzadri costrette a migrare a Est (dall’Oklahoma alla California) per sopravvivere. La descrizione attenta e minuziosa di un vero e proprio inferno visto dal di dentro, dove la disumanità di un sistema volto a privilegiare gli interessi di pochi a discapito delle masse è solo in parte compensato dalla nascita di forme di toccante solidarietà tra diseredati.
Steinbeck ci presenta la famiglia Joad, una famiglia di contadini che diventa simbolo dello sfruttamento e dell’impossibilità di riscatto di un’intera categoria.
Massimo Maugeri
Leggete questo libro, se potete. In edizione economica ha un prezzo più che accessibile.
_____________________________________________________
AGGIORNAMENTO del 28 ottobre 2007
Mi è stato chiesto di mettere in primo piano sul post l’articolo di Irene Bignardi (“perché è più fruibile”). Obbedisco!
(Massimo Maugeri)
—————————-
Sognando la California: terra del latte e del miele
di IRENE BIGNARDI
Di solito dei grandi romanzi si ricorda l´incipit – a partire da quello più celebre (forse) di tutti, “Chiamatemi Ismaele”, indimenticabile inizio di Moby Dick. Di “Furore” (Grapes of Wrath, letteralmente l´uva dell´ira), il capolavoro di John Steinbeck, è leggendario soprattutto il finale. Quando, al termine della terribile, dolorosa, epica traversata dell´America verso il mito di una sognata California dove tutto dovrebbe essere facile e dove tutto è miserando e difficile, Rose of Sharon, la giovane donna del clan degli Joad, che ha appena perso il suo bambino neonato, offre il latte del suo seno a uno sconosciuto, un poveraccio che sta – letteralmente, come tanti, come gli infiniti poveri di questo libro e di queste storie vere – morendo di fame.
Tra il ritorno di Tom Joad a casa con un permesso speciale della prigione dove ha scontato quattro anni dei sette che deve fare per aver ucciso un uomo che lo ha accoltellato e, molto tempo e molte sofferenze dopo, l´arrivo nella tragica California della Depressione e il gesto da moderna pietà di Rose of Sharon, si snoda quello che a molti e per molto tempo, salvo gli inevitabili revisionismi, è sembrato il Grande Romanzo Americano – e che invece una critica eternamente insoddisfatta continua ancora a cercare.
Furore fu pubblicato il 14 aprile del 1939, e divenne subito un caso, un successo e un simbolo. Vinse il premio Pulitzer, e fu probabilmente il testo sacro che contribuì a fare del suo autore un eroe letterario e a fargli vincere nel 1962 il Premio Nobel. Bisogna aggiungere che, in quel lontano 1939 e nell´anno successivo fu il libro più venduto (chissà se si usava già la parola bestseller, e se il senso della medesima si portava dietro la stessa volgarità intellettuale). Che ne sono stati venduti quattro milioni e mezzo di copie in edizione hardcover. Che se ne vendono centomila ogni anno in tutto il mondo. Che è stato tradotto praticamente in tutte le lingue esistenti, fino ad arrivare alla cifra record di quattordici milioni di copie. E che nel 1940, sceneggiato da Nunnally Johnson e interpretato in maniera indimenticabile da Henry Fonda, è diventato uno dei grandi film di John Ford, politicamente molto forte e impegnato – e vincitore di ben due Oscar. Il tutto, a cementare il successo di Steinbeck su ogni fronte, mentre Lewis Milestone si preparava a girare un film dal suo play-novelette, Uomini e topi.
La storia di Furore, per chi non l´abbia mai letta o l´abbia dimenticata, è l´epopea della biblica trasmigrazione della famiglia Joad, assieme ad altre centinaia di poveracci, dall´Oklahoma attraverso il Texas Pandhanle, il New Mexico e l´Arizona, lungo le famosa Route 66 che conoscerà altre storie letterarie (Kerouac, fra gli altri), fino alla California, «il paese del latte e del miele», in cerca di un modo di vivere. Ci troveranno solo il modo di sopravvivere: paghe da fame, padroni terribili, lavori da schiavi. Sono gli anni della Grande Depressione, e, se non vogliamo ricorrere a John Ford, possiamo immaginarci i Joad con gli stessi volti dei disperati ritratti da Dorothea Lange e da Walker Evans, cotti dal sole e dal vento della Dust Bowl – come vennero soprannominate una volta per tutte, anche quando tornarono alla quasi normalità, quelle zone, dopo le spaventose siccità di quegli anni, che le aveva rese un deserto di polvere e di tempeste di sabbia – , smagriti da un regime di lavoro che non bastava neanche lontanamente a nutrirli, e non si dica a farli vivere.
Forse Furore adesso può a qualcuno sembrare un (grande) romanzo di propaganda politica, un affresco di realismo americano improntato a una visione manichea e sinistrorsa della realtà sociale. Allora fu certamente uno choc. Osannato da una parte della critica (mentre Malcolm Cowley su The New Republic scriveva prudentemente che il romanzo apparteneva alla categoria «dei grandi libri arrabbiati» come La capanna dello zio Tom che «sollevano la gente a combattere contro ingiustizie intollerabili»), visto da taluni come un «trionfo della narrativa proletaria», esaltato come un racconto biblico ispirato al reale, Furore fu attaccato dall´altra parte con altrettanta passione. La sua denuncia era troppo forte e fu guardato come un documento di propaganda politica, non come il grande libro che era: scuole e biblioteche lo misero al bando, uomini politici lo denunciarono pubblicamente, le grandi corporations dell´agricoltura lo definirono “immorale, degradante e falso”, le istituzioni della chiesa protestante lo attaccarono.
Attacchi che contribuirono a consolidare le insicurezze di Steinbeck. Perché dietro questo grande, roccioso romanzo, c´è la lunga e difficile storia del suo concepimento come la racconta Steinbeck nel suo diario Working Days – che venne pubblicato in concomitanza con il mezzo secolo del libro, nel 1989 – e come la riassume il suo non tanto clemente biografo Jay Parini nella sua biografia pubblicata nel 1994. E dietro l´uomo grande e bello e severo e con l´aria patriarcalmente sicura c´è un personaggio pieno di insicurezze, che non si immaginerebbero dal suo successo, dalle sue certezze morali, dalla sua storia.
Working Days fa la storia di una gestazione difficile, di un genio che non sapeva di esserlo e che troppo spesso era tentato, addirittura, di distruggere il libro che sarebbe diventato il suo capolavoro, e che non lo amava, e che si diceva, in tono negativo, che Furore era “assolutamente il meglio che so fare”. Se la stesura del suo grande romanzo richiese a Steinbeck solo cinque mesi (anzi, cento giorni di lavoro pieno, gli altri essendo “giorni dispersivi”: amici, distrazioni e pigrizia) il processo per cui si arrivò al libro è stato molto più complesso. All´inizio ci fu una serie di articoli scritti da Steinbeck per il San Francisco News nel 1936. Poi nacque l´idea di un romanzo di grandi dimensioni, il cui titolo sarebbe dovuto essere The Oklahomans. Il terzo passo fu il progetto di una satira socio-politica, L´Affaire Lettuceberg, che fu però abbandonato. Poi si arrivò a Furore. I modelli a cui Steinbeck si ispirava erano i grandi della letteratura civile, Hemingway, Faulkner, Thomas Wolfe, Dos Passos, Caldwell, e Melville per quanto riguardava i capitoli introduttivi. L´atmosfera e i tempi erano quelli della battaglia condotta dalla amministrazione di Roosevelt per controllare e smorzare la situazione esplosiva e prerivoluzionaria dei contadini impoveriti dalla crisi, dai ricatti delle banche, dai disastri atmosferici. Ma nella composizione del libro entra anche la presenza e l´amicizia di Tom Collins, la “coscienza” di Furore, la persona che aveva aperto e rivelato a Steinbeck il mondo del lavoro dei braccianti lavoratori a giornata organizzati dalla Resettlement Administration (e Collins fu anche colui che collaborò con Ford sul set del film come “consulente tecnico”).
“Senza Tom”, scrisse Steinbeck, “non avrei potuto cogliere tutti i particolari, e i particolari sono tutto”, come sa chi ha letto l´altro grande libro sui contadini poveri di quegli anni, Sia lode ora a uomini di fama, di James Agee e Walker Evans, la versione testimoniale e sociologica di Furore, che, come Furore ma in forma di inchiesta, indaga la tragica condizione dei contadini bianchi senza terra. Ma è vero anche che Steinbeck Furore non l´avrebbe potuto scrivere senza Carol, sua moglie (per tredici anni), che del romanzo seguì ogni riga, lo batté a macchina, lo difese, lo sostenne. E a cui Furore è dedicato. “A Carol, che ha voluto questo libro”, con la sua passione, la sua epica potenza, la sua sonorità biblica, la sua dolente umanità.
Furore e il suo successo e le polemiche che seguirono rappresentarono per Steinbeck una prova che lo lasciò stremato e diverso. Non si accontentò più della piccola stanza in cui gli piaceva e in cui era abituato a lavorare. Cambiò casa, scelse residenze sempre più grandiose, ebbe una seconda moglie, e poi una terza. I libri che scrisse erano, inutile dirlo, belli – La valle dell´Eden, La luna è tramontata – ma meno sanguigni e importanti (e anch´essi ebbero un destino cinematografico: prima La luna è tramontata, del 1943, con la sua nobile storia sulla resistenza norvegese contro il nazismo, nel 1955 La valle dell´Eden con l´esordio di James Dean). C´era stata Pearl Harbour, l´entrata in guerra degli Usa, una crisi della sinistra che convertì molti al patriottismo e coinvolse anche personalità come Welles e Chaplin. Fatto sta che, con gli anni, la visione politica di John Steinbeck cominciò ad appannarsi – tanto che l´ex uomo di sinistra, visto ormai da qualcuno come un “falco”, finì nel 1967 per sostenere la guerra del Vietnam, dove si era recato in veste di grande inviato giornalistico (le sue corrispondenze da Saigon sono state raccolte in un libro edito da Leonardo, C´era una volta la guerra): e per le sue posizioni, sorprendenti almeno per i suoi più fedeli lettori, si giocò una parte della sua popolarità. Lo scrittore laureato dal Nobel era sempre un grande, ma molto diverso dal generoso, appassionato, estremo cantore dei diseredati Okies di Furore.
Pubblicato in SONDAGGI, GIOCHI E SVAGHI 68 commenti »
martedì, 23 ottobre 2007
STORIA DELLA BRUTTEZZA di Umberto Eco
Dopo il successo della Storia della bellezza (oltre 500.000 copie in 27 edizioni nel mondo), Umberto Eco riflette su un tema ben più rimosso e trascurato dalla nostra cultura: quello della bruttezza.
Vi dico la verità. Io questo libro non l’ho ancora esaminato, ma mi ha colpito questa considerazione: le varie manifestazioni del brutto attraverso i secoli sono più ricche e imprevedibili di quanto comunemente si pensi.
Il concetto di ricchezza del brutto mi pare una sorta di ossimoro.
Il brutto attrae. Diciamo la verità. Affascina. Un po’ come il male.
Dicono che questo libro conduca a un “itinerario sorprendente tra incubi, terrori e amori di quasi tremila anni, dove gli atti di ripulsa vanno di pari passo con toccanti moti di compassione, e al rifiuto della deformità si accompagnano estasi decadenti per le più seducenti violazioni di ogni canone classico”.
E poi che: “tra demoni, folli, orribili nemici e presenze perturbanti, tra abissi rivoltanti e difformità che sfiorano il sublime, freaks e morti viventi, si scopre una vena iconografica vastissima e spesso insospettata. Così che, incontrando via via su queste pagine brutto di natura, brutto spirituale, asimmetria, disarmonia, sfiguramento, in un succedersi di meschino, debole, vile, banale, casuale, arbitrario, rozzo, ripugnante, goffo, orrendo, insulso, nauseante, criminoso, spettrale, stregonesco, satanico, repellente, schifoso, sgradevole, grottesco, abominevole, odioso, indecente, immondo, sporco, osceno, spaventoso, abbietto, mostruoso, orripilante, laido, terribile, terrificante, tremendo, rivoltante, ripulsivo, disgustoso, nauseabondo, fetido, ignobile, sgraziato, spiacevole e indecente, il primo editore straniero che ha visto quest’opera ha esclamato: “Come è bella la bruttezza!”
Sopra sono riportati solo alcuni degli aggettivi con cui si parla e si rappresenta la bruttezza. Di ognuno di questi, il libro ci fornisce, con humour e profondità, più di un esempio – letterario e artistico.
 “In ogni secolo, filosofi e artisti hanno fornito definizioni del bello; grazie alle loro testimonianze è così possibile ricostruire una storia delle idee estetiche attraverso i tempi. Diversamente è accaduto col brutto. Il più delle volte si è definito il brutto in opposizione al bello ma a esso non sono state quasi mai dedicate trattazioni distese, bensì accenni parentetici e marginali.”
“In ogni secolo, filosofi e artisti hanno fornito definizioni del bello; grazie alle loro testimonianze è così possibile ricostruire una storia delle idee estetiche attraverso i tempi. Diversamente è accaduto col brutto. Il più delle volte si è definito il brutto in opposizione al bello ma a esso non sono state quasi mai dedicate trattazioni distese, bensì accenni parentetici e marginali.”
Umberto Eco
Nato ad Alessandria nel 1932, Umberto Eco è Presidente della Scuola Superiore di Studi Umanistici presso l’Università di Bologna. Tra le sue opere di saggistica si ricordano: Opera aperta (1962), La struttura assente (1968), Trattato di semiotica generale (1975), Lector in fabula (1979), Semiotica e filosofia del linguaggio (1984), I limiti dell’interpretazione (1990), La ricerca della lingua perfetta (1993), Sei passeggiate nei boschi narrativi (1994), Kant e l’ornitorinco (1997), Sulla letteratura (2002), Dire quasi la stessa cosa (2003). Nel 1980 ha esordito nella narrativa con Il nome della rosa (Premio Strega 1981), seguito nel 1988 da Il pendolo di Foucault, nel 1994 da L’isola del giorno prima, nel 2000 da Baudolino e nel 2004 da La misteriosa fiamma della regina Loana. Nel 2004 ha curato Storia della bellezza.
—
Storia della bruttezza (a cura di Umberto Eco)
Bompiani, 2007, pagg. 456, euro 35
—
Vi propongo, di seguito, un particolare articolo di Sergio Sozi scritto sulla base di una videointervista che Eco ha rilasciato a Gianni Riotta (direttore del TG1) qualche giorno fa.
E poi vi pongo un po’ di domande.
Come è stato rappresentato il brutto nella storia dell’arte? Con quali testi? Con che immagini? Con quali differenze nei secoli?
Se non sapete rispondere leggete il libro (anzi, leggiamo il libro).
Questa domanda è più facile: Il brutto di ieri equivale al brutto di oggi?
È corretto (o può aver senso) dire che il brutto di oggi è più brutto del brutto di ieri?
Massimo Maugeri
________________________
________________________
Il politeismo della bellezza. Umberto Eco esce dieci minuti dalla tana
di Sergio Sozi
Umberto Eco, il giorno 12 ottobre dell’Anno Domini 2007, ha concesso un’intervista a Gianni Riotta di TV7 (Rai Uno, verso mezzanotte: l’ora delle streghe e dei… guru intellettuali). Il fatto fa notizia, conoscendo la riservatezza del geniale poligrafo alessandrino, dunque abbiamo trascritto per Letteratitudine qualche passo del colloquio, premettendo che la sua Storia della bruttezza esce ora in ventisette edizioni in tutto il mondo e quindi Riotta ne ha evidentemente approfittato – gatto col topo – per intrappolare il semiologo alla Fiera del Libro (Buchmesse) di Francoforte, dove lo studioso ha appena presentato al pubblico la sua nuova opera. Evidentemente il direttore della popolare trasmissione aveva attratto l’illustre ex Novissimo col formaggio di un dialogo stimolante. Ma ora, scherzi bonari a parte, veniamo all’incontro.
La polemica sui ”bamboccioni” del Ministro Padoa Schioppa apre il colloquio, ed Eco qui precisa che, sebbene molti giovani italiani siano effettivamente tali, ciò non è vero per tutti, dunque la definizione non è generalizzabile. Poi si passa ai problemi della ricerca umanistica, dove, precisa Eco ”Anche con pochi soldi si riesce a andare avanti”. Il problema dunque resta anche per Eco la sottofinanziata ricerca scientifica. Di seguito si affronta il libro: ”Una fenomenologia del brutto è estremamente più ricca e varia di una fenomenologia del bello.” Dal bello-brutto, si passa alla classica analogia bello-bene e brutto-male, un concetto risalente ai Greci, nonostante la bruttezza estetica di un buono come Socrate. Con il Romanticismo comunque, precisa Eco, si arriva a proporre il brutto-buono (Hugo) e viceversa il cattivo-bello. Oggi, infine, ”Ci troviamo di fronte ad un politeismo della bellezza: non c’è una bellezza unica e lo stesso avviene per la bruttezza. In questo politeismo, abbiamo delle bellezze che divengono bruttezze e delle bruttezze che diventano bellezze.” Esempi di belli attuali: Marilyn Manson e George Clooney ”Opposti ma entrambi validi per certi gruppi umani.”
E tocca alla televisione; Riotta, alludendo alla quotidiana attenzione televisiva per i drammi della violenza (Garlasco, Cogne, ma anche gli ammazzamenti terroristici e a sfondo politico), chiede ad Eco: ”Perché abbiamo bisogno oggi di questa riproduzione quotidiana in tv del brutto, di questa notte dei morti viventi televisiva?”. Qui la risposta dello scrittore è interessante, seppur discutibile: ”Non bisogna mai pensare che noi siamo peggiori dei nostri padri: i nostri padri erano sempre peggiori di noi: tu comincia a pensare ai Romani che andavano a vedere i cristiani divorati dai leoni, o alle code che nei secoli passati si facevano per poter andare a assistere alle impiccagioni o alle decapitazioni. Le tricoteuse in Francia, durante la Rivoluzione, facevano lì la maglia tutto il giorno, durante le esecuzioni. Quindi, per la folla bruta, per la gente di basso livello intellettuale, c’è sempre stato il bisogno di dare sangue e crudeltà. La televisione dà questo stesso materiale alla gente di basso livello intellettuale, solo che fa finta di darlo a quella di alto livello intellettuale.”
A questo punto Riotta obietta che, però, lui ha ”L’impressione che anche gli intellettuali siano attratti dalla cronaca nera”. La risposta di Eco è la seguente: ”Chiunque ogni tanto prova il piacere d’incanaglirsi; in più c’è una differenza tra il trash sanguinolento e la cronaca nera, cioè: vedere una testa che esplode e il sangue che sprizza, questo fa parte dello stesso gusto degli Antichi Romani che andavano a vedere i leoni e i cristiani; la cronaca nera… be’ lì interviene anche il gusto del poliziesco, dell’enigma: chiedersi ma il ragazzo è davvero colpevole o no?… e questo è anche un gusto intellettuale, c’è poco da fare. I maggiori consumatori di romanzi polizieschi sono gli intellettuali, solo che non lo dicono.”
Dunque, si chiede Riotta: tale diffusa bruttura televisiva genererà in noi un’educazione maggiormente democratica o una semplice assuefazione ai servizi che ci mostrano le immagini di stragi e orrori vari?
”Oggi siamo obbligati a vedere l’orrore là dove c’è nel mondo. Io non so”, tituba Eco, ”capiremo solo tra un secolo quale dei due elementi pesi di più, se la possibilità di rappresentare l’orrore ci ha resi più sensibili o più insensibili; e può anche darsi che la risposta sia che per certe persone sia stata un elemento di sensibilizzazione e quindi di risveglio morale, per altre invece sia stato un elemento narcotico. Forse la verità sta proprio in mezzo.”
Riotta, poi, passa alla Letteratura, citando la tremenda Giornata di uno scrutatore di Italo Calvino, narrazione-testimonianza ambientata negli orrori del Cottolengo di Torino. Con una citazione da quel romanzo, infatti, Eco conclude la sua ultima opera storico-antologica. E dice: ”Questa pagina è pervasa da una immensa pietà. L’ho voluta come pagina finale proprio perché, dopo una lunga rassegna del brutto attraverso i secoli che può provocare anche qualche compiacimento nel lettore, questo richiamo alla pietà, al rispetto dell’orribile, quando l’orribile è sofferenza e condanna, mi è parso un modo molto giusto per concludere il libro.” Poi si va a finire.
Be’, secondo me l’intervista forse avrebbe potuto dare frutti migliori, ma Riotta, avendo inserito l’intervento di Eco nell’ambito di un successivo dibattito sul nuovo Partito Democratico, ha comunque cercato di conciliare le esigenze dell’attualità politico-sociologica – concernenti le tematiche di TV7 – con quelle inerenti lo specifico ruolo dell’illustre invitato. Certo, potremmo magari chiedere a Gianni Riotta di dedicare un giorno una puntata intera ad Umberto Eco, il cui pensiero complesso variegato e affascinante ha faticato in questa occasione ad emergere dal ruolo di opinionista – vestito che gli sta stretto, direi.
Tuttavia, grazie ad entrambi i colloquianti, di stimoli da dibattere penso che qui ne siano emersi molti. Per esempio la crudeltà nostra che è inferiore a quella dei nostri antenati Romani; la sovraesposizione al macabro televisivo giornaliero, che potrebbe anche migliorare la nostra moralità; il trash che è diverso dalla cronaca nera attuale; l’attrazione-repulsione per la morte che diviene per gli intellettuali un gioco giallistico; i plurisecolari canoni estetici oggi andati a briglie sciolte. Sarà proprio così?
Inoltre personalmente aggiungerei questa domanda collaterale: ma la nuova Letteratura italiana proprio non può fare a meno, oggi, di seguire, imitare, agganciare troppo strettamente il nostro reale incanaglimento collettivo? Romanzi come Il nome della rosa ci mostrano le infinite possibilità per la (buona) Letteratura di affrontare temi e interrogativi sempre attuali, pur senza parlare di angosce metropolitane, psicofarmaci, pistolettate, borghesia decaduta e stragi politiche. Cose, queste, che alla lunga annoiano, visto che stanno su tutti i giornali e su tutti gli schermi – oltretutto vestite di una onnicomprensiva trascuratezza linguistica grigia, lugubre e ammorbante.
Sergio Sozi
________________________________________
________________________________________
AGGIORNAMENTO del 5 dicembre 2007
Ieri, 4 dicembre 2007, il mondo della cultura lubianese era in fermento – ma in verita’ la cosa nei nostri ambienti si risapeva da una decina di giorni – per via del conferimento ad Umberto Eco della Laurea Honoris Causa in Lettere presso l’ateneo della capitale slovena.
Va detto che qui Eco fa molta eco soprattutto da quando il principale quotidiano ”Delo” (circa 60-70.000 copie in media: gli sloveni sono in tutto due milioni di cristiani, quasi tutti Cattolici), da quando quel giornale, dicevo, allego’ in omaggio la traduzione del ”Nome della rosa” (accadde qualche anno fa).
Dunque, ieri, alle ore diciotto, mi sono recato nella capiente sala conferenze ”Linhartova dvorana”, sita nel grandissimo complesso ad usum incontri culturali, conferenze, fiere dell’editoria e fiere varie (una specie di Lingotto torinese) che si chiama ”Cankariev dom” (”La casa di Cankar”, Ivan Cankar e’ uno dei maggiori narratori sloveni a cavallo fra Ottocento e Novecento). Avevo il biglietto per via di un mio caro amico e connazionale che insegna italiano all’Universita’ di Lubiana.
Trovo almeno 6-700 persone nell’anfiteatro della sala (una sorta di teatro, con tanto di sipario, galleria, platea e boccascena), il solito assedio di fotoreporter e telecamere; dunque mi sorbisco l’intera ”conferenza” dell’Eco (corroborata da immagini in diapositiva) in inglese. Solo in inglese! Domande alla fine della ”conferenza”: in inglese. Spiegazione delle virgolette: Eco, furbacchione, ha detto in inglese quel che tutti sappiamo come introduzione della sua ultima ”Storia della bruttezza”, niente piu’: citazioni di poeti, scrittori e pittori con Italo Calvino a concludere. La mattina stessa aveva ricevuto l’onorificenza e la sera ”allentava” ’sta boiata agli sloveni come se fossero cretini (mio suocero filologo classico, che c’era, ha detto, giustamente, che era una boiata).
Insomma, finisce la cosa (circa un’ora comprese le cinque sei domande del pubblico, in gran parte studenti, accademici e uomini di cultura interessati alla Letteratura italiana) ed io vado da Eco, il quale stava firmando su di un tavolinetto le copie ai ragazzotti. Gli dico, in italiano ovviamente: ”Mi scusi professore, io non ho libri da autografare, ma vorrei un giorno, magari, parlare con lei a proposito del ”romanzo”, per conto del blog Letteratitudine.”
Lui risponde: ”E cos’e?”’
”Un blog di letteratura molto visitato. Io sono un critico.”
”Ah… potrei lasciarLe questo indirizzo. Ha della carta?” E mi scrive sul depliant che io, tremebondo, gli porgo, un indirizzo di posta elettronica.
”Arrivederci e grazie.”
Ecco tutto.
Una fregatura. Per dirla alla GREGORIana maniera.
Avrei almeno immaginato qualcosa di piu’ che una serata pubblicitaria per i suoi libri Bompiani. Non c’e’ piu’ dignita’, ragazzi. Onesta’ e’ parola gia’ eliminata persino dal vocabolario dei grandi come lui. Uno che fa eco. Ma ricordiamoci uno dei miti di eco: quello della donna troppo ciarliera che Giunone condanna a parlare solo con la voce degli altri.
Anzi: se ne ricordi lui.
Sozi
Umberto Eco a Lubiana in occasione della laurea honoris causa
Pubblicato in SEGNALAZIONI E RECENSIONI 194 commenti »
domenica, 21 ottobre 2007
RISCHI SUL FUTURO DELL’INFORMAZIONE IN INTERNET. NEO-OSCURANTISMO O CIALTRONERIA?
 Il titolo del post è molto provocatorio. E l’immagine prescelta pure (se non addirittura peggio). Lo so.
Il titolo del post è molto provocatorio. E l’immagine prescelta pure (se non addirittura peggio). Lo so.
Il fatto è che questa vicenda mi ha fatto seriamente preoccupare.
Soprattutto all’inizio.
Come certamente avrete saputo, il Governo ha recentemente approvato e mandato all’esame del Parlamento un testo che si prefigge di cambiare le regole del gioco del mondo editoriale, per i giornali e anche per Internet. Si tratta di questo disegno di legge (20 pagine e 35 articoli).
Esaminato alla lettera sembrerebbe che chi ha un piccolo sito, perfino chi ha un blog personale, sarà ben presto costretto a ottemperare a obblighi di registrazione, burocrazia, spese impreviste e sanzioni penali più forti in caso di diffamazione.
Proviamo a fare il punto della situazione con l’aiuto degli articoli pubblicato da Repubblica.it
L’articolo 6 del disegno di legge prevede che deve iscriversi al ROC, in uno speciale registro custodito dall’Autorità per le Comunicazioni, chiunque faccia “attività editoriale”. L’Autorità non pretende soldi per l’iscrizione, ma l’operazione è faticosa e qualcuno tra i certificati necessari richiede il pagamento del bollo. Attività editoriale – continua il disegno di legge – significa inventare e distribuire un “prodotto editoriale” anche senza guadagnarci. E prodotto editoriale è tutto: è l’informazione, ma è anche qualcosa che “forma” o “intrattiene” il destinatario (articolo 2). I mezzi di diffusione di questo prodotto sono sullo stesso piano, Web incluso.
Ricardo Franco Levi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e padre della riforma, ha precisato: “Lo spirito del nostro progetto non è certo questo. Non abbiamo interesse a toccare i siti amatoriali o i blog personali, non sarebbe praticabile”.
Chi finirà, allora, nel registro ROC? “Non spetta al governo stabilirlo – continua Levi – Sarà l’Autorità per le Comunicazioni a indicare, con un suo regolamento, quali soggetti e quali imprese siano tenute davvero alla registrazione. E il regolamento arriverà solo dopo che la legge sarà stata discussa e approvata dalle Camere”.
Pare però che, una volta stabilito che un sito web sia tenuto all’iscrizione al ROC, debba anche dotarsi di una società editrice e di un giornalista nel ruolo di direttore responsabile.
Beppe Grillo si è subito fatto sentire dal suo blog. Conseguenza della legge, sostiene il comico, sarebbe la chiusura del 99% dei blog e “il fortunato 1% della Rete rimasto in vita, per la legge Levi-Prodi, risponderebbe in caso di reato di omesso controllo su contenuti diffamatori ai sensi degli articoli 57 e 57 bis del codice penale. In pratica galera quasi sicura”.
Grillo, nonostante le “rassicurazioni” di Levi, ha proposto la cancellazione della legge e annunciato che il prossimo V-day sarà dedicato all’informazione per chiedere due cose:
l’abolizione del finanziamento pubblico all’editoria e l’abolizione dell’ordine dei giornalisti.
Folena, presidente della commissione Cultura della Camera ha chiesto chiarimenti: “Chi fa un blog non è un editore. Quindi non deve sottostare a nessuna regola particolare riguardante la stampa o gli operatori della comunicazione. Anche io ho un blog, e un blog è un diario. Nel quale, certo, si può fare informazione. Così come esistono migliaia di siti. Quindi – conclude – va chiarito che chi fa informazione amatoriale online, così come è oggi, se vuole usufruire dei vantaggi della legge sulla stampa si iscriverà al tribunale, altrimenti non deve iscriversi da nessuna parte. Un conto è la professione, l’impresa, altro è la libera circolazione di idee e informazioni”.
Sergio Bellucci, responsabile Comunicazione e innovazione tecnologica del Prc ha sostenuto: “Le risorse pubbliche devono essere usate per aumentare il pluralismo della comunicazione nella carta stampata e in internet” ma la riforma “dev’essere ispirata al criterio di regalare meno soldi ai grandi gruppi e aumentare le capacità di comunicazione dei piccoli gruppi e dei singoli cittadini”.
Alfonso Pecoraro Scanio ha annunciato che i Verdi presenteranno emendamenti alla legge “per evitare restrizioni per chi apre un blog e consentire a tutti gli utenti di parlare liberamente preservando la democrazia web”. Per il ministro dell’Ambiente, “essendo un disegno di legge, per l’approvazione dovrà passare in Parlamento e lì sarà possibile apportare modifiche e migliorare il testo. Invito tutte le forze politiche a sostenere l’iniziativa dei Verdi per non limitare la possibilità d’espressione in Rete”.
Antonio Di Pietro, fra i primi politici-blogger, è convinto che “il ddl vada bloccato”, perché “metterebbe sotto tutela internet in Italia e ne provocherebbe la fine”. Parla di “una legge liberticida”, e conclude: “Per quanto mi riguarda, questa legge non passerà mai, a costo di mettere in discussione l’appoggio dell’Idv al governo”.
Paolo Gentiloni, ministro delle Comunicazioni, ha ammesso sul suo blog che è giustificato l’allarme suscitato dalla norma sulla registrazione dei siti internet: “L’allarme lanciato da Beppe Grillo e ripreso da molti commenti al mio blog è giustificato”. Poi ha aggiunto che la correzione è necessaria perché la norma in questione “non è chiara e lascia spazio a interpretazioni assurde e restrittive”.
Il ministro riconosce poi (come ha fatto nei rispettivi blog Antonio Di Pietro e pecoraio Scanio), la propria fetta di responsabilità nell’accaduto “per non aver controllato personalmente e parola per parola il testo che alla fine è stato sottoposto al Consiglio dei Ministri”.
“Pensavo – prosegue Gentiloni – che la nuova legge sull’editoria confermasse semplicemente le norme esistenti, che da sei anni prevedono sì una registrazione ma soltanto per un ristretto numero di testate giornalistiche on line, caratterizzate da periodicità, per avere accesso ai contributi della legge sull’editoria”.
Per il ministro delle Comunicazioni, dunque, “va bene applicare anche ai giornali on line le norme in vigore per i giornali, ma sarebbe un grave errore estenderle a siti e blog. (…) Il testo, invece, è troppo vago sul punto e autorizza interpretazioni estensive che alla fine potrebbero limitare l’attività di molti siti e blog”. In definitiva, “meglio, molto meglio lasciare le regole attuali che in fondo su questo punto hanno funzionato. Riconosciuto l’errore, si tratta ora di correggerlo. E sono convinto che sarà lo stesso sottosegretario alla Presidenza Levi a volerlo fare”.
____________________________
Prendiamo atto delle scuse presentate da Gentiloni, Di Pietro e Pecoraro Scanio. Le accettiamo.
È anche vero, però, che sarebbe il caso di dire: “meno presenza in Tv e più occhi sulle carte”.
O no?
Voi che ne pensate dell’intera “questione”?
———–
Aggiornamenti e notizie ulteriori su Lipperatura.
Pubblicato in PERPLESSITA', POLEMICHE, PETTEGOLEZZI E BURLE 110 commenti »
giovedì, 18 ottobre 2007
GIUDA L’OSCURO di Antonio Di Grado (recensione di Sabina Corsaro)
E’ un’ ispezione nel labirinto del tradimento quella attuata da Antonio Di Grado, resa attraverso lo sguardo dei letterati che tra Ottocento e Novecento ne hanno esaminato e poi interpretato le multiple valenze semantiche. L’atto del tradimento è inteso non solo come effetto di una delazione ma anche come conversione, apostasia, ricognizione, nei confronti “di una fede, di un patto, di un mandato o di una gerarchia di norme e di valori, di una identità nazionale o ideologica”. Giuda è un personaggio-simbolo, anzi, usando un termine caro a Debenedetti (tra l’altro chiamato in causa in questo testo), rappresenta il personaggio-uomo; risulta plasmabile, indefinito, moralmente plastico, dove per plasticità s’intende la capacità continua di adattamento ai vari contesti sociali, culturali, ideologici, religiosi. La letteratura riprende ed interpreta, col proprio linguaggio, l’episodio cardine che ha dato vita a quell’opposizione tra identità senza identificazione (propria dell’uomo) e determinatezza dell’infinito, percezione della sua illimitatezza (propria di un’entità). Giuda non è solo il discepolo che tradì per trenta denari Gesù o il fedele esecutore del disegno divino in cui interpretò la vittima sacrificale ma diviene uomo comune, con la sua fragile umanità, con i suoi ripensamenti, le sue contraddizioni e con il marchio del peccato.
La figura di Giuda viene scissa nel corso dei tempi e viene dall’autore identificata ora con l’Iscariota, ora con gli intellettuali che hanno rinnegato il loro credo ideologico (una buona parte degli esponenti della letteratura italiana tra le due guerre) e persino con gli scrittori ‘irregolari’, emarginati, in quanto traditori di norme e valori fissati da un canone da cui hanno preso le distanze, quelli che egli definisce gli “esclusi dalle provvidenziali risorse della totalità epica o romanzesca” e per i quali chiede una sorta di rivalsa: “E’ forse il caso allora –scrive- di riformulare la categoria stessa di ‘minore’, affinché essa non rimandi più a improponibili gerarchie di valori”. Tra essi sfilano scrittori come: Lanza (Giuseppe), Alvaro, Aniante, i ‘moralisti vociani’ Boine e Jahier, (dove il termine di ‘moralista’ è stato da molti usato come mera etichetta che “ha funzionato sempre e soltanto come una comoda scappatoia per archiviare la moralità…”), fautori, questi ultimi, di una nuova interpretazione della natura del peccato “ineluttabile e connaturato all’uomo, alla sua legittima volontà di operare nel mondo e di trasformarlo”.
Ma il tradimento richiede inevitabilmente altri soggetti oltre ai traditori: i traditi; tra questi Di Grado chiama in causa gli ebrei, vittime di un tradimento attuato dalla storia e da quello stesso Dio ‘assente’, silenzioso, sulla cui indifferenza ha persino dubitato Gesù nei momenti che hanno preceduto la sua morte. Vediamo così sfilare in rassegna una costellazione di autori che nel Novecento hanno trattato di Giuda: Leo Perutz, Paul Claudel, Borges, fino ad arrivare alla denuncia di André Gide del tradimento di tutte le chiese operato nei confronti delle fedi. Il riferimento al tradimento inteso come adulterio viene solo accennato per il riferimento ai due grandi romanzi di Flaubert e Tolstoj.
Ma è, in particolare, in una frase dello stesso autore che si può cogliere l’invito ad un nuovo atteggiamento ‘intellettuale’ nei confronti di quello ‘scacco’ nella storia dell’umanità, proteso a rilevare una redenzione e riconciliazione tra la figura di Giuda e quella di Cristo, tra il peccato e la predisposizione alla coerente perfezione, tra la condizione dell’uomo e la sua spiritualità: “grazie a quei trenta denari coniati nella sofferenza l’uomo-Giuda sarà liberato”. Una scrittura sofisticata, ricca di metafore ricercate, di lucidità e logicità sintattiche; corposa, eclettica e raffinatamente ‘eversiva’. Un libro gremito di riflessioni, eleganti provocazioni, inconfessabili idiosincrasie, che, insieme, si svelano come tracce indelebili dell’ ‘oscuro’ e ineluttabile rapporto tra letteratura, destino ed essenza dell’uomo.
Sabina Corsaro
_________________________________________________________
Si ringraziano l’autore del libro e la casa editrice per aver concesso la pubblicazione del brano che segue.
Aveva scritto Paolo che, se i Greci cercano la sapienza e i Giudei i miracoli, «noi predichiamo il Cristo crocifisso, follia per i Greci e scandalo per i Giudei». L’Evangelo è questo, è questo il nucleo, è questa la sintesi della rivelazione. Che perciò non è conoscenza filosofica, non è efficienza storica. È un Dio in croce, è un Dio sconfitto, è lo scandalo della debolezza e della morte, della carne piagata e degli olocausti, repliche infinite dell’incarnazione. È il Dio che s’accompagna ai reietti, alla feccia; è il Dio che intinge il boccone per Giuda e ne riceve amichevolmente il bacio.
Nel cosiddetto Vangelo di Giuda, Gesù ride spesso. Ride dell’ottusità degli apostoli, ride dell’indegnità delle chiese e dell’inferiorità del loro dio, ride della nostra ignoranza che ci rende inaccessibile il nome dell’Eterno. In quel vangelo come negli altri testi gnostici, la salvezza non è l’espiazione del peccato ma il raggiungimento della consapevolezza, che è un dono, è il frutto d’una elezione: come sarà per Lutero la fede che ci giustifica. Per i tanti cristianesimi possibili dei primi secoli, così come per quelli resi possibili più tardi dalla Riforma, il rapporto diretto con Dio, il dono della Sophia o della Grazia, il libero esame della Parola sono la via – plurale, sinuosa, errabonda – per la salvezza.
Ma gli gnostici non intesero il mistero dell’incarnazione e lo scandalo della Croce, né la centralità del corpo e l’annunzio della sua resurrezione, cui sostituirono il mito dell’anima autorizzando manie d’immortalità nonché la voga – malauguratamente ricorrente – delle New Age spiritualistiche. E i protestanti edificarono chiese, stabilirono gerarchie, finirono troppo spesso col riprodurre forme e norme della chiesa di Roma.
Nulla salus in ecclesia? Aveva ragione André Gide, a voler comporre un Christianisme contre le Christ, come a dire che l’Evangelo è tradito dalle chiese, la fede dalle “religioni”? Umana, troppo umana, inevitabilmente intrisa di peccato e di sopraffazione, di errore e di presunzione, ogni chiesa forse è tradimento: arresta
la Parola in movimento del Cristo, il suo dispiegarsi in cammino, il suo farsi incessantemente e mutevolmente carne; le dà alloggio mentre essa (Matteo 8, 20) «non ha dove posare il capo».
E ancora avanza, quella Parola, senza tema di confondersi con la propria eco cangiante, di offrirsi instabile e alterata «come in uno specchio». Si accompagna anche con scrittori oziosi e di smodata immaginazione come ieri con pubblicani e prostitute. Invita i curiosi e i disperati che l’ascoltano a tradire fedi, patrie, chiese, idee, affetti e altri umanissimi vincoli. E ci parla d’un solo Dio: non una seconda e più autorevole divinità da contrapporre al collerico demiurgo dell’Antico Testamento; semmai, come affermavano gli gnostici valentiniani, un’idea più profonda oltre l’immagine popolare, umana, dispotica, maschile del Dio d’Israele. O, come scriveva Paul Tillich, un «Dio al di là di Dio». Un Dio Padre-Madre-Figlio: solo in questi termini, forse, è possibile concepire l’inesplicabile politeismo della Trinità; solo così, come Grazia e principio femminile, è possibile dare un senso all’enigmatica o pleonastica figura dello Spirito; solo così è possibile ricondurre all’unità – dell’autorità paterna ma pure dell’indulgenza della madre generatrice – la figura a tratti ribelle, quasi sempre amletica, comunque irriducibile, del Cristo.
E quella Parola in cammino misteriosamente aggrega la chiesa invisibile degli eletti, che attraversa tutte le fedi; e recluta, fuori da quelle, moltitudini di dubbiosi e miscredenti, perché Dio ha conosciuto nel Figlio la ribellione e la bestemmia; e forse non gradisce altra forma di preghiera che non sia la sorda colluttazione con l’Angelo:
E Iacob restò solo: ed un huomo lottò con lui fino all’apparir dell’alba.Ed esso, veggendo che non lo potea vincere, gli toccò la giuntura della coscia: e la giuntura della coscia di Iacob fu smossa, mentre quell’huomo lottava con lui.E quell’huomo gli disse, Lasciami andare: percioche già spunta l’alba. E Iacob gli disse, Io non ti lascerò andare, che tu non m’habbi benedetto.
Così, nella splendida lingua seicentesca di Giovanni Diodati, la lotta di Giacobbe con l’inviato di Dio (Genesi 32, 24-26), e dell’uomo con Dio stesso. Così lottano nella storia e nei libri, e nella coscienza d’ognuno, Gesù e Giuda; e alla fine, ogni volta, Gesù lo benedice.
_____________________________________________
Letteratura e tradimento
di Antonio Di Grado
Claudiana – Torino, 2007
Euro 13,50
Pubblicato in SEGNALAZIONI E RECENSIONI 56 commenti »
martedì, 16 ottobre 2007
UNA STORIA AI DELFINI di MariaGiovanna Luini (recensione di Barbara Gozzi)
MariaGiovanna Luini, ‘Una storia ai delfini’ (Edizioni Creativa all’interno della collana ‘Declinato al femminile’ diretta da Francesca Mazzucato).
Il primo romanzo di MariaGiovanna Luini è la storia di una donna.
Una donna tratteggiata da subito come ‘la pazza’ per le bizzarrie della sua attuale vita, quella che, nel momento in cui racconta, è diventata routine necessaria, stacco dal resto del mondo e dalla gente. Perchè questo romanzo è il racconto di Lucia, che vive sola in barca e ha disimparato a parlare. Viaggia e scrive. Finchè una pinna. Poi due, tre e così via. Un branco di delfini la segue e “sembrava che sapessero dove stavo andando, che lo sapessero meglio di me e volessero ricordarlo al povero cervello liquefatto dal tempo” (pag.17). Inizia così il viaggio, questo racconto che è in realtà il diario della protagonista con un intento ben preciso: “raccontare la mia storia non significa dirvi cose che non interessano più neanche a me. Significa forse spiegare ai delfini […] perchè vivo su una barca bianca ormeggiata in un porto qualsiasi, perchè ho perso la voglia di parlare e ascoltare, perchè non sono più io.” (pag.20)
Sono dunque gli occhi di una donna che narrano il passato arrivando a spiegare un presente all’apparenza solitario ma che cela profondi solchi, cicatrici indelebili di un’esistenza vissuta a due velocità. La scelta di un io narratore in prima persona diventa un espediente necessario per permettere al lettore di entrare nella vita della protagonista assaporandone odori e colori amplificati. Percepiti intensamente. La lunghezza stessa del romanzo facilita a mio avviso questo processo in quanto non stanca il lettore anzi, lo guida verso un viaggio pieno. Un assolo semplice ed efficace. Allo stesso tempo le descrizioni che fa Lucia dei luoghi che ama costeggiare, dove si ferma per visite veloci sono il tratteggio che serve al lettore per inserire la trama in un ambiente preciso tra il mare e Ponza, in netto contrasto con gli appartamenti milanesi sempre piccoli dove ha vissuto in passato. “Ponza è l’isola che placa il mio cuore” (pag.59) spiega Lucia.
La storia destinata ai delfini è dunque il viaggio di una donna tormentata. Contradditoria. Fragile e fiera. Una donna che vive molti anni nell’apatia, nell’accettazione di avvenimenti avvertiti nel profondo come sbagliati e disumani. Errori per sua stessa ammissione ai quali, però non si ribella, chiude gli occhi e ne aspetta la fine nel disperato quanto fallimentare tentativo di non perdere l’uomo che crede di amare. Da qui i silenzi, i pensieri abbandonati e “il lungo e freddo buio” (pag.44) che la porterà a disimparare il piacere fisico pur di non contraddire il marito. “Mio marito mi amava e io lo assecondavo in tutto. Proprio in tutto” (pag.47) chiarisce Lucia che arriverà fino a sprofondare in un’ “apatica accettazione della realtà” (pag.49) quando il marito tanto venerato si innamorerà di un’altra. Sarà una circostanza drammatica a scuoterla, a riportarla alla vita con la ferocia tipica delle malattie destinate ad annullare tutto, a spazzare via tempi e pause. Lucia prova a ignorare i segnali, si trincera dietro a finzioni sporadiche, blandi tentativi di congelare una realtà che non vuole, non accetta. Poi l’inevitabile, una ripresa lenta e nuove gioie. Fino al crollo finale e a un equilibrio fragile ma stabile che le permette di raccontarsi ai delfini con occhio critico ma consapevole. Perchè questo libro racconta un’intera esistenza e lo fa denudandosi, senza risparmiarsi niente, dando in pasto al lettore ogni emozione senza filtri e, come spesso accade nella realtà quotidiana, tracciando quelle rotte che mutano e ci portano ad amare e a perdere.
In tutto questo sentire e trasmettere, i delfini appaiono in distanza; sbucano in punta di piedi e sembra quasi che sorridano rassicuranti a Lucia che è l’unione di frammenti della MariaGiovanna scrittrice donna e medico. “Scriverò la mia storia e la regalerò a loro, insieme al ricordo straziante della mia felicità. Del senso perduto della mia esistenza.” (pag.71) E’ tutto riassunto in questa frase. Una felicità che strazia e un’esistenza perduta ma comunque vissuta, a due velocità come accennavo poco fa, ma pur sempre assaporata fino in fondo. Perchè Lucia è un personaggio mutevole, che passa dall’immobilità dell’accettazione passiva alla forza per riappropriarsi dei colori, di quegli aromi mai assaporati fino in fondo che diventano per lei linfa vitale. Lucia smette di operare e si dedica anima e corpo agli affetti e alla scrittura che diventa per lei valvola di sfogo, strumento di esternazione emozionale.
Credo che in questo libro si sentano i respiri dell’autrice in molti angoli. Non è un testo autobiografico per sua stessa ammissione però racchiude frammenti della MariaGiovanna Luini medico e della donna che in barca scrive, entra nei sentimenti altrui e li scava. Accoglie le gioie ma sopratutto i dolori come parte integrante di un vivere a pieno ogni giornata.
Ed è proprio l’accettazione del dolore la parte che più mi ha colpita. Un finale che vuole essere anche un messaggio senza la pretesa di insegnare o imporsi ma con l’intento delicato di lasciare addosso qualcosa al lettore che ha seguito fin lì i delfini.
“Quando fuggivo dallo strazio della disperazione le mie gambe correvano veloci e la ricerca affannosa dell’oblio consumava ogni energia […] Poi qualcosa ha rallentato i miei passi e l’andatura più lenta ha permesso al dolore di raggiungermi.” (pag.95). Ecco dunque l’essenza dello scrivere questa storia. Ma prima ancora del riflettere. Dell’accettare l’onda dolorosa e traziante perchè il dolore non si annulla né si può mescolarlo con altro nella speranza che la sua voce sia meno graffiante, “è inutile combatterlo” (pag.95).
La prefazione di Umberto Veronesi è straordinariamente pulsante. C’è l’uomo di scienza che osserva le sofferenze umane ogni giorno e cerca di alleviarle non senza fallimenti e “l’impotenza di fronte alla loro invasione nel nostro sottile e fragile filo esistenziale” (pag.11). Ma c’è anche l’uomo che si immerge nell’universo femminile e ne condivide fragilità e punti di forza.
‘Una storia ai delfini’ apre il cuore di una donna e lo mostra così com’è. Pulsante. Scalfito. Sincero e silenzioso. Immobile quanto frenetico. Innamorato e apatico. E’ una storia che si potrebbe etichettare ‘come tante’ ma sarebbe un tentativo ridicolo di sminuirla. E’ un romanzo che scava nelle profondità degli avvenimenti cercandone i nodi. Le emozioni più forti e nascoste.
La scrittura della Luini è scorrevole, la scelta delle parole è accurata. E la struttura narrativa lineare permette una lettura fluida e immediata. Per chi fosse interessato, segnalo i blog dell’autrice dove periodicamente vengono pubblicati piccoli racconti, flash narrativi:
http://mariagiovannaluini.splinder.com/, http://mariagiovanna.typepad.com/.
Altri riferimenti web: Il sito della casa editrice, il blog della collana ‘Declinato al femminile’.
Barbara Gozzi
__________________________________
Una storia di delfini di MariaGiovanna Luini
Edizioni Creativa, 2007
collana Declinato al femminile
pagg. 110, euro 10
Pubblicato in SEGNALAZIONI E RECENSIONI 120 commenti »
lunedì, 15 ottobre 2007
COME SONO BELLI I LIBRI CHE NON SI LEGGONO
I dati relativi alla nuova indagine Ipsos su libri e letture non sono certo rassicuranti. Ne ha scritto Mirella Appiotti su Tuttolibri de La Stampa, interagendo con Gian Arturo Ferrari, direttore generale libri Mondadori, e Stefano Mauri, presidente e ad del Gruppo Mauri-Spagnol.
“Letture: Solo il 38% del campione legge 1 libro l’anno (nel 2003 il 39%, nel 2005 il 46% «effetto presunto – dice Ferrari – dei libri allegati ai giornali e di best seller tipo Dan Brown»).
Acquisti: il 71% non compra neppure un libro (il 65% del 2005).
Fenomeno generale: Polarizzazione sociale del Paese, forbice che si allarga drammaticamente, la fascia alta della popolazione compra di più, sempre meno l’Italia povera. Di qui, crollo al Sud: -8% di lettori dal 2003. Benino il Centro Italia al +10% di «acquirenti», con Roma «capace di esprimere grande vivacità…»; solo un +2% di lettori al Nord, leggero calo dei «lettori forti».
«Il libro, una perdita di tempo» secondo il 61% degli intervistati.
«La lettura? Pesante» per il 20% del campione perché «gli ricorda la scuola».
«In nessun Paese del mondo l’esperienza scolastica lascia un ricordo così negativo» ha commentato Ferrari. L’uomo più potente dell’editoria italiana, che afferma di non parlare pro domo sua «l’industria editoriale non patendo più di tanto il fenomeno, siamo pur sempre il 6° mercato del mondo», sottolinea comunque come i lettori tra i 25 e i 34 anni siano cresciuti dal 2003 del 4%. «Basterebbero 10 milioni di euro dello Stato per intraprendere tra i bambini una campagna quinquennale di promozione della lettura con frutti sicuri». Stefano Mauri sostiene quanto segue: «Vorrei collegare due cose emerse. La prima, per l’appunto, è l’aumento della lettura tra i giovani dai 25 anni. La seconda è che i non lettori non hanno capito, in gran parte, quale magnifica fonte di svago possa essere un libro»”.
Sullo stesso numero di Ttl compare un articolo di Ferdinando Camon (cfr. Ttl del 13 ottobre 2007, pag. 2, rubrica “L’opinione”) intitolato “Non bastano i libri belli”. Camon cita i dati Ipsos e chiama in causa Corrado Augias. Vi propongo di seguito l’articolo:
“Apro il libro di Corrado Augias Leggere (Mondadori, pp. 120, e 12), davanti al computer acceso, e sul monitor arriva un lancio Ansa: «Leggere? Per gli italiani è tempo perso». Continua: «Il 61% degli italiani non leggono nemmeno un libro all’anno, per il 12% leggere è tempo sprecato, per il 16 nella vita ci sono cose più divertenti, e per il 33 ci sono cose più utili». Nessuna meraviglia se i nostri ragazzi sono meno preparati dei coetanei europei. Ce l’ha appena detto l’Europa, con un’indagine di poche settimane fa. I nostri ragazzi sono messi peggio della media europea, per l’abbandono scolastico e per la percentuale di laureati. Il dato più triste è che dal 2003 ad oggi i lettori, in Italia, sono calati. Ma allora, il successo dei festival letterari? Il festival di Mantova funziona in maniera strana: la gente che ci va è tanta, ma è sempre gente che già legge, non è gente nuova. Adesso vediamo cosa fa Pordenone. Per ora «Pordenonelegge» deve fare se stesso, e ci riesce: fa notizia, attira gente, crea l’evento. Ma tutti questi sono festival di scrittori. La vera festa del libro resta la Fiera di Torino, ineguagliata. Le trasmissioni televisive avevano una loro utilità: sì, lanciavano pochi libri, ma li lanciavano molto. Una fra le migliori era quella di Corrado Augias. Evidentemente, scrivendo questo libro, Augias obbedisce ancora all’istinto missionario di chiamare il pubblico ai libri, perché «i libri ci rendono migliori, più liberi e più allegri». Bisogna leggere, dice, perché «i libri sono belli». E usa, con cenni molto rapidi o presentazioni un po’ più solide, un centinaio circa di libri. C’è anche un capitolo sul leggere che fa male, ma a ben guardare anche quello fa bene: don Chisciotte, Madame Bovary, Paolo e Francesca, Eloisa e Abelardo sono travolti dai libri che leggono, ma in quel travolgimento trovano il senso della vita. Tutto ciò che si fa per far leggere è ben fatto. Ma l’impresa di Augias mi ricorda quella di Thomas Merton: Merton s’è convertito al cattolicesimo perché «le cattedrali cattoliche sono belle», e voleva convertire il mondo spiegando a tutti che «le cattedrali cattoliche sono belle». Dubito che ci sia riuscito: gli altri uomini hanno altre bellezze. Augias vuol convertire i non-lettori spiegando che i libri sono belli. E’ difficile. I non lettori, dice l’Ansa, hanno le loro belle cose da fare”.
___________________________________
Verrebbe da dire: siamo alle solite.
Commentate l’articolo di Camon, se volete.
Poi vi domando: secondo voi cosa bisognerebbe fare per incentivare la lettura di questi famigerati libri ?
Magari potrebbe venire fuori un’idea innovativa.
Chi lo sa?
A voi!
Massimo Maugeri
_______________________________________________________
AGGIORNAMENTO del 17 ottobre 2007
Ringrazio moltissimo Ferdinando Camon per il suo intervento nel dibattito che è nato dopo la pubblicazione del post. Il “perché leggere” che troverete di seguito – un bellissimo spot a favore della lettura – è tratto dal suo libro “Tenebre su tenebre” (Garzanti, 2006, pagg. 355, euro 18)
In questo libro Ferdinando Camon usa una lente che permette di cogliere, oltre il brusio della cronaca, certe onde lunghe che sommuovono nel profondo tanto la realtà quanto noi stessi. La memoria della civiltà contadina e la percezione del mutamento, la scrittura e la psicoanalisi, la famiglia e il sesso, la religione e la religiosità, il corpo e la biologia, la guerra e la morte, il denaro e il potere, la solitudine e i popoli: sono questi gli aspetti dell’esperienza su cui Camon s’accanisce, e al tempo stesso gli strumenti con cui misura il mondo. O, per meglio dire, gli strumenti con cui lo soppesa, in tutta la sua feroce insensatezza. Così, pagina dopo pagina, s’inscrive una diagnosi impietosa del nostro tempo e delle sue perversioni, in un libro di lotta che turba e ferisce.
PERCHÉ LEGGERE
Chi vive, vive la propria vita. Chi legge, vive anche le vite altrui. Ma poiché una vita esiste in relazione con le altre vite, chi non legge non entra in questa relazione, e dunque non vive nemmeno la propria vita, la perde. La scrittura registra il lavoro del mondo. Chi legge libri e articoli, eredita questo lavoro, ne viene trasformato, alla fine di ogni libro o di ogni giornale è diverso da com’era all’inizio. Se qualcuno non legge libri né giornali, ignora quel lavoro, è come se il mondo lavorasse per tutti ma non per lui, l’umanità corre ma lui è fermo. La lettura permette di conoscere le civiltà altrui. Ma poiché la propria civiltà si conosce solo in relazione con le altre civiltà, chi non legge non conosce nemmeno la civiltà in cui è nato: egli è estraneo al suo tempo e alla sua gente. Un popolo non può permettersi di avere individui che non leggono. E’ come avere elementi a-sociali, che frenano la storia. O individui non vaccinati, portatori di malattie. Bisogna essere vaccinati per sé e per gli altri. Perciò leggere non è soltanto un diritto, è anche un dovere. Nelle relazioni tra i popoli, la prima e più importante forma di solidarietà è dare informazioni: mai l’altro dev’essere convertito alla nostra supposta superiorità, ma sempre messo in condizioni di scegliere tra le sue informazioni e le nostre. Quando una cultura si ritiene nella fase di superiorità tale che tutte le altre culture devono apprendere da lei, per il loro bene, e lei non può apprendere da nessuna, comincia la sua decadenza.
Ferdinando Camon
Pubblicato in IL SOTTOSUOLO (di Ferdinando Camon), PERPLESSITA', POLEMICHE, PETTEGOLEZZI E BURLE 136 commenti »
giovedì, 11 ottobre 2007
DORIS LESSING VINCE IL NOBEL PER LA LETTERATURA 2007
Diamo la notizia in tempo reale (h. 13): Doris Lessing, autrice britannica nata in Iran – ex Persia – (nel 1919) ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2007. Come al solito le voci della vigilia si sono bruciate nell’aria fritta che le aveva generate. Nelle ultime ore si parlava di una probabile vittoria di Claudio Magris (dimenticando la recente attribuzione del Nobel a un italiano: Dario Fo). Gli altri nomi che circolavano erano Philip Roth, Les Murray, Vargas Llosa, Amos Oz.
La Lessing è un’autrice nota – in Italia la pubblicano Feltrinelli e Fanucci- ma la sua vittoria quest’anno era piuttosto inattesa. Ecco la motivazione del Premio: “that epicist of the female experience, who with scepticism, fire and visionary power has subjected a divided civilisation to scrutiny”.
(“cantrice dell’esperienza femminile, che con scetticismo, passione e potere visionario ha messo sotto esame una civiltà divisa”).
I suoi libri più importanti sono: L’erba canta, Le nonne, Il taccuino d’oro, Il senso della memoria, Sotto la pelle.
Videointervista di RaiNews24 a Doris Lessing (precedente al Premio)
Riporto di seguito la biografia di Doris Lessing pubblicata su Wikipedia Italia.
Poi aspetto i vostri commenti. Non mancate!
______________________________
Doris Lessing (22 ottobre 1919) è una scrittrice inglese, nata Doris May Tayler, a Kermanshah in Persia (Iran).
Il padre, un ufficiale britannico reduce della prima guerra mondiale, dove aveva sofferto diverse amputazioni, aveva sposato la madre di Doris, una infermiera, e si era trasferito in Iran dove lavorava come impiegato di banca. La sua famiglia si trasferì nella colonia inglese della Rhodesia del Sud (l’odierno Zimbabwe) nel 1925, conducendo la difficile vita dei coltivatori di mais. Sfortunatamente i mille acri di bush africano non divennero sufficientemente fecondi, ostacolando il desiderio della madre di vivere il sogno vittoriano delle “terre selvagge”.
Doris Lessing frequentò una scuola cattolica femminile, sebbene la sua famiglia non fosse cattolica. Anche come manifestazione del suo conflitto con la severità materna, lasciò la scuola all’età di quindici anni, divenendo da quel momento autodidatta.
Nonostante le difficoltà e un’infanzia infelice, le opere della Lessing sulla vita nell’Africa Inglese sono piene di compassione sia per le infruttuose vite dei coloni britannici sia per le sfortune degli indigeni.
Si è sposata due volte (entrambe seguite dal divorzio) e ha tre figli. Il secondo marito fu Gottfried Lessing, un emigrante tedesco. Il suo primo romanzo, L’erba canta, fu pubblicato a Londra nel 1949 (anno del secondo divorzio), dopo il suo trasferimento in Europa, dove ha vissuto da allora.
Nel 2001 fu premiata con il Premio Príncipe de Asturias nella categoria Letteratura per le sue opere in difesa della libertà e del Terzo Mondo e il Premio Grinzane Cavour. Ha ricevuto inoltre il David Cohen British Literature Prize.
Le opere della Lessing sono comunemente divise in tre periodi: Il comunismo (1944-1956) quando scrive radicalmente su temi sociali, Il tema psicologico (1956-1969) e il Sufismo che viene esplorato nella serie di Canopus. Dopo i temi sufisti la Lessing ha lavorato in tutte e tre le aree.
Il suo romanzo Il taccuino d’oro è considerato un classico della letteratura femminista da molti studiosi, ma stranamente non dall’autrice stessa. Il romanzo la fece entrare nella rosa dei possibili candidati al Premio Nobel, ma i suoi successivi romanzi di fantascienza l’hanno screditata, eliminandola dalla rosa dei possibili vincitori. La Lessing non ama l’idea di essere considerata un’autrice femminista. Quando una volta le chiesero perché, rispose:
« Quello che le femministe vogliono da me è qualcosa che loro non hanno preso in considerazione perché proviene dalla religione. Vogliono che sia loro testimone. Quello che veramente vorrebbero dirmi è ‘Sorella, starò al tuo fianco nella lotta per il giorno in cui quegli uomini bestiali non ci saranno più’. Veramente vogliono che si facciano affermazioni tanto semplificate sugli uomini e sulle donne? In effetti, lo vogliono davvero. Sono arrivata con grande rammarico a questa conclusione.»
Quando le chiedono quali dei suoi libri considera il più importante, la Lessing sceglie la serie fantascientifica di Canopus in Argos. Questi libri mostrano, da molti punti di vista, come una società avanzata può combattere l’evoluzione forzata (vedi anche il Ciclo delle Cinque Galassie di David Brin). La serie di Canopus è basata in parte sul sufismo, cui la Lessing fu introdotta da Idries Shah. I suoi primi lavori sullo “spazio interno” come Memorie di una sopravvissuta sono anch’essi connessi a questo tema.
A parte questo, ha scritto numerosi racconti sui gatti, che sono i suoi animali preferiti.
__________________________
Aggiornamento serale
Vi segnalo dei video su Repubblica Tv con impressioni a caldo della Nobel.
_________________________________________________________
AGGIORNAMENTO DEL 12 ottobre 2007
Fanucci Editore mi ha inviato un brano estratto del romanzo della Lessing che uscirà tra circa un mese, “Un pacifico matrimonio a Canopus”, inedito in Italia. Io ringrazio e pubblico. Credo sia un buon modo per far conoscere meglio questa autrice non più giovane, ma fresca di Nobel.
Preciso che Canopus in Argos è una serie ambientata in un nuovo Cosmo ove il destino della Terra dipende dalle interazioni di tre potenti imperi galattici.
(Massimo Maugeri)
—————————-
Nelle immense lande delle Zone, strani reami che circondano la Terra, si sta per celebrare un’unione le cui conseguenze potrebbero cambiare per sempre il destino del pianeta. La Zona Tre, un paradiso pacifico e matriarcale, è guidata da una mite regina, mentre la confinante Zona Quattro è una terra abbandonata alla guerra e al caos, schiacciata dal dominio del brutale re guerriero Ben-Ata. Il matrimonio tra i due, che rappresentano gli estremi princìpi di femminilità e mascolinità, minaccia di destabilizzare l’intero impero galattico e i reami delle Zone. In una potente commistione di mito, favola e allegoria, la stupefacente creazione visionaria di Doris Lessing riflette e ridefinisce la storia del mondo dalle sue più remote origini all’inevitabile e tragico processo di autodistruzione.
—————————————————————–
Doris Lessing, Un pacifico matrimonio a Canopus , 320 Pagine, Euro 16,00, Collana: Collezione Vintage, Fanucci 2007, Traduzione dall’inglese di Eleonora Federici
———————————————————————–
Prima edizione: ottobre 2007© – 1980 by Doris Lessing© – 2007 Fanucci Editore
Le dicerie portano pettegolezzi, ma ancor di più generano canzoni. Noi, i Cronisti e compositori della nostra Zona, dichiarammo che ancor prima che i partner di queste nozze esemplari comprendessero il significato che le nuove direttive avrebbero avuto sule loro vite, le canzoni erano nostre e venivano ampliate e composte da una parte all’altra della Zona Tre. E lo stesso accadeva nella Zona Quattro.
Il grande nel piccolo
L’alto nel basso
Il tre nel quattro
Non può funzionare,
Questa era una filastrocca per bambini. Li stavo guardando dalla finestra il giorno che seppi la notizia. E uno di loro mi corse incontro facendomi un indovinello che gli avevano insegnato i genitori: nell’unione tra un cigno e un papero, chi ha la meglio?Decidemmo di non registrare ciò che veniva composto o cantato negli accampamenti e nelle baracche della Zona Quattro. Non è per esprimersi con mezzi termini, ma piuttosto perché ogni cronaca deve avere il tono giusto. Sto dicendo forse che uno disdegnava l’altro? No, non ci è permesso criticare ciò che ci viene dato dai nostri Tutori, ma si può dire che nella Zona Tre non dimentichiamo. Una poesia burlesca di quei giorni suonava così:
Il tre viene prima del quattro
Da noi c’è pace e abbondanza
Da loro… la guerra!
Erano giorni lontani, prima che tutto accadesse. Mentre questo sposalizio era celebrato nell’immaginazione di entrambi i reami, i due protagonisti erano più preoccupati. Non capivano cosa si volesse da loro. Nessuno si era aspettato queste nozze. Nessuno ci aveva pensato. Le Zone Tre e Quattro se la cavavano bene, con l’aiuto di Al-Ith per noi e Ben Ata per loro. O così perlomeno pensavamo noi.A parte la questione delle nozze, c’erano moltri altri argomenti. Cosa significava che Al Ith fosse stata chiamata nel territorio di Ben Ata, cosicché lo sposalizio avesse luogo là? Era questo che ci chiedevamo. Che significato avevano queste nozze?A cosa portava questo matrimonio? Quando Al-Ith venne a sapere dell’Ordine, pensò fosse uno scherzo. Lei e la sorella ne risero. Tutta la Zona Tre sapeva quanto ne avessero riso. Poi arrivò un messaggio che poteva essere interpretato solo come un rimprovero, e le persone iniziarono a incontrarsi in consigli e conferenze in tutta la Zona. Ci fecero chiamare – i Cronisti, i poeti, i compositori di canzoni e gli archivisti delle Memorie. Per settimane non si parlò che di matrimoni e sposalizi, e ogni ballata e vecchia storia venne ripresa e riletta con attenzione, in cerca di informazioni.
Dei messaggeri vennero mandati nella Zona Cinque, dove pensavamo avessero luogo matrimoni di qualche tipo. Ma c’erano guerre lungo tutti i confini della Zona Quattro, e non riuscimmo ad entrare in quel territorio. Se il matrimonio doveva aver luogo seguendo deteminati riti, forse le Zone Tre e Quattro dovevano organizzare un vero e proprio festeggiamento? Ma queste Zone non potevano mescolarsi, erano nemiche per natura. Non eravamo nemmeno sicuri di dove si trovasse la frontiera. La nostra non era pattugliata. Gli abitanti della Zona Tre che vivevano vicino ad essa, se vi si avvicinavano per curiosità, soprattutto bambini e giovani, ne erano ripugnati, o almeno provavano una forte sensazione negativa per quell’atmosfera; sembrava un luogo in letargo, ed estremamente noioso. Non si può certo dire che la Zona Quattro provasse per noi attrazione o fascino per il proibito: la cosa più accurata che posso sostenere è che ce ne dimenticammo.
Forse avrebbero dovuto esserci due festeggiamenti distinti e simultanei, in ciascuno dei territori, così diversi uno dall’altro. Almeno avrebbe avuto un significato. Ma aveva senso? Dopotutto, festeggiamenti e celebrazioni non erano piaceri di cui dovessimo fare a meno. Forse dovevamo organizzare dei pranzi di nozze tra di noi per celebrare l’evento? Ci servivano nuovi vestiti? Addobbi per le strade? Regali? Tutto questo veniva raccontato nelle vecchie storie e canzoni.
Trascorse del tempo. Sapevamo che Al-Ith era giù di morale, e restava chiusa nella sua stanza. Non lo aveva mai fatto prima, era sempre stata disponibile con noi. Le donne erano arrabbiate e scoraggiate per queste nozze. I bambini soffrivano. Poi arrivarono i primi segni visibili della nuova èra. Ben Ata inviò un messaggio annunciando che i suoi uomini sarebbero venuti a prenderla per scortarla da lui. Questo era l’atteggiamento che ci aspettavamo dalla sua Zona. Un regno dedito alla guerra non aveva bisogno di un atteggiamento gentile. Era la prima prova che il nostro timore e riluttanza di essere maltrattati dalla Zona Quattro era giustificato.
Al-Ith era risentita, si ribellava a questo. Disse che non sarebbe andata.
Seguì un altro Ordine: diceva semplicemente che era obbligata a farlo. Al-Ith indossò il vestito blu da lutto, unica espressione dei suoi sentimenti che poteva ancora concedersi. Non diede alcuna istruzione per un Cordoglio, ma tutti ne sentivamo l’esigenza. La sentivamo in modo confuso e – sospettavamo – ingiustamente. Non siamo abituati a questo tipo di emozioni. Non abbiamo memoria di averle provate in passato. Come individui di questo regno non ci aspettiamo – non ci viene chiesto – di soffrire, piangere o gemere. Può forse succederci qualcosa che non accade ad altri in un altro momento? Il dolore per una perdita, per un lutto, è formalizzato, ritualizzato in pubbliche occasioni considerate canali e veicoli per i nostri personali sentimenti. Non significa che non proviamo sentimenti! Ma pensiamo che debbano essere mostrati e che servano a rafforzare un concezione di noi stessi e del nostro regno. Ma con questa scelta di Al-Ith, sembrava stesse accadendo il contrario. Mai la nostra Zona pianse tante lacrime, fece accuse e provò sentimenti tanto irrazionali.
Al-Ith chiamò a sé tutti i suoi figli, e quando piansero non li confortò. Disse che questo le era dovuto e non doveva essere considerato un atto di ribellione. Ci fu chi tra di noi – molti – si sentì turbato; altri la criticarono. Non ricordavamo nulla che assomigliasse a questo; e iniziammo subito a parlare di quanto tempo era passato dall’ultimo ordine dei Tutori che avevamo ricevuto. Di come precedenti cambiamenti del Bisogno – che ci era sempre stato riferito semplicemente, e senza altra spiegazione con questa sola parola – fossero stati da noi vissuti. Del perché ora doveva verificarsi un simile stravolgimento. Ci chiedemmo se per caso avessimo iniziato a vedere noi stessi in modo falsato. Ma come potevamo non approvare la nostra armonia, il benessere e la prosperità della nostra terra? Credevamo che la nostra Zona fosse uguale alle altre per la ricchezza e l’assenza di discordia. È stato forse uno sbaglio esserne così fieri? E ci rendemmo conto di quanto tempo era trascorso dall’ultima volta che ci eravamo chiesti cosa succedesse oltre i nostri confini. Sapevamo che la Zona Tre era solo uno dei regni amministrati da Lassù. Pensavamo, le poche volte che lo facevamo, di interagire con gli altri regni, ma in modo astratto. Ci comportavamo forse come persone di strette vedute? Che non avevamo bisogno di nessuno?Al-Ith aspettava nella sua stanza. E arrivarono, una truppa di venti soldati a cavallo con le armature. Avevano scudi per proteggersi dalla nostra aria, per non ammalarsi, e questo era giusto. Ma perché anche una protezione per le teste e le famose armature della zona Quattro che potevano respingere ogni arma? Tutti quelli che erano vicino al percorso di quegli ospiti non graditi avevano un’espressione cupa e si mostravano critici nei loro riguardi. Eravamo determinati a non dare alcun segno di approvazione. Ma anche i soldati non ci salutarono. Percorsero in silenzio il tratto fino al palazzo e si fermarono sotto le finestre di Al-Ith. Un cavallo con sella e briglie era senza cavaliere. Al-Ith li vide. Seguì una lunga attesa. Poi emerse in cima al lungo scalone bianco, una figura vestita di scuro. Rimase in silenzio e osservò i soldati: un tale comportamento nel suo regno poteva solo significare essere un prigioniero di guerra. Lasciò loro il tempo di guardarla, di ammirare la sua bellezza, la sua forza, la sua sicurezza, il suo portamento regale. Poi scese la gradinata lentamente, da sola. Si diresse verso il cavallo che avevano portato per lei, lo guardò negli occhi, e gli accarezzò il muso. Il nome del cavallo era Yori, che da quel momento venne citato nelle narrazioni. Era un bel cavallo nero ma non più possente di quello dei soldati. Dopo averlo salutato, tolse la pesante sella. La tenne tra le braccia rivolgendo lo sguardo agli uomini finchè uno di loro capì cosa voleva fare. Allora lei gli gettò la sella e lui dovette bilanciarsi per reggerne il peso. Le rivolse un sorriso divertito, guardando i compagni, mentre lei restava ferma con le braccia incrociate a osservarli. Era il tipo di sorriso che si fa ad un bambino intelligente che riesce a fare qualcosa di più grande di lui. Tutto ciò non sfuggì a Al-Ith, che dimostrò loro che non avevano capito le sue vere intenzioni, togliendo all’animale con gesto lento e deliberato anche le briglie, che lanciò a un altro soldato. Poi reclinò il capo all’indietro, scuotendolo, in modo che i suoi capelli neri che teneva dolcemente legati le ricadessero lungo la schiena. Le nostre donne acconciano i capelli in diversi modi, ma se sono raccolti, in trecce o in altra maniera, e vengono scossi e liberati dall’intreccio, quello è considerato un gesto di afflizione. Ma i soldati non lo compresero, e restarono ad ammirarla, come degli sciocchi; forse lei aveva voluto lanciare un segnale agli astanti che ora affollavano la piccola piazza. Al-Ith aveva le labbra arricciate in una smorfia di disprezzo nei confronti dei soldati, e d’impazienza. Devo registrare qui che una simile forma di arroganza – sì, è necessario chiamarla in questo modo – non era qualcosa che ci saremmo aspettati da lei. Quando tornammo a parlare di quell’episodio, tutti furono d’accordo nel dire che l’amarezza che Al-Ith mostrava nei confronti del matrimonio si stava probabilmente ritorcendo contro di lei.
In piedi, con i capelli sciolti e gli occhi di fuoco, si avvolse lentamente un elegante velo nero intorno alle spalle e alla testa. Sempre mostrando il proprio dolore. Dietro quello scuro strato trasparente rilucevano i suoi occhi. Un soldato tentava in modo maldestro di scendere dal proprio cavallo per aiutarla a salire sul suo, ma lei era montata già prima che l’uomo toccasse terra. Lei fece voltare l’animale e galoppò via, attraversando i prati, diretta a est, alla volta dei confini della Zona Quattro. I soldati si lanciarono dietro di lei. A noi che li osservavamo, parve un inseguimento.
Fuori dalla nostra città, frenò il cavallo e lo fece procedere al passo. Gli altri la imitarono. La gente, ai bordi delle strade, la salutava e fissava i soldati, che non sembravamo più inseguirla, perché ora, imbarazzati, sorridevano come sciocchi, mentre Al-Ith pareva tornata quella di sempre. C’è una discesa che parte dall’altopiano al centro della nostra terra e attraversa strettoie e gole: non era possibile procedere troppo speditamente, e non solo perché Al-Ith si fermava ogni volta che qualcuno desiderava parlare con lei. Ogni volta che notava una persona che voleva rivolgerle la parola, infatti, fermava il cavallo e la lasciava avvicinare. Ora i sorrisi che i soldati si scambiavano erano differenti, e molti si lagnavano, perché erano convinti che sarebbero rientrati nei loro confini per l’imbrunire. Alla fine, quando un ennesimo gruppo di persone le aveva fatto segno e l’aveva chiamata, e lei aveva udito le voci dei soldati che si sollevavano dietro di lei, si era voltata portandosi a pochi passi da loro, costringendoli a frenare i loro animali bruscamente.
«Qual è il problema?» domandò. «Non sarebbe meglio che me lo diceste apertamente, invece di lamentarvi tra voi come dei bambini?»
Gli uomini non gradirono quell’osservazione, e tra loro si levò un turbine d’ira che il comandante soffocò.
«Abbiamo ordini da rispettare» rispose quest’ultimo.
«Finché resto nel mio Paese,» rispose lei «mi comporterò secondo le nostre usanze.»
Si accorse che non l’avevano capita, e dovette spiegarsi. «Ho la posizione che detengo per volere del popolo. Non posso avere l’arroganza di passare oltre, se qualcuno mi fa cenno di volermi dire qualcosa.»
Gli uomini si scambiarono altre occhiate. Il comandante non poté celare un’espressione impaziente.
«Non potete aspettarvi che io stravolga i nostri costumi e assuma i vostri in questo modo.» aggiunse lei.
«Abbiamo razioni d’emergenza sufficienti a un solo pasto» disse l’uomo.
Lei scosse appena il capo, come se non potesse credere a quanto aveva appena sentito. Il suo non voleva essere un gesto di disprezzo, ma così fu interpretato. Il comandante arrossì, ed esplose: «Ognuno di noi è in grado di digiunare per un’intera campagna, se necessario.»
«Non chiedevo tanto» rispose lei in tono grave, che questa volta fu preso per umorismo. Gli uomini risero, e lei riuscì a rivolgere loro un rapido sorriso, poi sospirò e aggiunse: «So che non vi trovate qui per vostra volontà, ma a causa dei Tutori.»
Ma quelle parole, per cause che lei non seppe spiegarsi, furono percepite come un insulto e una sfida, e i cavalli si agitarono e si mossero, percependo le emozioni dei loro cavalieri. Lei rispose con un’alzata di spalle, si voltò e andò verso il gruppo di giovani che la aspettavano all’angolo della strada. Dietro di loro, oltre le montagne, si intravedeva la pianura. I prati brillavano di giallo per il tramonto, e i picchi dei monti riflettevano il sole, ma il gruppo se ne stava all’ombra e al freddo. Gli uomini si raggrupparono attorno al cavallo parlando e mostrando di non avere alcun timore o paura, e il viso dei soldati rivelò il loro sgomento. Nel momento in cui un giovane accarezzò il muso dell’animale, gli uomini armati emisero all’unisono un sospiro di disapprovazione. Ma erano dubbiosi, in conflitto con loro stessi. Non potevano mostrare di disprezzare quel regno o i chi lo governava: lo sapevano. Eppure tutto ciò che vedevano, in ogni momento, contraddiceva il loro concetto di ciò che è giusto. Al-Ith alzò una mano per salutare i giovani, e i soldati si prepararono a partire a quel segnale che però non era stato rivolto a loro. Procedette cavalcando in testa al gruppo finché non furono tutti sulla pianura, poi si voltò di nuovo.
«Suggerisco che poniate qui l’accampamento, ora che abbiamo superato le montagne.»
«In primo luogo» le rispose il comandante in tono brusco – seccato dal fatto che i suoi uomini seguissero lei e non aspettassero i suoi ordini «in primo luogo, non ho preso in considerazione di fermarci prima di raggiungere la frontiera. E in secondo luogo…»
Ma la rabbia che provava lo fece tacere.
«È solo un suggerimento» disse lei «Ci vorranno nove, dieci ore prima di arrivare al confine.»
«Di questo passo certamente.»
«A qualsiasi passo. La maggior parte delle notti, sulla pianura soffia un forte vento da est.»
«Signora! Per chi ha preso questi uomini? Per chi ha preso tutti noi?»
«So che siete dei soldati» gli rispose. «Ma pensavo agli animali. Sono stanchi.»
«Seguiranno gli ordini. Come li seguiamo noi.»
I nostri Cronisti e artisti hanno rappresentato mirabilmente questo dialogo tra Al-Ith e i soldati. Alcune storie iniziano proprio da tale momento. Lei sta di fronte a loro, sul suo cavallo che tiene basso il muso per la fatica del viaggio. Lei lo accarezza con la mano bianca, che brilla di gioielli… Ma Al-Ith era nota per il suo modo di vestire semplice, per la mancanza di gemme o ornamenti regali! La raffigurano con i lunghi capelli neri al vento, il velo anch’esso mosso dal vento e fermato sulla fronte da un fermaglio brillante. Raffigurano la rabbia del comandante, il viso distorto, e il fare beffardo dei soldati. In lontananza, nuvole sparse e allungate dal vento e i campi della pianura.
In questa raffigurazione si ritrovano numerose specie di piccoli animali. Uccelli che volano sopra le loro teste. Un cerbiatto, animale molto amato dai nostri bambini, sul ciglio del sentiero, volge il proprio muso verso il cavallo di Al-Ith per confortarlo e portagli un messaggio da parte degli altri animali. Spesso questi dipinti sono intitolati Gli animali di Al-Ith. Alcune storie narrano dei soldati a caccia di uccelli e del cerbiatto, e di come essi vengano rimproverati da Al-Ith.
Mi prendo la libertà di dubitare che tale evento possa aver avuto un effetto drammatico sui soldati, e persino su Al-Ith. I soldati volevano proseguire e andare via da quella terra che non comprendevano e che li sconcertava. Il comandante non voleva ritrovarsi a dover seguire i consigli di una donna, ma non voleva nemmeno cavalcare per ore in quel vento freddo. Un vento che già soffiava forte.
Al-Ith si sentiva di nuovo sé stessa, molto di più che nelle settimane passate. Capì che avrebbe potuto fare molte altre cose invece che piangersi addosso nelle proprie stanze! Era stata negligente nei propri doveri. Si ricordò di tutti i messaggi ricevuti da ogni parte del regno a cui non aveva risposto perché troppo occupata a tenere a bada i sentimenti intensi che provava. Stava ritrovando in sé stessa una forte disobbedienza, e ciò che questo implicava. Questo la rese più gentile con quella truppa di barbari e con quel comandante, che era poco più che un ragazzo.
«Non mi ha detto il suo nome» gli disse.
Lui esitò. Poi rispose: «Jarnti.»
«È al comando dei cavalli del re?»
«Sono al comando di tutte le sue forze. Le forze armate del re.»
«Le mie scuse» sospirò lei, e la sentirono tutti. Pensarono fosse un segno di debolezza. Ogni volta che succedeva qualcosa del genere con lei, i soldati non potevano fare a meno di provare una sensazione di trionfo, la stessa che i barbari nutrono sempre quando si trovano davanti alla debolezza, così come sentono il bisogno di unirsi raggrupparsi davanti a una dimostrazione di forza.
«Vorrei allontanarmi per alcune ore» disse lei.
A quel punto, come spinti dallo stesso impulso, e senza alcuna indicazione dal loro comandante, la accerchiarono. Al-Ith si trovò al centro di un cerchio formato da coloro che l’avevano catturata.
«Non posso permetterlo» disse Jarnti.
«Quali sono gli ordini del re?» gli chiese. Era calma e paziente, ma tutti scambiarono il suo atteggiamento per arrendevolezza.
Si levò un coro di risa rauche. La tensione esplose. Ridevano e urlavano, e se ne sentiva l’eco nei dirupi alle loro spalle. Gli uccelli che si erano già posati per trascorrere la notte tornarono a levarsi in cielo. Nell’erba alta lungo la strada, gli animali che erano nascosti scapparono via.
Pubblicato in EVENTI, INTERVENTI E APPROFONDIMENTI 78 commenti »
martedì, 9 ottobre 2007
LA LUCE DI ORIONE: INTERVISTA A VALERIO EVANGELISTI (di Ippolito Edmondo Ferrario)

In questi giorni esce in libreria il nuovo romanzo di Valerio Evangelisti (nella foto). Il titolo è La luce di Orione. Anche questo libro è incentrato sulla figura dell’inquisitore spagnolo Nicolas Eymerich. Lo scrittore Ippolito Edmondo Ferrario (autore di questi romanzi) ha intervistato Evangelisti.
Prima dell’intervista trovate, di seguito, una breve nota introduttiva sul personaggio Nicolas Eymerich tratta da Wikipedia Italia.
__________________
Storicamente Nicolas Eymerich è un inquisitore domenicano realmente esistito (nato nel 1320 a Gerona, in Catalogna, e morto nel 1399). Il personaggio che Evangelisti ha mutuato dalla realtà storica è crudele, inflessibile, altero, tormentato, agisce con totale spietatezza al servizio della Chiesa e di ciò che ritiene il bene ed è tuttavia dotato di straordinaria intelligenza e di profonda cultura. Nei vari romanzi del ciclo indaga i fenomeni misteriosi nell’Europa medioevale influenzando strategicamente i grandi avvenimenti storici dell’epoca, ma la soluzione del mistero spesso la si ritrova in storie parallele a quella dell’intreccio principale, che si proiettano nel nostro presente e nel nostro futuro, volutamente rappresentato con toni oscuri, fondamentalisti e disumani.
__________________
Valerio Evangelisti torna a ottobre in libreria con il nono episodio del ciclo di romanzi dedicati alla figura storica dell’inquisitore spagnolo Nicolas Eymerich (1320-1399). “La luce di Orione” (Strade Blu Mondadori, www.eymerich.com) si prospetta come una nuova allucinata e allucinante avventura del domenicano che ha consacrato Evangelisti non solo in Italia, ma nel mondo. Tanto per fare un esempio i suoi romanzi e i racconti sono tradotti in francese, spagnolo ( per la Spagna e per il Messico), tedesco, portoghese (per Brasile e Portogallo), croato, serbo, greco, ceco, slovacco, russo, rumeno, ebraico, polacco, inglese.
Nonostante l’indubbia fama, Evangelisti da sempre segue un modello di vita piuttosto ritirata. Non frequenta i salotti mondani e tantomeno lo si vede in televisione. Per avere qualche anticipazione sul suo nuovo romanzo lo abbiamo intervistato.
-Qualche anticipazione sul nuovo romanzo “La luce di Orione”. Quale sarà il tema centrale di questa nuova storia?
Eymerich, nel romanzo, parte per ciò che resta dell’impero bizantino, su cui grava la minaccia degli Ottomani. I sovrani, in piena decadenza, contano per il loro riscatto su una creatura che tengono prigioniera, e che forse ha un nesso con misteriosi giganti che ogni mattina sorgono dal mare. L’inquisitore saprà svelare la chiave del mistero.
-L’inquisitore Nicolas Eymerich e lo scrittore Valerio Evangelisti: come è nato questo binomio?
Eymerich rappresenta il peggio di me, la parte oscura. Me ne accorsi mentre collaboravo alla stesura di un manuale di psicoterapia, giunto alla voce “la sub-personalità schizoide”. Decisi di spostare in un personaggio letterario ciò che di patologico esisteva in me.
-Crede che i lettori la identifichino con Eymerich?
No, o almeno capita raramente. Sono di indole tutto sommato cordiale, non spavento nessuno, non ho mai fatto del male ad anima viva. Certo, bisogna conoscermi di persona, e io mi faccio vedere poco in giro.
-Che cosa c’è di Valerio Evangelisti nella figura dell’inquisitore?
Una certa asocialità. Ma mentre Eymerich cerca adepti, e di modellare la società sul suo esempio umano, io tendo piuttosto a farmi i fatti miei. Somiglio maggiormente a un altro mio personaggio, il pistolero Pantera.
-Di recente ha partecipato a Trieste a un convegno sull’Inquisizione. Che cosa ne pensa dell’Inquisizione e del suo operato?
Largamente condannabile, sebbene il Santo Uffizio non sia stato colpevole di tutti gli eccessi che gli vengono attribuiti. Va poi tenuto presente che la Chiesa cattolica tentava di sostituire, con mezzi rudi, l’impero romano venuto meno. Ciò non toglie che coartasse le coscienze. Erede diretto dell’Inquisizione è stato il sovietico Vishinskij.
-La trama narrativa dei romanzi del ciclo di Eymerich si svolge sempre su più piani temporali, tra passato, presente e un futuro plausibile. Come mai?
Cerco di far capire come la personalità tenebrosa di Eymerich varchi le epoche storiche, e domini il nostro futuro ancor più che il nostro passato. Questo è un pericolo serio, che vivo con angoscia. Vedo in giro tanti eredi di Eymerich, sparsi per il mondo.
-L’inquisitore Eymerich, seppur riluttante alla ferocia e al sadismo, non si tira indietro di fronte all’uso della tortura per estorcere confessioni. Nonostante questo, chi legge i suoi libri si identifica inevitabilmente con l’inquisitore dandone un’impronta solo positiva. Come lo spiega?
La violenza di Eymerich è anzitutto psicologica. A volte ricorre alla tortura, ma senza trascendere. Credo che questo risponda a una verità storica, circa l’Inquisizione medioevale: fu quella rinascimentale a fare della tortura una prassi. Quanto all’attrazione esercitata da Eymerich, va considerato che lui è, di norma, molto più intelligente e colto dei suoi nemici. Inoltre tutto è visto attraverso i suoi occhi. L’identificazione è obbligata. Si tratta, per chi sa intenderlo, del “fascino discreto” dell’autoritarismo.
-In questo prossimo libro si parla dell’attuale guerra all’Iraq. Qual è il suo punto di vista sulla questione?
All’Iraq accenno proprio in “La luce di Orione”. Per il commento a quella guerra, cito una frase detta dal ministro napoleonico Fouché, in occasione del rapimento del duca d’Enghien: “Peggio di un crimine: un errore politico”.
-Quale sarebbe quello dell’inquisitore Eymerich?
Penso analogo al mio (e a quello di Fouché, cui somiglia). Forse più cinico.
-Dai suoi libri emergono temi d’attualità quali la scienza che sfugge al controllo dell’uomo, o meglio che viene asservita per scopi malefici. Come si pone di fronte al dilemma scienza o morale?
La morale, purché non superstiziosa o “bacchettona”, deve prevalere sempre.
-Se incontrasse Eymerich adesso che cosa gli direbbe?
Gli direi: “Come mai governi il mondo?”
-Una sua riflessione sull’attualità politica italiana.
Credo che uno scrittore debba occuparsi di questioni etiche generali, non di problemi partitici. Si individua una contraddizione, la si indica al lettore. Questi, al momento di votare, farà le sue scelte. Ho la fortuna di trascorrere in Messico alcuni mesi all’anno. Mi appassiona più la politica di laggiù, con tutte le sue turbolenze, di quella di casa nostra. Almeno, da quelle parti non esistono “Ballarò” né programmi altrettanto molesti, tipo “Matrix” o “Porta a porta”.
Pubblicato in SEGNALAZIONI E RECENSIONI 83 commenti »
sabato, 6 ottobre 2007
CENT’ANNI DI VITALIANO BRANCATI
Cent’anni fa nasceva Vitaliano Brancati (per l’esattezza il 24 luglio del 1907). C’è da dire che la ricorrenza non è passata inosservata. Se ne è parlato molto, quest’estate, sulle pagine culturali di quasi tutti quotidiani.
Vi propongo due video relativi alla bella mostra organizzata a Catania in occasione del centenario presso il centro fieristico “Le Ciminiere” (sponsorizzato dal Ministero dei Beni Culturali e dall’Assessorato alla Cultura della Provincia Regionale di Catania). Ne approfitto per ringraziare la professoressa Sarah Zappulla Muscarà per la sua disponibilità.
(Qualora non riusciste a visualizzare i video cliccate sui rispettivi titoli per poterli visionare direttamente su YouTube).
Di seguito vi riporto un mio articolo pubblicato sulla pagina Cultura de Il Mattino del 23 luglio 2007.
________________
Mostra centenario nascita Vitaliano Brancati (parte I)
Mostra centenario nascita Vitaliano Brancati (parte II)
___________
Cent’anni son passati da quel 24 luglio del 1907 che segnò la nascita di Vitaliano Brancati, autore siciliano che si è conquistato con merito un posto di rilevo nella storia della letteratura italiana del Novecento. Conquista avvenuta nonostante la prematura scomparsa, avvenuta a Torino il 25 settembre del 1954 quando aveva 47 anni: età – di norma – in cui uno scrittore comincia a dare il meglio di sé. Una ricorrenza da ben celebrare, dunque. La moglie Anna Proclemer – che al marito ha voluto dedicare un pensiero in cui esprime ammirazione e amore ancora vivi: «Darei quel che mi resta da vivere per avere la possibilità di leggere una tua pagina sulla realtà italiana di oggi» -, insieme alla figlia Antonia, domani sera a Catania presenterà alle «Ciminiere» il recital «Viaggio intorno a Brancati» e nello stesso giorno si aprirà la mostra «Dalla Sicilia all’Europa, attraverso Brancati», curata da Enzo Zappulla e Sarah Zappulla Muscarà, Annamaria Andreoli e Franca De Leo, nell’ambito di Etnafestival. Perché è bene ricordare il Brancati scrittore, ma gli onori della ricorrenza vanno tributati anche allo sceneggiatore di cinema, all’autore di opere teatrali, al saggista e giornalista. Sono tanti i meriti dell’autore nato a Pachino e cresciuto a Catania, ma tra tutti primeggia la capacità di aver saputo conferire alla propria opera una forte connotazione umoristica. Forse è proprio questa l’eredità principale che lascia. Del resto Brancati non ha mai nascosto l’importanza che egli stesso attribuiva al comico, come è dimostrabile da questo stralcio tratto dal volumetto I piaceri: «Si ha paura del comico come di un potere diabolico. (…) Il male di non sopportare l’ironia non è vecchio in Italia. Comincia col Seicento. Nel Cinquecento, invece, il popolo italiano possedeva, insieme col più alto senso della realtà (Machiavelli), la più intelligente e poetica ironia (Ariosto). Dopo quel secolo, l’ironia abbandona l’Italia, lasciando al suo posto una forma pigra, passiva, rozza come la vignetta o la barzelletta. Eppure in nessuna parte del mondo essa è necessaria come da noi». Sciascia individuò in Brancati lo scrittore nazionale che meglio aveva saputo rappresentare le due tragicommedie italiane: quella del fascismo e quella dell’erotismo, intrecciandole in un contesto in cui il rispetto della vita privata e delle idee dei singoli erano ignoti o dimenticati, e tratteggiandone – al tempo stesso – le manifestazioni comiche in guisa tale da inglobare nel comico anche le situazioni tragiche. Il comico, il grottesco, l’ironia beffarda, veicolati attraverso l’erotismo, esplodono in Don Giovanni in Sicilia e rimbalzano con intensità variabile nelle altre opere dell’autore siciliano, fino a cedere il passo al sorriso amaro che si trasmuta in ossessione tragica nelle pagine di Paolo il caldo. Nel corso delle celebrazioni le tematiche saranno approfondite e riproposte. Sperando che non venga riproposto con altrettanto zelo il termine «gallismo», anacronistico e usurato. Forse sarebbe meglio far riferimento al – più generico, ma efficace – «umorismo brancatiano». Come ha scritto Enzo Siciliano a proposito del Don Giovanni in Sicilia: «Non è lo straordinario caratteriale di una piccola comunità che Brancati racconta, ma l’ordinario della comunità nazionale. (…) Pensare che egli fosse semplicemente uno scrittore siciliano o catanese significa fargli torto: fare torto non solo alla vitalità della sua immaginazione, ma alla luciferina forza conoscitiva che la possedeva e che esprimeva». Ha ragione. Per questo comprimere, oggi, l’opera di Brancati nei confini angusti del «gallismo» potrebbe tradursi, implicitamente, in un’involontaria accusa di effimero e datato provincialismo.
Massimo Maugeri
Vorrei invitarvi a ricordare Brancati e le sue opere. Ci state?
Un suo libro che avete amato. Un film da lui sceneggiato, o tratto dalle sue opere, che ricordate con piacere. Una sua opera teatrale, o altro. Fate voi.
Grazie.
Pubblicato in EVENTI, INTERVENTI E APPROFONDIMENTI, LETTERATITUDINE TV, OMAGGI, RICORRENZE, ANNIVERSARI E CELEBRAZIONI 66 commenti »
mercoledì, 3 ottobre 2007
LE SACRESTIE DI COSA NOSTRA di Vincenzo Ceruso (recensione di Roberto Alajmo)
 In quel genere di attitudine del tutto personale rappresentato dalla lettura è raro che io mi sbilanci, ma una volta tanto mi sentirei di prescrivere la lettura di un libro: si intitola “Le sacrestie di Cosa Nostra”, di Vincenzo Ceruso, editore Newton Compton.
In quel genere di attitudine del tutto personale rappresentato dalla lettura è raro che io mi sbilanci, ma una volta tanto mi sentirei di prescrivere la lettura di un libro: si intitola “Le sacrestie di Cosa Nostra”, di Vincenzo Ceruso, editore Newton Compton.
E’ un libro di quelli che mettono in fila i fatti uno dietro l’altro, in modo che parlino da soli. I ragionamenti, quelli, vengono di conseguenza, e sono lasciati all’intelligenza del lettore.
Io, per dire, sono uscito dalla lettura rafforzato nell’idea che la chiesa sarà pure “santa”, “cattolica” e “apostolica”, ma di sicuro non è “una”. Nel senso che assume di volta in volta un atteggiamento differente a seconda dei contesti. Solo all’apparenza padre Pino Puglisi e don Agostino Coppola sono in contraddizione fra loro. Al contrario: rappresentano due volti fra i cento diversi che la chiesa è capace di rappresentare. Ognuno di essi copre un segmento di mercato, in modo che a ogni interpretazione della fede, anche la più perversa, corrisponda una rispettiva chiesa. C’è il prete mafioso e il prete antimafioso, così come c’è il prete pedofilo e il prete antipedofilia.
Se i mafiosi non trovano contraddittorio uccidere e pregare, anche la chiesa cattolica non trova contraddittorio assumere un aspetto proteiforme, in modo da trarre il massimo profitto in ogni circostanza.
Ferma restando la buona fede di individui come padre Puglisi, quello della chiesa, in Sicilia come altrove, è un puro gioco delle parti.
Roberto Alajmo
- – - -
Le sacrestie di Cosa Nostra
di Vincenzo Ceruso
Newton & Compton, 2007, euro 9,90, pagg. 270
_______________________________________________________________
Roberto Alajmo è nato a Palermo nel 1959. Fra i suoi libri: Le scarpe di Polifemo (Feltrinelli, 1998), e Notizia del disastro (Garzanti, 2001), col quale ha vinto il premio Mondello. Con Mondadori nel 2003 ha pubblicato il romanzo Cuore di Madre, finalista ai premi Strega e Campiello. Nel 2004 è uscito Nuovo repertorio dei pazzi della città di Palermo e nel 2005 il romanzo È stato il figlio, finalista al premio Viareggio e vincitore del SuperVittorini e SuperComisso.
Con Laterza, sempre nel 2005, ha pubblicato il saggio Palermo è una cipolla.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Aggiornamento del 4 ottobre 2007
L’ufficio stampa della Newton & Compton, di comune accordo con l’autore del libro, mi invia il prologo. Ringrazio e pubblico qui di seguito. (Massimo Maugeri)
—
Prologo
Non fai più parte di questo mondo.
Il capomafia Leoluca Bagarella
rivolto a un nuovo affiliato a Cosa nostra
La sagrestia è una terra di mezzo. Non sei in chiesa ma neppure al di fuori di essa. È uno spazio in cui sacro e profano si mescolano. Vi si trovano gli arredi sacri e i paramenti liturgici.
Il prete lo usa per cambiarsi prima delle funzioni. Ma è anche un posto dove ci si può fermare a parlare tranquillamente, senza il timore reverenziale che si prova nel luogo deputato al culto. La gente entra, chiede informazioni, parla con il sacerdote, talvolta si confessa. Questo libro è un reportage sulle sagrestie di Cosa nostra: «Un poco come un viaggio senza precedenti, un viaggio da inviato speciale non già sulla mafia, ma “dentro la mafia” [...]. Un lungo, fantastico viaggio, dentro un mondo anche per me sconosciuto: una esplorazione, una scoperta. Un viaggio dentro la mafia e “sotto il mondo”…» (Felice Chilanti, in «L’Ora», 15 settembre 1963).
Parlare di “sagrestie di Cosa nostra” ha un duplice significato: in un senso puramente geografico, si riferisce a quante si trovano in territori dove il controllo della mafia è profondamente radicato e tendenzialmente assoluto; poi vi sono le sagrestie per le quali i padrini hanno una particolare predilezione.
Sono quelle che i padrini sentono come cosa propria, dove celebrano le loro festività, si sposano, battezzano i figli, in cui si muovono a proprio agio, dove la loro presenza non è imposta per via autoritaria, ma in cui sono bene accolti; non come peccatori in cerca di redenzione, ma proprio per quello che sono: personaggi di rispetto, mafiosi riconosciuti e, in quanto tali, ossequiati. Ovviamente, le due cose non sempre coincidono. Le sagrestie di Palermo racchiudono molti dei segreti dell’Onorata società. Il viaggio ci condurrà in chiese molto diverse tra loro. Dalla chiesa di Maria SS. delle Grazie, nel cuore della terribile “mafia dei giardini”, alla chiesa di San Giuseppe, nel pieno centro storico del capoluogo siciliano, così amata dall’infelice Vincenza Marchese, sposa del sanguinario Leoluca Bagarella; dallo splendido duomo normanno di Monreale alle chiese del SS. Crocifisso e di Maria SS. del Carmelo, nelle borgate di Coceverde-Giardina e Ciaculli, per decenni occupate quasi militarmente dalla spietata famiglia dei Greco; senza dimenticare la chiesa, anzi le chiese, del mite e forte don Giuseppe Puglisi, ucciso dai sicari mafiosi il 15 settembre del 1993. Non solo San Gaetano, nel famigerato quartiere palermitano di Brancaccio, la cui liberazione il coraggioso prete pagò con il martirio; Puglisi maturò la sua resistenza alla mafia nei primi anni di sacerdozio, trascorsi anche in condizioni difficili, in diverse chiese della diocesi di Palermo, lasciando ovunque segni tangibili della sua presenza amica. Il suo ultimo incarico come parroco, in un territorio ad alta densità mafiosa, fu il tragico epilogo di una vita spesa per il Vangelo e contro tutto ciò che Cosa nostra rappresenta in Sicilia. Ma quale interesse possono avere i rappresentanti di un’organizzazione criminale che movimenta decine di miliardi di euro dappertutto, si occupa di traffici internazionali di stupefacenti, decide la vita e la morte di migliaia di affiliati, a inserirsi nella vita di una parrocchia o, comunque, a intromettersi nelle vicende religiose dei suoi membri?
A titolo esemplificativo, si può rispondere a questo interrogativo raccontando una storia. Ciccio Pastoia era il braccio destro dello “zio Binnu”, cioè Bernardo Provenzano, l’ultimo capo dei capi di Cosa nostra (“zio” è un titolo onorifico abbastanza diffuso in Sicilia), arrestato nell’aprile del 2006. Grazie a questa fiducia don Ciccio, originario di un piccolo paese dell’entroterra siciliano, chiamato Belmonte Mezzagno, si era ritrovato a comandare in mezza Sicilia e a decidere su ogni genere di affari, dalle poche centinaia di euro per il pizzo di un negozio fino ai miliardi di euro per il futuro ponte sullo Stretto.
Ciccio Pastoia prendeva ordini solo dal capo e a lui solo riferiva. Ma aveva commesso un errore. Si era fidato troppo della sua autonomia e aveva ordinato un omicidio senza informarne Provenzano. Quando venne arrestato i giornali pubblicarono alcune intercettazioni telefoniche, in cui Pastoia metteva a punto il piano per il delitto e diceva chiaramente ai suoi complici che a Provenzano era meglio non dire niente. Decise di non attendere la punizione e di suicidarsi in carcere. Ma ciò non venne ritenuto sufficiente. Ha ricevuto la condanna fin nella tomba. All’indomani del funerale il loculo venne interamente distrutto; per ammonire e intimidire i vivi, certamente, ma anche per esprimere un giudizio sulla sorte ultraterrena del traditore. L’ambizione del sodalizio mafioso sembra essere quella di non fermarsi neppure di fronte alla morte, ma anche a questa apporre il proprio sigillo.
Quale altra organizzazione di malviventi si preoccupa del destino trascendente dei propri membri?
È un compito, questo, in genere riservato alle religioni. I terroristi legati al mondo dell’estremismo islamico, che abbiamo imparato a conoscere sotto la sigla di Al Qaeda, la rete criminale di Osama Bin Laden, ci hanno in effetti abituato all’immagine di uomini e donne che commettono azioni orribili, sgozzano, sequestrano, si fanno saltare in aria, massacrano vittime innocenti e sono disposti a farsi uccidere senza dubitare che, in cambio di ciò, riceveranno una ricompensa ultraterrena. Tutto questo ci disgusta ma, in un certo senso, ormai non ci stupisce più. Abbiamo familiarizzato con l’idea. È possibile che i mafiosi pensino ai loro crimini come azioni legittimate da una finalità religiosa?
Per rispondere a questa domanda dovremmo riuscire a pensare come pensa un appartenente a Cosa nostra. E non è facile.
Possiamo aiutarci con il lavoro di storici, psicologi e sociologi, ma ancora più utile potrebbe risultare lo studio di uno specialista molto particolare. Si chiama Sergio De Caprio, meglio conosciuto come “capitano Ultimo”. È l’uomo che ha catturato, dopo ventisei anni, Totò Riina, detto “’u curtu”, uno dei più feroci capimafia mai esistiti. Nel suo libro, un manuale di tecniche investigative destinato alla Scuola di perfezionamento di polizia, il militare espone il problema di come prepararsi a un conflitto asimmetrico, tra lo Stato e un nemico inferiore per forza e quantità, che però trova proprio nella sua presunta debolezza il vantaggio di cui servirsi sul terreno:
Il nemico invisibile, non strutturato, non convenzionale è la minaccia che stabilisce la nuova dottrina di lotta: non più muro contro muro, non più vuoto contro pieno, ma piccolo contro grande, leggero contro pesante, semplice contro complesso, poco contro tutto [...]. È immediata l’intuizione dell’importanza fondamentale che nei conflitti moderni assume la funzione dell’esplorazione nascosta by stealth e la tecnica che la spalma sul terreno. Vince chi ha la superiorità informativa sull’avversario, non chi ha maggiore capacità di fuoco (Ultimo, La lotta anticrimine.
Intelligence e azione, Roma, Laurus Robuffo, 2006, pp. 48, 49).
Se c’è una cosa che la storia della mafia (e dell’antimafia) dovrebbe insegnare, è che Cosa nostra ha saputo costruire una «superiorità informativa sull’avversario», cioè sullo Stato.
Per dirla in altri termini, i mafiosi sanno chi siamo noi ma noi non sappiamo chi sono i mafiosi. Cioè, non sappiamo come pensano, come si muovono, cosa sta loro a cuore. De Caprio spiega che per lottare sul terreno dei mafiosi occorre imparare a «interiorizzare l’avversario per prevederlo».
Un analista del fenomeno criminale – la cui conoscenza non è finalizzata all’azione repressiva – potrebbe parafrasare questa formula così suggestiva: interiorizzare l’avversario per studiarlo.
In qualche misura, dovremmo fare come il protagonista di un celebre film, Donnie Darko. Il personaggio principale è un poliziotto che si infiltra nelle fila della mafia americana. Lo fa così bene che arriva a identificarsi con gli esponenti di quel mondo criminale, fino a creare un sincero legame d’amicizia con il piccolo mafioso che lo ha introdotto nella “famiglia”, impersonato da Robert De Niro. Tutta la sua vita ne esce sconvolta.
In una scena litiga con la moglie, che lo accusa di comportarsi come i criminali che dovrebbe arrestare, di essere come loro. Lui le risponde urlando: «Io sono uno di loro!».
Ovviamente, a nessuna persona normale verrebbe in mente di procurarsi una pistola, trafficare in droga e iniziare a chiedere il pizzo ai negozi sotto casa, per riuscire a carpire qualcuno dei segreti dell’universo mafioso. E infatti non è necessario arrivare a tanto. Secondo il popolare protagonista dei
romanzi di Sir Arthur Conan Doyle, il celebre Sherlock Holmes: «È difficile che una persona usi ogni giorno un oggetto senza lasciarvi impressa qualche traccia della sua personalità, che un osservatore esperto non può non decifrare». La mafia usa fin dalla sua nascita tradizioni e simboli della religione cattolica. Tracce del passaggio dell’organizzazione segreta Cosa nostra si possono rintracciare nelle sagrestie, negli archivi delle confraternite, nei santuari, nel silenzio dei cimiteri, nei chiostri dei conventi, nei percorsi delle processioni.
Un buon punto di partenza sono le “santine”, le immagini religiose, che vengono utilizzate per la “punciuta”, la rituale affiliazione degli adepti:
Sono entrato a far parte della famiglia nel 1974: io e Umina Salvatore. Ci portarono in campagna, da mio padre [...]. Poi hanno preso una candela accesa, hanno disinfettato un ago facendolo bruciare al fuoco e ci hanno punto il dito. Pigghiaru a santa, ci dettiru fuocu e nna’ misiru nna’ manu, poi ci fecero giurare: io giuro di essere fedele alla famiglia, se io dovessi tradire le mie carni saranno bruciate come brucia questa santina. Queste sono le modalità per potere entrare nella famiglia. Poi c’è stata la baciata (trascrizione di un interrogatorio in «Giornale di Sicilia», 16 maggio 1987).
È la descrizione della cerimonia di affiliazione dalla viva voce di un ex mafioso, un certo Vincenzo Marsala, diventato collaboratore di giustizia negli anni Ottanta del secolo scorso.
È un racconto fresco ed essenziale, dove il contaminarsi di dialetto siciliano, italiano scolastico e parlato rende, anche linguisticamente, la mescolanza di arcaico e di moderno di cui è impastata la mafia. Se Cosa nostra è abituata a descrivere se stessa come manifestazione della società tradizionale, indubbiamente in questa elaborazione ideologica ha un ruolo da definire l’adesione dell’uomo d’onore al cattolicesimo:
Per incoronare un capo non si sceglieva mai un giorno a caso. Per esempio a Riesi, tra le miniere di zolfo e il vino nero come inchiostro della contrada Judeca, un boss ha presentato pubblicamente il suo delfino nel giorno più importante di quella comunità: la festa della Madonna della Catena. E così fu anche nel 1963, quando Francesco Di Cristina si affacciò dal balcone della casa più grande e bella di Riesi e baciò suo figlio Giuseppe. Sotto quel balcone dodici uomini portavano a spalla la statua di gesso della Madonna. Non c’è mafia senza chiesa. Non ci sono mafiosi senza fede. In tempi antichi e in tempi moderni. Si possono scannare cristiani come capretti, si possono sciogliere bambini nell’acido, si possono strangolare uomini e poi gettare i loro corpi in fondo al mare e poi… pregare (Attilio Bolzoni, in «la Repubblica», 9 giugno 1997).
Cosa intende l’affiliato a Cosa nostra con religiosità? Che ruolo ha questa religiosità nella cosiddetta cultura mafiosa? È esistita (o esiste) un’ideologia, o meglio, un sistema di valori condiviso, che ha fatto da cerniera tra mafia e parte del clero siciliano?
Possiamo rispondere a queste domande solo se partiamo da un presupposto: per un membro di Cosa nostra la mafia stessa esaurisce la sfera della religiosità. È una delle intuizioni di Giovanni Falcone: «Entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi ad una religione».
Nulla viene prima e nulla viene dopo di essa. Nell’Ottocento lo avevano già capito. Scriveva un delegato di polizia in un suo studio, nel 1886:
Si è parlato lungamente di riti di iniziazione. Si racconta in tono leggendario che dopo il 1866 girava per vari comuni una specie di missionari, i quali andavano facendo proseliti per una causa che, camuffata a religiosa e politica, sotto le finte cioè di far trionfare la religione ed abbattere il governo usurpatore e scomunicato, metteva capo realmente al delitto. Furono da costoro introdotti riti tra il mistico e il settario, che con brevi varianti si resero poi comuni alle varie associazioni di malfattori [...]. I soci avevano segni di riconoscimento e ben presto il tenebroso sodalizio si sparse in vari comuni. Vuolsi che all’atto del giuramento l’iniziato dovesse anche tirare un colpo di pistola ad un crocifisso colà appeso, quasi per dimostrare che dopo aver sparato al Signore non avrebbe esitato ad uccidere qualunque persona, anche a lui cara (Giuseppe Alongi, La maffia, 1886, p. 102).
Sono storie e metodi che riguardano un mondo arcaico e ormai scomparso, sostituito dalle strategie di una moderna holding criminale-finanziaria, che opera in borsa e non si preoccupa più di crocifissi e giuramenti?
Forse. O forse no. L’onorevole Lo Giudice, un deputato regionale siciliano di una certa importanza, recentemente arrestato, intercettato al telefono durante un’indagine, parlava dell’organizzazione mafiosa con un suo amico: «Conosco i parrini, anche se non faccio parte della Chiesa».
I “parrini”, i preti in siciliano, sono i mafiosi; la Chiesa di cui si parla qui è la mafia siciliana, Cosa nostra. Con questa colorita espressione, il politico intendeva sottolineare la sua vicinanza, la sua intimità, con il mondo degli uomini d’onore, nonostante il fatto di non essere formalmente affiliato all’associazione. In maniera non molto diversa, un capomafia si rivolgeva qualche anno fa a un nuovo aderente dicendogli: «Non fai più parte di questo mondo»; per fargli intendere quale vita lo attendeva, quasi assimilandolo a un convertito a una nuova religione, più che a uno spietato sicario. Sappiamo inoltre che per riferirsi alla famiglia mafiosa di San Filippo Neri, un quartiere della periferia nord di Palermo, meglio conosciuto come ZEN, i seguaci della cosca usano un’espressione: la Chiesa.
No, non si tratta di procedimenti superati, come cercheremo di dimostrare. La gran parte della documentazione che useremo è basata sugli scritti degli esponenti ecclesiastici, sulle dichiarazioni di chi ha combattuto la mafia, sulle rivelazioni dei mafiosi divenuti collaboratori di giustizia, sulle comunicazioni e sulle lettere degli uomini d’onore. Una fonte primaria sono le interviste rivolte a religiosi che operano, con la funzione di parroco, in alcuni quartieri palermitani considerati ad alta densità mafiosa: Brancaccio, Ciaculli e Settecannoli.
Un grande reporter, recentemente scomparso, ha scritto: «Esistono tre tipi di fonti, la principale delle quali è la gente. La seconda sono i documenti, i libri e gli articoli. La terza è il mondo che ci circonda e in cui siamo immersi: colori, temperature, atmosfere, climi, i cosiddetti elementi imponderabili e difficili da definire, e che tuttavia costituiscono un elemento importante del nostro lavoro» (Ryszard Kapuscinski, Autoritratto di un reporter, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 64).
È una fonte primaria anche l’esperienza e la testimonianza personale di chi scrive, e che in quel territorio vive e risiede.
Questo non è necessariamente un vantaggio, poiché la vicinanza con l’oggetto del mio studio ha richiesto uno sforzo ulteriore di lucidità durante l’analisi; dall’altro lato vi è il vantaggio di poter osservare, in determinati momenti, quella che è la vita quotidiana di Cosa nostra, sapendo leggere connessioni e significati di un mondo in cui si assiste, senza tregua, all’alternarsi di grigiore borghese e di follia omicida. Le fonti orali che ho utilizzato sono indispensabili quando si indaga su una realtà quale quella mafiosa, connotata da segretezza e da mancanza, il più delle volte, di fonti scritte. Il lavoro
di un ricercatore sulle tracce di Cosa nostra non è talvolta dissimile da quello di un normale investigatore, che deve sapere infiltrarsi, leggere le connessioni, lavorare con frammenti per ricostruire l’insieme completo: «Ricondotti ad un unitario sistema di coerenze interpretative, i vari elementi
“indiziari” acquistano un convincente valore probatorio» (G. C. Marino, L’opposizione mafiosa, 1996).
Nel caso dei rapporti tra chiesa e mafia, non mancano gli indizi per ipotizzare una strategia di Cosa nostra volta a infiltrarsi all’interno del tessuto ecclesiale. Per un mafioso non solo mafia e religione si conciliano perfettamente ma, si può dire, il problema in genere non si pone neppure. Un collaboratore di giustizia, in un’intervista a Rita Mattei, così spiega come poteva conciliare mafia e religione: «Io e mia moglie siamo religiosi. Mi hanno insegnato che la mafia è nata per amministrare la giustizia. Quindi, nessuna contraddizione. Anzi, sa che ora, davanti a Cristo, mi sento un traditore? Quando ero un assassino andavo in chiesa con animo tranquillo. Ora che sono un pentito no, non prego serenamente» (T. Principato – A. Dino, Mafia donna, 1997, p. 131).
E i sacerdoti cosa ne pensano? La Chiesa non è un monolite.
Le sue relazioni con la mafia non possono essere comprese sotto facili slogan. Da un lato vi è il religioso carmelitano Mario Frittitta, che ha ammesso di aver officiato i sacramenti e celebrato messa nel covo del padrino Pietro Aglieri; dall’altro vi è don Puglisi. Tra questi due poli vi è un ampio arco di posizioni che questa ricerca ha cercato di rappresentare, seppure parzialmente, nel modo più fedele possibile. La storia della Chiesa di Palermo è necessariamente diversa dopo l’assassinio di padre Pino Puglisi in una misura che forse ancora non cogliamo pienamente, ma la sua stessa figura per essere compresa appieno, va inquadrata nella storia del cristianesimo del Novecento. E poi vi sono le strategie che la mafia mette in atto nei confronti del clero, per cercare di strumentalizzarlo e indirizzarlo, là dove questo può essere utile ai suoi scopi. Gran parte del libro si preoccupa di indagare intorno ai metodi utilizzati da Cosa nostra per riuscirvi.
Una lettura che non vuole dimenticare un filo rosso di resistenza cattolica alla mafia, lungo tutto il Novecento, che va da don Giorgio Gennaro, ucciso dai Greco di Ciaculli nel 1916, a don Giuseppe Puglisi, e passa attraverso l’esperienza di una rivista come «Segno», nata a Palermo, quella del Centro studi Pedro Arrupe, creato dai gesuiti nel capoluogo siciliano, o di sacerdoti come il salesiano Baldassare Meli e il gesuita padre Antonio Damiani, nei quartieri palermitani dell’Albergheria e del Capo. Ciò che ci interessa non sono tanto le colpe degli uomini o delle istituzioni, ma le conseguenze delle loro decisioni. E precisamente le conseguenze, sul piano religioso ed ecclesiale, di una egemonia mafiosa in Sicilia che si è consolidata nell’arco di almeno due secoli.
Pubblicato in Senza categoria 86 commenti »
lunedì, 1 ottobre 2007
LAVORATORI DI OGGI: “RISORSE UMANE” O “RISERVE UMANE” ?
Il titolo di questo post è provocatorio, lo so. Però è anche vero che la situazione del mercato del lavoro è tutt’altro che rosea. Soprattutto a sentir parlare la gente; e i giovani in particolare (e al di là degli esiti delle statistiche ufficiali sulle percentuali di occupati e disoccupati).
Di libri e romanzi che affrontano il problema in maniera più o meno diretta ce ne sono parecchi.
C’è l’ultimo romanzo di Tullio Avoledo (“Breve storia di lunghi tradimenti”, Einaudi, 2007, euro 16,50), per esempio, di cui parleremo prossimamente in maniera più dettagliata, dove – con un tocco di efficace visionarietà – ci vengono presentate banche ultramoderne, ipertecnologiche e disumane (interessante e indicativo il sottotitolo del libro: un grande romanzo sulla fine del lavoro e dell’amore).
C’è il romanzo/antiromanzo del giovane Gianfranco Franchi (“Pagano“, edizioni Il Foglio, euro 10: ne abbiamo già parlato qui), dove si evidenziano le difficoltà delle nuove generazioni a fare i conti con forme di precariato “senza fine” (le virgolette per indicare il doppio senso).
Poi c’è questo libro di Aldo Nove (che non ho avuto modo di leggere ma che ritengo possa “calzare a pennello”).
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
La letteratura è vita. A essa si rifà, a essa ritorna.
Giorni fa mi ha scritto uno dei frequentatori di Letteratitudine. Si chiama Benedetto (nick name: Outworks 110). Nella lettera denuncia una situazione di disagio che credo sia comune a molti lavoratori dipendenti.
Vi chiedo di leggerla e di commentarla.
E poi vi pongo alcune domande.
La cosiddetta flessibilità del lavoro – almeno, quella che sembrerebbe vada a danno del lavoratore – è davvero un male necessario e inevitabile come qualcuno sostiene?
Avete aneddoti da raccontare (vissuti in prima persona o che hanno coinvolto persone che conoscete direttamente)?
C’è qualche imprenditore o manager che può fornirci il punto di vista dell’altra “campana”? (Auspicherei in particolare – anche per “controbilanciare” il post – gli interventi di manager e dirigenti dell’azienda dove lavora Benedetto).
Ragioniamo e discutiamo con calma.
Segue la lettera di Benedetto.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Buongiorno,
lavoro in un call center della Vodafone, quello di Padova per la precisione, e sono una delle 914 persone coinvolte in quello che viene definito in linguaggio asettico una operazione di esternalizzazione. Ho visto durante questi anni nel nord-est, io originario della Puglia, alcune persone a volte manifestare e parlare in televisione a proposito di questa strana bestia: l`esternalizzazione. Ebbene molto spesso li ho ascoltati distrattamente, altre volte faticavo a comprendere di cosa parlavano. Adesso sono coinvolto in prima persona e capisco tutto alla perfezione. Si tratta, in soldoni, di una grande azienda, che come nel caso della mia con conti in ordine e situazione di mercato stabile, decide per mantenere gli utili azionari ad un livello costante se non crescente, di vendere alcuni segmenti della propria azienda ad altre aziende piu` piccole. Sin qui l`operazione farebbe discutere solo per piccoli problemi morali, come ad esempio quello di vendere persone come sacchi di patate semplicemente per mantenere profitti alti, ma della morale non parliamo. Di questi tempi si fa brutta figura a parlare di cose del genere. Sono altri due gli aspetti di cui mi piacerebbe parlare : la strana contiguità di un’azienda come quella cedente Vodafone, che sin dai tempi in cui si chiamava Omnitel, aveva rapporti di stretta collaborazione con l’azienda che acquista i lavoratori: Comdata. E questa azienda guarda caso dovrà quotarsi in borsa nei prossimi mesi. Inoltre detta azienda possiede nella propria banca dati le informazioni riguardanti tutte le compagnie telefoniche. Si parla di concorrenza fra gestori e legge sulla privacy e poi una sola compagnia, neanche telefonica, possiede 3/4 dei dati di tutte le compagnie telefoniche. Un classico esempio di capitalismo arruffato e pasticcione nel quale noi italiani a quanto pare siamo specialisti. Il secondo aspetto del quale volevo parlare è quello che ovviamente riguarda le persone coinvolte in questo “progetto”. Alla sensazione di sgomento e sconforto iniziale subentrano, poi, in modo del tutto irrazionale e schizofrenico sensazioni contrastanti: disperazione, incertezza, qualche piccola speranza che tutto si risolva, e poi ancora disperazione. Non è la vecchia storia di persone abbarbicate alla famosa poltrona, quelli lì in Italia non riesci mai a schiodarli, quanto invece una sensazione mista di delusione nei confronti di un’azienda che ha fatto della sua immagine giovanile e di successo una delle sue carte vincenti, e l’incertezza quanto non la paura per il futuro. L’azienda che acquista, Comdata, garantisce trattamento e sede per soli due anni. Poi persone di quarant’anni e passa, con famiglia e mutuo, potrebbero sentirsi fare delle richieste oscene come lavorare a cottimo o cambi di sede repentini e ripetuti. Questo in un mercato del lavoro, quello di italiano, asfittico in gratificazioni e generoso solo di angosce e precariato. Certo il problema riguarda me e 913 colleghi della Vodafone, ma non sarebbe il caso, ogni tanto ed anche in uno spazio atipico come questo blog parlarne? Giusto per smitizzare questa immagine ottimistica, asettica ed indolore di operazioni finanziarie che hanno il solo pregio di arricchire poche persone e il torto di gettare nell`angoscia migliaia di lavoratori.
Cordialmente,
Benedetto
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Aggiornamento del 2 ottobre 2007
L’aggiornamento del post è finalizzato alla segnalazione di un ulteriore libro. Un libro che va in una direzione diversa rispetto a quella seguita dai tre che ho citato all’inizio. L’autrice è una giornalista del Messaggero: si chiama Angela Padrone. Il titolo del suo libro non è meno provocatorio del titolo di questo post.
Precari e contenti (Marsilio, 2007). Un titolo che a prima vista parrebbe… ossimorico. Il sottotitolo però è più rassicurante: Storie di giovani che ce l’hanno fatta.
Angela Padrone è ufficialmente invitata a partecipare al dibattito.
Pubblicato in PERPLESSITA', POLEMICHE, PETTEGOLEZZI E BURLE 101 commenti »









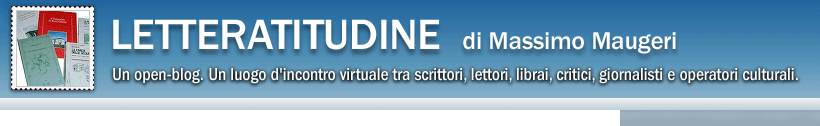















 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI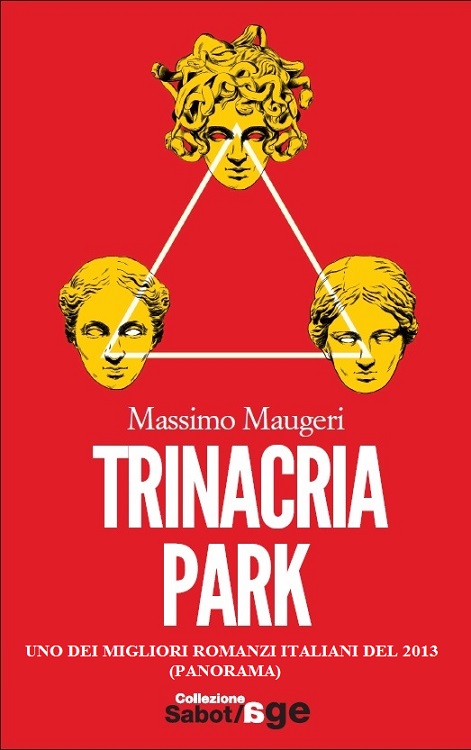
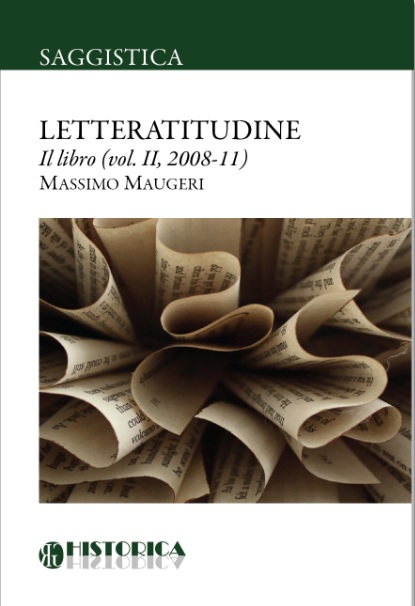


Commenti recenti