Post lungo, ma che vi prego di leggere. Vi consiglio di salvare la pagina, leggere con calma e intervenire successivamente… se ne avrete voglia (N.d.A.)
*
*
Il 10 gennaio del 1987 è una data da ricordare per la carta stampata italiana. Sulle pagine del Corriere della Sera (in terza pagina) apparve un articolo di Leonardo Sciascia dal titolo I professionisti dell’antimafia. Quell’articolo scatenò il putiferio. Spezzò l’Italia in due. Fiumi di parole si riversarono sulle pagine di quotidiani e riviste. E fa impressione constatare che, trascorsi vent’anni, la ferita è rimasta aperta; che la forza prorompente di quel j’accuse ritorna oggi con la stessa intensità di allora, rimbalzando – ancora una volta – da un quotidiano all’altro.
Allora, vent’anni fa, non c’era Internet, non c’erano i portali web, non c’erano i blog. Per fortuna!, potrebbe commentare qualcuno.
Voglio provare a ricostruire la vicenda qui, su questo luogo virtuale, partendo da allora per arrivare ai nostri giorni.

Leonardo Sciascia
Ciò che spinse Sciascia a scrivere quell’articolo (o che comunque gli fornì l’input per affrontare una questione che evidentemente gli stava molto a cuore) fu una nota pubblicata sul "Notiziario straordinario" n. 17 del 10 settembre 1986 del Consiglio superiore della magistratura. In quella nota si commentava l’assegnazione del posto di procuratore della repubblica a Marsala a Paolo Borsellino; assegnazione avvenuta prescindendo dall’ordine di graduatoria dei candidati. Ecco il testo: «Rilevato, per altro, che per quanto concerne i candidati che in ordine di graduatoria precedono il dottor Borsellino, si impongono oggettive valutazioni che conducono a ritenere, sempre in considerazione della specificità del posto da ricoprire e alla conseguente esigenza che il prescelto possegga una specifica e particolarissima competenza professionale nel settore della delinquenza organizzata in generale e di quella di stampo mafioso in particolare, che gli stessi non siano, seppure in misura diversa, in possesso di tali requisiti con la conseguenza che, nonostante la diversa anzianità di carriera, se ne impone il ’superamento’ da parte del più giovane aspirante.»
Quel ‘superamento’ da parte del più giovane aspirante fornì, ripeto, a Sciascia il pretesto per contestare coloro che poi ebbe modo di definire sull’articolo con l’epiteto di professionisti dell’antimafia. Il citato articolo è disponibile on-line e potete leggerlo integralmente cliccando qui.
.
Sciascia comincia il suo articolo autocitandosi due volte. Lo fa riportando stralci di brani estrapolati da Il giorno della civetta e da A ciascuno il suo. E fa precedere le citazioni da questa frase: «Autocitazioni, da servire a coloro che hanno corta memoria o/e lunga malafede e che appartengono prevalentemente a quella specie (molto diffusa in Italia) di persone dedite all’eroismo che non costa nulla e che i milanesi dopo le Cinque giornate, denominarono "eroi della sesta"».
Poi cita un saggio pubblicato dall’editore Rubettino. Il titolo è: La mafia durante il fascismo. L’autore è Christopher Duggan. Sciascia sottolinea che: «l’attenzione dell’autore è rivolta non tanto alla "mafia in sé" quanto a quel che "si pensava la mafia fosse e perché": punto focale, ancor oggi, della questione: per chi si capisce sa vedere, meditare e preoccuparsi; per chi sa andare oltre le apparenze e non si lascia travolgere dalla retorica nazionale che in questo momento del problema della mafia si bea come prima si beava di ignorarlo o, al massimo, di assommarlo al pittoresco, al colore locale, alla particolarità folcloristica.»
Di seguito Sciascia chiama in causa don Luigi Sturzo. Nel 1900 Sturzo scrisse un dramma intitolato: La mafia. Quel dramma, evidenzia Sciascia: «andava a finire male e nel male, coerentemente a quel che don Luigi Sturzo sapeva e vedeva. (…) E come poi dal suo partito popolare sia venuta fuori una democrazia cristiana a dir poco indifferente al problema, non è certo un mistero: ma richiederà, dagli storici, un’indagine e un’analisi di non poca difficoltà.»
Torna sul libro di Duggan e chiama in causa Mori: «(…) non è senza significato che nella lotta condotta da Mori contro la mafia assumessero ruolo determinante i campieri (che Mori andava solennemente decorando al valor civile nei paesi "mafiosi"): che erano, i campieri, le guardie del feudo, prima insostituibili mediatori tra la proprietà fondiaria e la mafia e, al momento della repressione di Mori, insostituibile elemento a consentire l’efficienza e l’efficacia del patto. (…) l’antimafia è stata allora strumento di una fazione, internamente al fascismo, per il raggiungimento di un potere incontrastato e incontrastabile. (…) Morale che possiamo estrarre, per così dire, dalla favola (documentatissima) che Duggan ci racconta. E da tener presente: l’antimafia come strumento di potere. Che può benissimo accadere anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando. E ne abbiamo qualche sintomo, qualche avvisaglia».
A questo punto Sciascia lancia una stilettata all’allora sindaco di Palermo: Leoluca Orlando. E lo fa partendo, appunto, dal concetto di antimafia come strumento di potere. Non cita esplicitamente Orlando, ma il riferimento è chiaro. Inequivocabile. Scrive Sciascia: «Prendiamo, per esempio, un sindaco che per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei come antimafioso: anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra (che sono tanti, in ogni paese, in ogni città: dall’acqua che manca all’immondizia che abbonda), si può considerare come in una botte di ferro. Magari qualcuno, molto timidamente, oserà rimproverargli lo scarso impegno amministrativo: e dal di fuori. Ma dal di dentro, nel consiglio comunale e nel suo partito, chi mai oserà promuovere un voto di sfiducia, un’azione che lo metta in minoranza e ne provochi la sostituzione? Può darsi che, alla fine, qualcuno ci sia: ma correndo il rischio di essere marchiato come mafioso, e con lui tutti quelli che lo seguiranno. Ed è da dire che il senso di questo rischio, di questo pericolo, particolarmente aleggia dentro la democrazia cristiana: et pour cause, come si è tentato prima di spiegare. Questo è un esempio ipotetico».
Di seguito cita la nota del "Notiziario straordinario" n. 17 (10 settembre 1986) del Consiglio superiore della magistratura (di cui abbiamo già inserito il testo) coinvolgendo Paolo Borsellino.
Infine chiude l’articolo con una frase bruciante: «I lettori, comunque, prendano atto che nulla vale più, in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso.»
Si scatena l’inferno.
Come ricorda Attilio Bolzoni in un articolo pubblicato su Repubblica del 28 dicembre 2006 (dal titolo Quel J’accuse di Sciascia): «Fu una guerra di parole. Violentissima. Si riempirono pagine e pagine di giornali, tutti avevano qualcosa da dire. Ministri. Preti. Sindacalisti. Magistrati. (…) Nando Dalla Chiesa, il figlio del generale prefetto ucciso a Palermo nel settembre dell’82, gli chiese sull’Espresso: “Non ti viene mai in mente una bella terza pagina sui magistrati che fanno carriera proprio perché non attaccano la mafia, perché insabbiano? Su Repubblica, Giampaolo Pansa (…) confessò: “Non riconosco il mio Sciascia, il nostro Sciascia. Dov’è lo scrittore civile, l’analista tagliente?” Giorgio Bocca difese il procuratore Borsellino ma avvertì: “Il vero torto di Sciascia è di esporre tesi, di muovere critiche che stanno fuori dagli opposti schieramenti, che non collimano esattamente né con i dogmi dell’Antimafia né con le ipocrisie e le seduzioni della mafia. Seguendo un suo acuto intuito ha spesso indicato ciò che noi non sapevamo o volevamo vedere.»
Molto interessanti, in questo articolo di Bolzoni, le dichiarazioni di Maria Andronico e Agnese Borsellino. Maria Andronico, vedova dello scrittore, ricorda: « (…) Era addolorato, una sofferenza che quella volta non era riuscito a nascondere. “Mio marito parlava poco, lui che non mostrava mai le sue debolezze rimase profondamente colpito, turbato. (…) A un certo punto però si avvicinò a me e alle mie figlie per assicurarci: non perdete tempo a difendere la mia memoria, non perdete tempo perché il tempo mi darà ragione”.»
Il tempo è passato, scrive sull’articolo Attilio Bolzoni chiamando in causa la vedova Borsellino: «“Aveva ragione, Sciascia aveva ragione”, ripete Agnese Borsellino, un’altra vedova di Palermo che allora non riuscì nemmeno lei a nascondere la sua sofferenza. “Anche Paolo era sconvolto, ma lo sapeva bene di non essere lui il bersaglio di quella riflessione provocatoria”.»
Il 31 dicembre 2006, Sandra Amurri, sulle pagine de L’Unità richiama in causa Leoluca Orlando. Bisogna valutare con attenzione le dichiarazioni di Orlando il quale da un lato giustifica Sciascia spiegando (e contestualizzando) i motivi di quella provocazione, dall’altro però ne stigmatizza l’imprudenza, partendo dalla considerazione che tale provocazione si prestava benissimo, così come poi – a suo giudizio – avvenne, a essere strumentalizzata dai veri nemici dell’Antimafia.
Orlando dichiara: « L’indomani, ero in aereo con Giovanni Falcone diretti a Mosca e mi chiese: Che ne pensi dell’articolo di Sciascia? Risposi in siciliano: “Quannu chiovi nesciunu fora i corna ddi babbaluci” (Quando piove escono fuori le corna dalle lumache). La pioggia, infatti, cominciò a far uscire allo scoperto le corna di mille lumache, sino ad allora confuse nell’antimafia di facciata.” (…) Una provocazione che accolsi con un sospiro di sollievo proprio perché rappresentava la fine dell’ipocrisia dell’antimafia intesa come luogo comune. (…) Ma una provocazione che accolsi con la preoccupazione che potesse essere utilizzata strumentalmente dagli “sciasciani di borgata” che avrebbero potuto sfruttare il prestigio dell’intellettuale per blandire le sue parole come clava per colpire chiunque facesse antimafia. (…) Le sue parole divennero uno strumento utilissimo per criticare quelli che la mafia la combattevano. E il suo invito alla riflessione, la sua esortazione a non lasciarsi travolgere dall’ottimismo della volontà, finì per diventare, in fondo, un’arma consegnata nelle mani dei mafiosi e dei loro amici.” (…) “Il 12 novembre dell’89 (morì dopo 8 giorni) andai a trovarlo. (…) Si sedette con le spalle rivolte alla grande finestra a vetri (…) e quasi singhiozzando mi disse: “Sono finito”. Gli risposi: “Professore, esiste la cronaca, ed esiste la storia. Nella cronaca siamo stati separati, ci siamo trovati su posizioni opposte e inconciliabili. Ma lei è nella storia ed io, per questo, le porto il mio affetto e la stima della città”. “Sono finito. Ma anche lei, sindaco, è finito…”. “Professore, stia tranquillo: anche se finirò, apparirà chiaro che sono stato sconfitto”. “È proprio questo che vogliono evitare i suoi nemici. Vogliono che lei finisca senza essere sconfitto. Faranno di tutto affinché lei esca di scena senza che appaia la sua sconfitta”, concluse. Mi stava mettendo in guardia, come, pur se sbagliando nei toni e non valutando le strumentalizzazioni, aveva voluto fare, due anni prima, con quell’articolo illustrandomi il rischio di finire prigioniero delle parate e delle parole. »
Il 2 gennaio 2007 Pierluigi Battista sul Corriere della Sera pubblica un articolo che riaccende gli animi. Lo intitola: Le scuse dovute a Sciascia. L’intento è chiaro. Nell’articolo Battista ri-racconta la “storia” ed arriva alla conclusione che Sciascia meritava e merita delle scuse e che tali scuse sono, appunto, dovute. Scrive: «Vent’anni fa a Leonardo Sciascia fu bruscamente intimato di rinchiudersi “ai margini della società civile”. (…) E diedero a Sciascia anche del “quaquaraquà”, il più spregevole degli individui secondo la gerarchia di valori del don Mariano Arena del Giorno della civetta.»
L’articolo di Battista riaccende gli animi, dicevo. E infatti, il 4 gennaio 2007 Nando Dalla Chiesa interviene con un articolo sull’Unità intitolato: Sciascia, perché non mi pento. Dalla Chiesa cita un episodio che coinvolge Paolo Borsellino e che adduce come motivazione principale del suo non-pentimento. Scrive Dalla Chiesa: «Chiedere scusa a Sciascia per avere criticato il suo celebre articolo contro i professionisti dell’antimafia di vent’anni fa? Recitare il mea culpa come chiede Pierluigi Battista sul “Corriere” dell’altro ieri? In questi casi è sempre bene non rispondere di getto. E rimettere in fila tutti i dati di realtà conosciuti. E poi pensarci. E poi pensarci ancora. Per evitare di reiterare un gioco delle parti. L’ho fatto. E sono giunto alla conclusione che non ci sia da chiedere scusa di nulla. Non per ostinazione. Ma per un ricordo che ho ben vivo nella mente. Incancellabile. (…) Partirò dunque da quella sera del 25 giugno del ’92. Biblioteca comunale di Palermo. Dibattito organizzato dalla rivista “Micromega” sullo stato della lotta alla mafia dopo la strage di Capaci, in cui era stato ucciso Giovanni Falcone. A un certo punto arrivò Paolo Borsellino. (…) Parlò del suo amico ucciso, parlò delle indagini, dei tempi veloci che egli stesso doveva darsi. (…) A un certo punto fece una pausa e disse: “Tutto incominciò con quell’articolo sui professionisti dell’antimafia”. Lo disse con un tono sprezzante e amareggiato, esistono le registrazioni di quella serata. Fu l’ultimo intervento pubblico di Borsellino. Il testamento morale di un giudice che, con un lucido istinto dell’animale braccato, sentiva che avrebbe seguito la stessa sorte dell’amico e che perciò pesò con quella gravità le sue parole. (…) Ripartiamo da lì: “Tutto incominciò con quell’articolo sui professionisti dell’antimafia”. Un articolo spartiacque, dunque. (…) Tanto più se l’attacco veniva da uno scrittore che con i suoi romanzi aveva insegnato a leggere la mafia a un paio di generazioni e che quindi si sarebbe prestato a meraviglia per essere usato contro il nascente movimento antimafia. Il che puntualmente accadde.»
Dice la sua anche Riccardo Chiaberge scrivendo sulla rubrica Contrappunto del Domenicale del Sole-24Ore del 7 gennaio 2007 (Chiaberge è caporedattore del Domenicale) un pezzo dal titolo: Lo “scusismo” piacerebbe a Sciascia?. Chiaberge parla di “scusismo” inteso come moda o propensione a “chiedere scusa” anche laddove non se ne vedono i presupposti e le necessità. Nell’articolo – in relazione allo "scusismo" – cita gli scrittori Morselli, Berto, Cassola, Solzenicyn. «Chiedere scusa a Sciascia? Francamente non ne sentiamo il bisogno. Intanto ogni polemica va contestualizzata, e nell’epoca dell’assalto mafioso allo Stato è comprensibile che non si dosassero troppo le parole. E poi, conoscendo la vena volterriana di Sciascia, siamo certi che avesse messo nel conto le reazioni e pure gli insulti. Anzi, sarebbe rimasto deluso se la sua provocazione fosse caduta nel vuoto.” (…) Se vogliamo chiedere scusa a qualche scrittore, ricordiamo semmai Guido Morselli, boicottato dalle camarille politico-editoriali e morto suicida senza veder pubblicato uno solo dei suoi romanzi, o Giuseppe Berto, trattato come un appestato perché di destra, o il Cassola ribattezzato “Liala” dalle neoavanguardie, o il Solzenicyn dell’Arcipelago Gulag. Ma a forza di scuse e complessi di colpa, si rischia di trasformare questi autori in martiri intoccabili e di spuntare le armi della critica.»
E sempre il 7 gennaio 2007 esce su Repubblica.it un altro articolo di Attilio Bolzoni dal titolo: Sono stato io a chiamare Sciascia un quaquaraquà. Si parla di Francesco Petruzzella: uno dei fondatori del Coordinamento antimafia. Nel 1987 aveva ventiquattro anni, era iscritto a Giurisprudenza e faceva pratica con le parti civili al maxi processo. Petruzzella dichiara: «Sono stato io a scrivere quel comunicato su Sciascia e non lo rinnego, quella vicenda non si può capire se non la trasportiamo nella terribile Palermo di quel tempo. (…) Non mi pento di nulla, certo la mia fu una reazione rabbiosa ma la crescita umana e culturale di un’intera generazione siciliana è stata scandita dai morti, dai funerali, dal terrore. Quando lessi quella mattina del 10 gennaio 1987 l‘articolo di Sciascia, rimasi pietrificato. Perché l’ha fatto?, mi chiesi. Perché Sciascia non si è limitato a descrivere uno scenario ma ha invece indicato due uomini – Orlando il sindaco del grande cambiamento di Palermo e Borsellino un magistrato integerrimo – come esempi dell’antimafia che fa carriera?" (…)La mia famiglia è di Racalmuto, il paese di Sciascia. E io Sciascia l’ho sempre amato, come d’altronde tutti i siciliani. Ma quell’articolo ha rappresentato uno spartiacque nella vicenda palermitana. Mentre noi cercavamo di ribellarci allo strapotere della mafia e andavamo in piazza a gridare ‘Palermo è nostra e non di Cosa Nostra’, gli intellettuali siciliani se ne stavano in silenzio, non si schieravamo, facevano finta di non vedere e di non sentire in una città dove era impossibile non vedere e non sentire. Poi Sciascia addirittura parlò dei rischi dell’antimafia, non dei rischi della mafia. (…) Sì è vero, certuni hanno fatto carriera con l’antimafia. Ma allora – insisto sulla Palermo di allora – di quella riflessione non ne avevamo bisogno. (…) "Dopo vent’anni penso ancora che da Leonardo Sciascia mi sarei aspettato un altro gesto, la sua voce alta si sarebbe dovuta far sentire per aiutare i siciliani onesti a liberarsi dalla mafia. (…) Palermo era avvolta nella paura. E Sciascia, il nostro migliore scrittore, il raffinato intellettuale, se la prendeva proprio con l’antimafia. No, dopo vent’anni non rinnego nulla».
L’ 8 gennaio 2007, dalle pagine de Il Giornale, Lino Jannuzzi lancia degli strali per mezzo di un articolo intitolato: Quando Sciascia mi rivelò i dubbi su Orlando.
Jannuzzi pone una serie di domande provocatorie: «Che cosa è successo in questi venti anni che sono passati da quell’articolo di Sciascia? Che cosa ne è stato, in questi vent’anni, della mafia e dell’antimafia? Chi ha vinto e chi ha perso? E sono state maggiormente rispettate le regole, come invocava Sciascia? Sono state abolite le leggi speciali, è prevalsa la bilancia, il simbolo della giustizia, oppure sono prevalse le manette invocate dai fanatici dell’antimafia? Che cosa avrebbe detto Sciascia della legge sui "pentiti" e della gestione “dinamica” dei pentiti? Che cosa avrebbe detto Sciascia dell’invenzione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa? E dell’articolo 41 bis, l’elogio alla tortura? E del processo a Giulio Andreotti? E del processo al più illustre dei magistrati italiani, Corrado Carnevale? E a decine e decine di uomini politici sulla base delle accuse di assassini liberati in cambio delle carceri e pagati dallo Stato? Ci fu la carneficina della mafia, come ricorda Nando Dalla Chiesa, e durò un paio d’anni, e poi ci fu la carneficina dell’antimafia, che dura da 15 anni e non è finita. Quale ha fatto più danno?». Poi Jannuzzi torna indietro nel tempo e ci racconta la sua versione del già menzionato incontro tra Sciascia e Orlando: «(…) Ero a Palermo, a casa di Sciascia, due anni dopo quell’articolo, una settimana prima che morisse. Sciascia era pallido, magrissimo, sofferente, girava per lo studio in pigiama, non si vestiva più, non usciva nemmeno più per andare a farsi la dialisi. Mi allontanai per qualche ora perché Sciascia doveva ricevere Leoluca Orlando, che insisteva da tempo per parlargli. Quando tornai, lo trovai seduto sulla poltrona, lo sguardo perso nel vuoto. Restò a lungo in silenzio, poi mi disse, prima che glielo chiedessi: “Ha parlato solo lui. Non ho capito perché ha voluto vedermi. Ha parlato contro i magistrati e la Procura di Palermo, forse per scusarsi della polemica di due anni fa. Ha detto che io resterò nella storia e che mi portava la stima della città. Ho capito che sono finito. Siamo finiti…»
Ecco. Ho provato a ricostruire i passaggi salienti di questa vicenda che iniziò vent’anni fa e che, come ho già scritto, ritorna oggi con immutata forza. Lo faccio – da siciliano – per contribuire a lasciar traccia anche qui, negli algidi luoghi del web, nel regno della velocità, della brevità e dei refusi, a beneficio dei navigatori che magari non hanno tempo o voglia di leggere la carta stampata; a beneficio, soprattutto, dei miei giovani conterranei frequentatori della blogosfera, perché sappiano; perché prendano coscienza di un’importante fatto siciliano che di coscienze ne ha scosse e ne continua a scuotere tante; e perché, anche, prendano coscienza della forza della parola scritta. La parola scritta può creare ferite; a volte profonde, insanabili. E a volte è inevitabile che ciò accada. La parola scritta può essere causa di divisioni, così come può essere occasione di “ricucite”. La parola scritta ha un peso che prescinde da quello dell’inchiostro utilizzato per imprimerla sulla pagina o da quello delle dita che picchiano sui caratteri di una tastiera. La parola scritta può essere un’arma che si innesca, e in maniera irrevocabile, nel momento in cui viene letta. E la sua potenza dipende dalla forza di colui che impugna l’arma (o la penna). Ricordiamocelo, amici miei. Ricordiamocelo. Anche quando fissiamo i nostri pensieri nei luoghi promiscui della rete. Non sprechiamo le nostre parole. Dosiamole. Misuriamole con il metro dell’onestà intellettuale. Gestiamole bene. O quantomeno, proviamo a farlo. (Lo dico anche a voi, ma in realtà lo dico a me).
Ciò detto, dichiaro il dibattito aperto. Per chi avrà voglia di cimentarvisi.
-
Massimo Maugeri









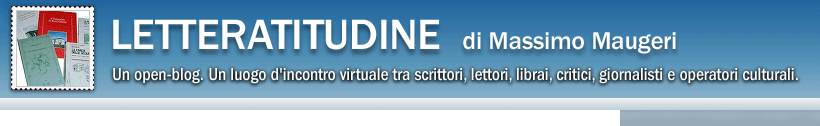























 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI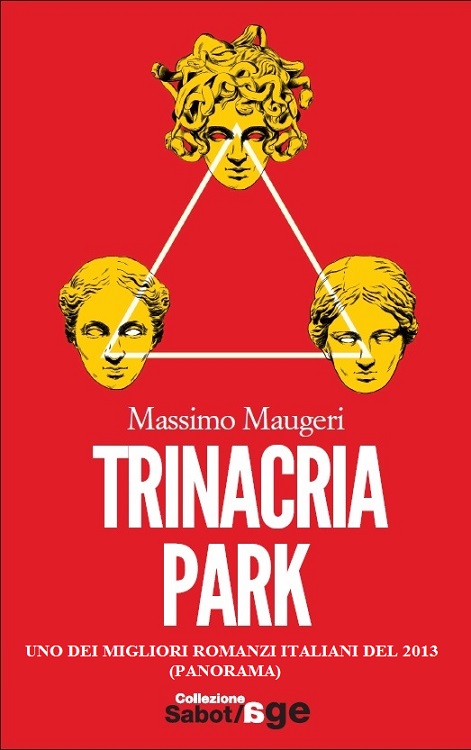
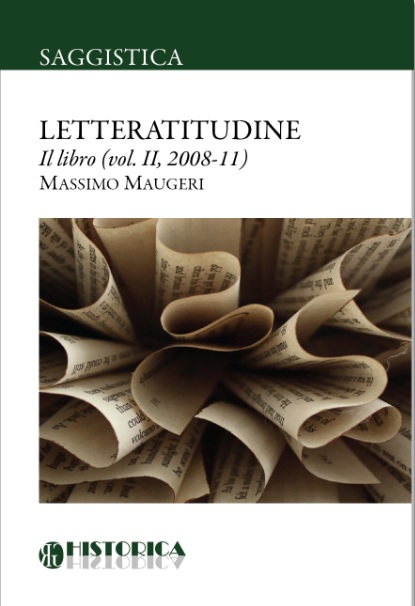


Commenti recenti