martedì, 31 luglio 2007
COLOBRARO, IL PAESE CHE NON SI PUO’ DIRE (di Andrea Di Consoli)
 I paesi della Lucania sono centotrentuno. Di questi, centotrenta sono infelici, mentre il centotrentunesimo è arrabbiato nero. Questo paese si chiama Colobraro. Per una strana assonanza lessicale, il paese sembra chiamarsi così perché somiglia a una “columbària”, cioè a un serpentario. Questo paese sconosciuto è una rocca, una collina rocciosa (da qui i serpenti), un “eden” di ginestre, olivi, boschi e canneti.
I paesi della Lucania sono centotrentuno. Di questi, centotrenta sono infelici, mentre il centotrentunesimo è arrabbiato nero. Questo paese si chiama Colobraro. Per una strana assonanza lessicale, il paese sembra chiamarsi così perché somiglia a una “columbària”, cioè a un serpentario. Questo paese sconosciuto è una rocca, una collina rocciosa (da qui i serpenti), un “eden” di ginestre, olivi, boschi e canneti.
Colobraro è un piccolo paese della provincia di Matera – dal capoluogo dista una novantina di chilometri – e dai suoi pianori si possono ammirare gli ineffabili calanchi del materano, i campi di grano sterminati, i giardini di Tursi (il paese del grande poeta dialettale Albino Pierro), le ricche coltivazioni di Policoro, le luci ammalianti di Valsinni (il paese dove visse e dove tragicamente morì la poetessa Isabella Morra), la diga di Senise, l’immenso lago artificiale che dà da bere alla Puglia, e le mastodontiche tubature dell’Acquedotto Pugliese.
Gli abitanti di Colobraro – il paese più arrabbiato della Lucania – sono appena millecinquecento, ma un tempo i colobraresi furono quasi cinquemila. Dove sono finiti tutti i colobraresi? E perché sono così arrabbiati? Qual è il segreto di Colobraro? Ecco, il segreto di Colobraro è che milioni di superstiziosi-imbecilli, in Italia, quando sentono questo nome – Colobraro, appunto – si toccano le palle e fanno le corna sul ferro. Il paese materano, purtroppo, ha una brutta nomèa, ché viene considerato il paese della iella, delle “masciare”, delle fattucchiere e dei sortilegi d’amore – Colobraro è il paese che non si può dire, in definitiva.
Arrivo a Colobraro nel pomeriggio di un venerdì afoso di luglio. Ho guidato sulla Sinnica con i finestrini aperti, facendomi intorpidire dal calore del sole. Sulla mia destra, per molti chilometri, mi hanno tenuto compagnia le tubature arrugginite dell’Acquedotto Pugliese, mentre in alto, sulla rocca, come uccellacci della modernità sostenibile, ad annunciarmi il paese c’erano alcune pale eoliche ferme nell’immobilità dell’aria. So già, mentre salgo la strada dissestata che porta a Colobraro, che la storia della iella e delle “masciare” è solo una leggenda nera, una leggenda paesana senza nessun fondamento, ma voglio verificare, parlare con la gente, capire la storia di quest’assurda “condanna” secolare.
Parcheggio in piazza e mi guardo intorno. Decido di entrare nella chiesa nuova del paese – quella vecchia fu colpevolmente abbattuta negli anni Sessanta. Tre signore anziane recitano il rosario, ma non sono fattucchiere, sono solo tre signore cattoliche molto devote. Esco, e mi faccio abbagliare dal sole caldo. Una bella ragazza sta seduta, annoiata, davanti a una macelleria, mentre un’altra ragazza, scura di pelle, entra trafelata in un bar, e mostra orgogliosa un bel tatuaggio sulle gambe.
Parlo con un ragazzo seduto ai piedi della statua della Madonna. Fuma e parla poco. Gli chiedo cosa c’è da vedere a Colobraro, ma lui mi dice, con diffidenza: “Niente, non c’è da vedere niente”. Lo saluto e ovviamente non gli credo, ché un paese è sempre pieno di storie nascoste, di cose belle. Mi fermo davanti al tabacchino e parlo con un signore. A bruciapelo gli domando com’è nata questa storia delle “masciare”, ma lui si irrita, è sulle difensive, mi dice che di questo non vuole parlare, che in paese c’è gente disposta a fare a botte, contro i superstiziosi. Gli dico che non sono a Colobraro per inventarmi finte maghe, ma per conoscere la verità, per sfatare una triste nomèa. L’uomo parla – poco, ma parla.
E per la prima volta sento parlare di un famigerato “avvocato”, ma dopo qualche secondo, come ci fosse davvero la provvidenza, una macchina si ferma e un uomo anziano mi fa segno di avvicinarmi. E’ Rocco Mango, il mio salvatore, il mio Virgilio colobrarese. Mi avvicino a lui e subito mi domanda, come fossi il rappresentante del governo di Roma, se “abbiamo” trovato un accordo sulle pensioni. Gli dico che passo le mie giornate a girare paesi e a leggere libri, e che di pensioni non so nulla. Mi parla male dei politici italiani e mi chiede di seguirlo con la macchina – mi porta a due chilometri dal centro, in un posto chiamato Serra, in un “eden” di boschi e di panorami mozzafiato. Subito mi accorgo di aver trovato la persona giusta. Il suo racconto, infatti, coincide tout-court con il racconto di Colobraro: “Ho fatto per quarant’anni il maestro di scuola elementare. Ho settantacinque anni. Di questo paese conosco tutto. Ho fatto finanche le occupazioni delle terre negli anni Cinquanta contro i Berlingieri. La storia della iella? Non c’è niente di vero, credimi. Io mi gioco la casa, mentre tu ti giochi un caffè. Ci stai? Trovami una sola fattucchiera a Colobraro, una sola testimonianza del passato, e io ti regalo la mia casa”.
Sto in ascolto, con le braccia incrociate. Poi gli domando com’è nata, questa “leggenda nera”, perché qualcosa deve pur essere accaduto, negli anni che furono, per consolidare questo luogo comune. Rocco Mango spalanca gli occhi e si accalora: “Sai com’è nata questa stupida leggenda? E’ nata dal fatto che nei primi anni del Novecento, a Colobraro c’era un grande avvocato, Biagio Virgilio, che era il miglior avvocato del materano. Vinceva tutte le cause, aveva una testa grossa così. Ovviamente era invidiato, soprattutto a Matera. Un giorno, mentre discuteva animatamente con alcuni suoi colleghi, che evidentemente non sopportavano la sua bravura, cadde a terra un grosso lampadario. Tutti pensarono: ‘Ecco, questo porta iella, adesso abbiamo capito perché vince tutte le cause’. E la nomèa dilagò a Matera in un batter d’occhio. Biagio Virgilio, il grande avvocato, divenne ingiustamente l’Innominabile. Poi, con gli anni a venire, ogni volta che uno passava davanti a Colobraro, subito pensava: ‘Questo è il paese dell’Innominabile’. Il passo fu breve. Nel volgere di pochi anni l’intera Colobraro divenne innominabile, e così si diffuse la leggenda del paese della iella. Ma qui di fattucchiere non ce ne sono mai state, né ieri né mai”.
Diventiamo amici, io e Rocco Mango. Il sole arancione – e ancora caldo – si spegne superbamente all’orizzonte. Entra nella mia macchina e mi guida per il paese – mi porta nel ristorante di Raffaele, un suo ex alunno, e mi mostra il convento del XII secolo. Il suo racconto non ha sosta: “Il nostro paese è stato rovinato da questa leggenda. I ragazzi emigrano da sempre. Molti si vergognano di dire che sono di Colobraro. Io invece ne approfitto. Sai che faccio? Se vado a Matera in qualche ufficio, basta che vedo una lentezza burocratica o un’ingiustizia, e subito dico ad alta voce: ‘Devo rientrare a Colobraro, è tardi!’ Non appena dico così, tutti mi trattano bene, come un Re. Sono imbecilli, e io approfitto della loro imbecillità. Una volta la polizia mi fermò verso Altamura. Avevo fatto un sorpasso azzardato. Il poliziotto mi chiese patente e libretto, ma quando lesse che ero di Colobraro mi fece andare e mi chiese scusa. Sono imbecilli, e io me ne approfitto. Che altro devo fare?”
Rocco ride, ma un violento colpo di tosse spezza la sua ilarità. Sta male, Rocco, e io me ne accorgo. Mi guarda con i suoi grandi occhi verdi e mi confessa il male oscuro che lo sta consumando: “Non ho mai fumato una sigaretta, eppure ho un tumore al polmone. Faccio la chemioterapia a Policoro. Ho avuto anche un tumore al colon, che mi hanno guarito a Bari. Ma sono ancora vivo. Anzi, il male è come se non mi appartenesse. Ci rido sopra. Non ho paura di morire. Tanto è un ciclo. Tutti dobbiamo morire prima o poi, ma se ti deprimi è finita”.
Rocco mi parla dei tempi andati: dei contadini di Colobraro (del loro fiero individualismo, della loro mitezza, così diversa dall’aggressività e dall’intraprendenza dei tursitani), di quando in paese si coltivava il cotone, di quando Emilio Colombo (mammasantissima della Democrazia Cristiana lucana e italiana, presidente del consiglio nei primi anni Settanta) venne a Colobraro e, poco prima del paese, ridendoci sopra (e ignorando il luogo comune delle gomme che si forano in paese) bucò una ruota della sua macchina. Rocco mi dice: “Sai perché a Colobraro si foravano le gomme? Perché le strade sterrate erano disseminate di chiodi dei ferri di cavallo. Anche questo, però, contribuì a rafforzare la leggenda nera”. E poi mi confessa il suo sogno segreto di una Repubblica Indipendente della Lucania: “Se mettessimo il ferro spinato intorno alla nostra terra, noi saremmo ricchissimi. Abbiamo grano, abbiamo acqua, abbiamo petrolio. Siamo una terra ricca e invece anneghiamo nella miseria e affondiamo nell’emigrazione”.
In paese ci affacciamo da un piccolo pianoro. C’è Valsinni davanti a noi, illuminata come un pugno di gioielli. Rocco sorride: “Adesso te lo posso dire. A Valsinni un fattucchiere effettivamente c’era. Si chiamava Zi’ Giuseppe, abitava verso il monte Coppola. Ma non capiva un fico secco. Quando avevo vent’anni io stavo male, ero debole, non mangiavo. Mia madre gli portò la mia maglia. Lui la annusò e disse che ero sotto gli effetti di un sortilegio d’amore. Invece avevo una malattia vera. Altro che sortilegio!”, e ride di nuovo, stanco di aver parlato così a lungo, di avermi fatto conoscere i suoi amici (il mite preside in pensione, il finanziere con le guance rosse di mille venuzze), di avermi portato a casa dei suoi parenti (una sua zia mi regala, per il viaggio di ritorno, due buonissime focaccine ripiene di zucchine e di verdure), di avermi messo a parte, in così poco tempo, di tutta la sua vita.
E’ quasi buio. L’aria si rinfresca. La zia di Rocco mi mostra, prima di partire, la foto del marito morto – faceva il collocatore privato, dava i nullaosta ai colobraresi che partivano per la Germania, la Francia, la Svizzera. Rocco vorrebbe tenermi lì ancora a lungo, ma è tardi. Il paese mi sembra fraterno, di una fraternità assoluta. “Qui non c’è mai stato un solo omicidio” fa in tempo a dirmi Rocco Mango, maestro di scuola elementare, fiero cittadino di Colobraro, “e quando morirò, sulla mia lapide scriveteci questo: ‘Amò profondamente il suo paese’. Non scriveteci altro”.
No, non ci sono fattucchiere e “masciare”, a Colobraro. Ci sono solo uomini che hanno voglia di raccontarti i loro pensieri, indicando l’orizzonte di una dolcissima Lucania. E a Colobraro bisogna venirci perché è bellissima, e perché il paese più offeso e arrabbiato della Lucania attende da decenni un gesto riparatore dall’Italia dei superstiziosi e degli imbecilli. Ma sono sicuro che Rocco non morirà prima di questo gesto riparatore, ché lui farà in tempo a vedere il suo piccolo paese affollato di turisti, di colobraresi offesi che ritornano, di politici che finalmente si decideranno a dare il secondo medico, visto che in paese ce n’è solo uno e deve farsi carico di troppe persone. Sono sicuro che Rocco Mango farà in tempo a vedere la grande festa di Colobraro, il paese che, nel 2007, assurdamente, ancora non si può dire.
Andrea Di Consoli
Andrea Di Consoli è nato a Zurigo nel 1976 da genitori lucani. Attualmente vive a Roma, dove lavora ai programmi radiotelevisivi della Rai. Collabora inoltre a «l’Unità», a «La Sicilia» e a varie riviste, inoltre scrive sul «Messaggero» e «Nuovi Argomenti». Ha pubblicato il saggio Le due Napoli di Domenico Rea (Unicopli 2002), la raccolta di poesie Discoteca (Palomar 2003) e i racconti di Lago negro (L’ancora del Mediterraneo 2005). Il romanzo Il padre degli animali (2007) ha vinto il premio Mondello ed è finalista al premio Viareggio-Repàci.
Pubblicato in LETTERATURA DEI LUOGHI 62 commenti »









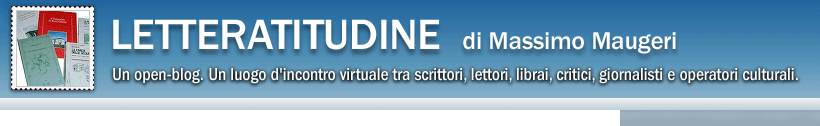

 Nei primi anni Settanta il cinema italiano presenta un numero indescrivibile di attrici che interpretano la nascente commedia sexy. Gloria Guida, Lilli Carati, Femi Benussi, Anna Maria Rizzoli, Carmen Villani, Nadia Cassini, Edwige Fenech, Orchidea De Sanctis, Barbara Bouchet, Laura Antonelli… l’elenco sarebbe interminabile. Mai periodo storico del cinema italiano è stato più affollato di starlette e di attrici affascinanti. La commedia sexy, o commedia erotica, deriva dalla commedia all’italiana e si afferma con l’esaurimento del sottogenere decamerotico. Nel decamerotico abbiamo un modello colto pasoliniano (Il Decameron, Il fiore delle mille e una notte e I racconti di Canterbury) che viene estremizzato da un punto di vista erotico e farsesco. Le tematiche ricorrenti sono quelle dei mariti cornuti, delle mogli traditrici e dei frati impenitenti che a tutto pensano fuorché a pregare. L’erotismo comincia ad andare di pari passo con la comicità e i registi di quelle pellicole raccontano storie divertenti ma piuttosto sboccate. Il sottogenere sfrutta ogni possibile variazione sul tema e si esaurisce nel breve volgere di un paio di stagioni. La commedia sexy unisce l’esperienza della commedia all’italiana con l’eredità del decamerotico e si propone di raccontare storie divertenti e piccanti ambientate in età contemporanea. Sono film che narrano storie familiari a base di tradimenti, equivoci a non finire, scambi di stanze e di coppie, travestitismi e situazioni comiche da avanspettacolo. A tutto questo va aggiunto, come ingrediente fondamentale, un pizzico di erotismo, perché la commedia sexy è soprattutto voyeuristica e basata sul gioco malizioso del si vede – non si vede. Non possono mancare le scene con la bella protagonista seminuda sotto la doccia e l’attore guardone che spia dal buco della serratura. Il regista ricerca l’immedesimazione tra interprete e pubblico, perché chi è seduto in platea osserva la scena con la soggettiva dell’attore che spia dal buco della chiave. Alla base della commedia sexy c’è sempre una comicità di grana grossa, facile, priva di implicazioni politiche e intellettuali. Le trovate da avanspettacolo di ottimi attori come Banfi, Montagnani, Vitali, Buzzanca, Salce, D’Angelo (e molti altri) sono il leitmotiv che accompagna le grazie più o meno esposte delle belle attrici. La commedia sexy lascia grande spazio all’immaginazione, non esibisce ma fa intuire ed è sempre più comica che erotica. In certi casi realizza uno spaccato veritiero della provincia italiana, soprattutto meridionale, e descrive vizi e turbamenti di un’Italia che cambia. Le piazze accolgono gruppi di femministe che contestano e vestono abiti per niente femminili. Al cinema (per contrasto) incontriamo le donne sensuali, il modello di riferimento che gli uomini cercano. È bene dire, però, che in questi film la donna esce sempre vincitrice mentre l’uomo non fa mai una bella figura. Basti pensare alla macchietta del dentista – latin lover interpretata da Lino Banfi ne L’infermiera di notte. La donna è maliziosa, intrigante, spesso è solo una finta oca, ma in ogni caso è il motore che fa girare il film e riveste un ruolo vincente. La commedia sexy rappresenta una variante della commedia all’italiana condita da situazioni equivoche e piccanti ai limiti del paradossale. Non è esagerato dire che simboleggia la voglia di liberazione sessuale di quel periodo storico e che molti film sono capaci di fotografare bene la realtà e di mettere alla berlina un’Italia moralista e bacchettona. Quei film ingenui e a volte un po’ raffazzonati non sono certo roventi storie di sesso, ma raccontano le emozioni e i turbamenti di tanti ragazzini che scoprono il sesso e sognano di diventare adulti. Non trascuriamo il lavoro dei registi della commedia sexy, perché si tratta di validi artigiani che danno vita a personaggi e macchiette indimenticabili. Citerei su tutti Sergio Martino, Mariano Laurenti, Michele Massimo Tarantini, Nando Cicero, e Bruno Corbucci, ma episodicamente incontriamo registi che provengono dal cinema fantastico come Lucio Fulci (La pretora con Edwige Fenech), Umberto Lenzi (Scusi lei è normale? con Annamaria Rizzoli) e Luigi Cozzi (La portiera di notte con Anne Miracle). Da non dimenticare che spesso hanno fatto ricorso a motivi e interpreti della commedia sexy anche registi del cinema alto, della commedia pura, come Ugo Tognazzi, Steno (si veda l’ottimo Fico d’India con Gloria Guida e Renato Pozzetto) e Alberto Sordi. Non dimentichiamo neppure sceneggiatori generosi e prolifici come Francesco Milizia (ferroviere prestato al cinema), Raimondo Vianello e Sandro Continenza. La commedia sexy porta sul grande schermo anche il sottogenere delle professioni con una sfilata di dottoresse, insegnanti, infermiere (la prima è Ursula Andress nell’ottimo L’infermiera di Nello Rossati), soldatesse, tassiste e poliziotte. Nei ruoli professionali primeggia Edwige Fenech, mentre Gloria Guida è perfetta nelle caratterizzazioni da Lolita nabokoviana. Il sottogenere professionale, nella sua variante scolastica, vede
Nei primi anni Settanta il cinema italiano presenta un numero indescrivibile di attrici che interpretano la nascente commedia sexy. Gloria Guida, Lilli Carati, Femi Benussi, Anna Maria Rizzoli, Carmen Villani, Nadia Cassini, Edwige Fenech, Orchidea De Sanctis, Barbara Bouchet, Laura Antonelli… l’elenco sarebbe interminabile. Mai periodo storico del cinema italiano è stato più affollato di starlette e di attrici affascinanti. La commedia sexy, o commedia erotica, deriva dalla commedia all’italiana e si afferma con l’esaurimento del sottogenere decamerotico. Nel decamerotico abbiamo un modello colto pasoliniano (Il Decameron, Il fiore delle mille e una notte e I racconti di Canterbury) che viene estremizzato da un punto di vista erotico e farsesco. Le tematiche ricorrenti sono quelle dei mariti cornuti, delle mogli traditrici e dei frati impenitenti che a tutto pensano fuorché a pregare. L’erotismo comincia ad andare di pari passo con la comicità e i registi di quelle pellicole raccontano storie divertenti ma piuttosto sboccate. Il sottogenere sfrutta ogni possibile variazione sul tema e si esaurisce nel breve volgere di un paio di stagioni. La commedia sexy unisce l’esperienza della commedia all’italiana con l’eredità del decamerotico e si propone di raccontare storie divertenti e piccanti ambientate in età contemporanea. Sono film che narrano storie familiari a base di tradimenti, equivoci a non finire, scambi di stanze e di coppie, travestitismi e situazioni comiche da avanspettacolo. A tutto questo va aggiunto, come ingrediente fondamentale, un pizzico di erotismo, perché la commedia sexy è soprattutto voyeuristica e basata sul gioco malizioso del si vede – non si vede. Non possono mancare le scene con la bella protagonista seminuda sotto la doccia e l’attore guardone che spia dal buco della serratura. Il regista ricerca l’immedesimazione tra interprete e pubblico, perché chi è seduto in platea osserva la scena con la soggettiva dell’attore che spia dal buco della chiave. Alla base della commedia sexy c’è sempre una comicità di grana grossa, facile, priva di implicazioni politiche e intellettuali. Le trovate da avanspettacolo di ottimi attori come Banfi, Montagnani, Vitali, Buzzanca, Salce, D’Angelo (e molti altri) sono il leitmotiv che accompagna le grazie più o meno esposte delle belle attrici. La commedia sexy lascia grande spazio all’immaginazione, non esibisce ma fa intuire ed è sempre più comica che erotica. In certi casi realizza uno spaccato veritiero della provincia italiana, soprattutto meridionale, e descrive vizi e turbamenti di un’Italia che cambia. Le piazze accolgono gruppi di femministe che contestano e vestono abiti per niente femminili. Al cinema (per contrasto) incontriamo le donne sensuali, il modello di riferimento che gli uomini cercano. È bene dire, però, che in questi film la donna esce sempre vincitrice mentre l’uomo non fa mai una bella figura. Basti pensare alla macchietta del dentista – latin lover interpretata da Lino Banfi ne L’infermiera di notte. La donna è maliziosa, intrigante, spesso è solo una finta oca, ma in ogni caso è il motore che fa girare il film e riveste un ruolo vincente. La commedia sexy rappresenta una variante della commedia all’italiana condita da situazioni equivoche e piccanti ai limiti del paradossale. Non è esagerato dire che simboleggia la voglia di liberazione sessuale di quel periodo storico e che molti film sono capaci di fotografare bene la realtà e di mettere alla berlina un’Italia moralista e bacchettona. Quei film ingenui e a volte un po’ raffazzonati non sono certo roventi storie di sesso, ma raccontano le emozioni e i turbamenti di tanti ragazzini che scoprono il sesso e sognano di diventare adulti. Non trascuriamo il lavoro dei registi della commedia sexy, perché si tratta di validi artigiani che danno vita a personaggi e macchiette indimenticabili. Citerei su tutti Sergio Martino, Mariano Laurenti, Michele Massimo Tarantini, Nando Cicero, e Bruno Corbucci, ma episodicamente incontriamo registi che provengono dal cinema fantastico come Lucio Fulci (La pretora con Edwige Fenech), Umberto Lenzi (Scusi lei è normale? con Annamaria Rizzoli) e Luigi Cozzi (La portiera di notte con Anne Miracle). Da non dimenticare che spesso hanno fatto ricorso a motivi e interpreti della commedia sexy anche registi del cinema alto, della commedia pura, come Ugo Tognazzi, Steno (si veda l’ottimo Fico d’India con Gloria Guida e Renato Pozzetto) e Alberto Sordi. Non dimentichiamo neppure sceneggiatori generosi e prolifici come Francesco Milizia (ferroviere prestato al cinema), Raimondo Vianello e Sandro Continenza. La commedia sexy porta sul grande schermo anche il sottogenere delle professioni con una sfilata di dottoresse, insegnanti, infermiere (la prima è Ursula Andress nell’ottimo L’infermiera di Nello Rossati), soldatesse, tassiste e poliziotte. Nei ruoli professionali primeggia Edwige Fenech, mentre Gloria Guida è perfetta nelle caratterizzazioni da Lolita nabokoviana. Il sottogenere professionale, nella sua variante scolastica, vede























 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI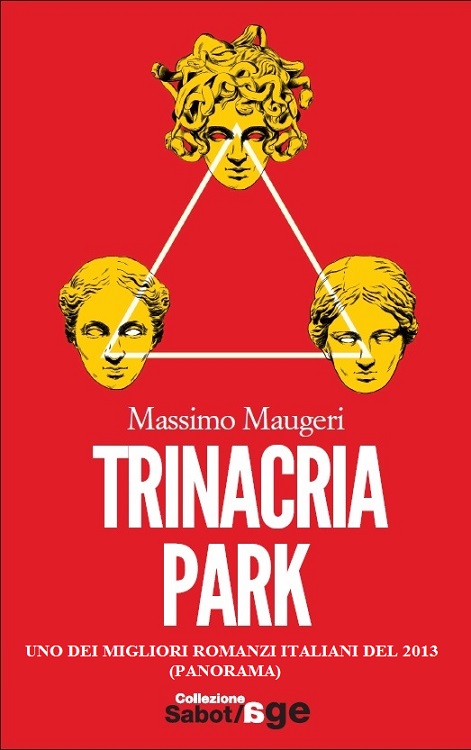
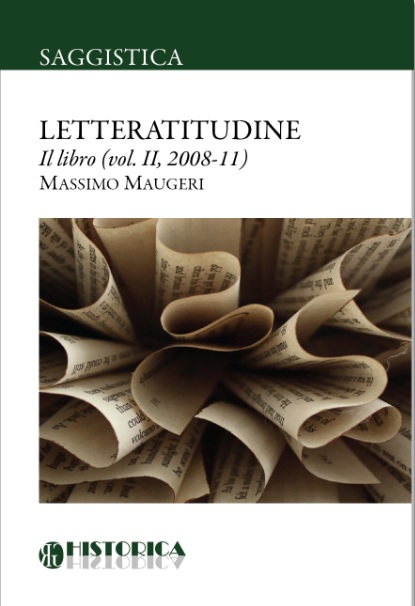


Commenti recenti