mercoledì, 4 luglio 2007
DALLA PARTE DEL TORTO di Elisabetta Bucciarelli
Capita che, aprendo le pagine di un libro, il suo inizio riesca – per un motivo o per l’altro – a catturarti, ad affascinarti. Oppure capita l’esatto contrario. Leggi le prime righe, sbuffi, chiudi il volume e lo seppellisci in uno scaffale secondario della tua libreria..
Per quanto mi riguarda il più recente romanzo di Elisabetta Bucciarelli – autrice di cinema, teatro e televisione – rientra nella prima categoria. Dopo un prologo mozzafiato, ci si imbatte infatti in un incipit/citazione che strizza l’occhio a uno dei più grandi romanzi della storia della letteratura mondiale: “Tutti i cieli azzurri sono uguali. Ogni cielo grigio è grigio a modo suo”. Il lettore attento non avrà difficoltà a riconoscere la trasposizione dell’incipit dell’Anna Karenina del grande Tolstoj: “Tutte le famiglie felici sono simili fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”.
Un incipit del genere depone senz’altro a favore dell’autrice e di questo suo nuovo romanzo: Dalla parte del torto (Mursia, 2007), volume corposo dalla copertina gialla che incornicia la foto in bianco e noir di un acquitrino che non lascia presagire nulla di buono.
Protagonista del libro è l’ispettore di polizia Maria Dolores Vergani, personaggio letterario che aveva già visto la luce nel primo romanzo della Bucciarelli: Happy Hour (Mursia, 2005), ambientato in una Milano moderna, abbiente e all’avanguardia per mode e tendenze. In quell’occasione avevamo avuto modo di ammirare l’intrepida Vergani alle prese con un serial killer particolare che prediligeva mietere vittime tra i frequentatori di bar alla moda e, appunto, happy hour.
Da poche settimane l’ispettore Vergani – quarant’anni, ex psicologa, vita sentimentale irrisolta – è stata dunque ri-catapultata in libreria a far compagnia all’ultimo Montalbano. Anche stavolta la morte bussa alle porte della Milano bene: quella dell’arte e della cultura, della elite e della fashion.
Il cadavere di una giovane donna, bella ed elegante, viene trovato all’interno del milanesissimo parco Forlanini. È solo il primo di una serie di delitti efferati consumati all’interno di parchi cittadini. La Vergani indagherà a modo suo avvalendosi del supporto di una delle più originali squadre investigative dove operano un pittore, un musicista, una copy writer e un fotografo di moda. L’indagine la porterà nel mondo oscuro delle pratiche sessuali estreme, intriso di sadismo, masochismo, feticismo. Un mondo oscuro che coincide, in parte, con l’alta società di una Milano insospettabile.
Con questo romanzo la Bucciarelli punta il dito contro gli aspetti vacui e superficiali di una società che tende all’estetica e alle mode effimere. Una società dove tutto è bello, ma nessuno è buono; o meglio, dove la differenza tra buoni e cattivi è più sottile della lama di un coltello. Per cui, come si legge a chiare lettere da questa sorta di slogan stampato in quarta di copertina, “nessuno può chiamarsi fuori, dal momento che tutti, prima o poi, si sono trovati, almeno per una volta, dalla parte del torto”.
Un’ulteriore nota. In questo libro il lettore avrà modo di apprezzare una scrittura ricca di commistioni e citazioni (commistioni linguistiche con prevalenza di inglesismi e citazioni di ogni tipo che toccano il mondo della letteratura, della musica, dell’arte) e tratti umoristici che risaltano da originali e riuscite didascalie comico/teatrali a supporto dei dialoghi.
In definitiva, davvero convincente la seconda prova narrativa di questa regina del noir milanese.
Massimo Maugeri
.
DALLA PARTE DEL TORTO di Elisabetta Bucciarelli
Mursia, 2007
pag. 408, euro 17
.
Elisabetta Bucciarelli vive e lavora a Milano. È autrice di cinema, teatro e televisione. Ha pubblicato i saggi: Strategie di comunicazione, Io sono quello che scrivo e Le professioni della scrittura. Ha scritto racconti e sceneggiature tra cui Amati Matti, menzione speciale della giuria alla 53a Mostra del Cinema di Venezia. Con Mursia ha pubblicato il romanzo Happy Hour.
.
.
Ringrazio la Mursia per avermi concesso la pubblicazione delle prime pagine del romanzo (le potete leggere di seguito).
.
.
La volante della polizia sta facendo il suo lento giro tra le anse del parco. Fioche luci lunari illuminano l’erba. Una sagoma si muove rasente il fiume che brulica di topi di fogna. Sobbalza. Due di loro sono impiccati al filo spinato che cinge l’argine. Le fauci aperte, le code lunghe, sottili, dritte. I colli strozzati da una corda da pacco, i corpi non ancora in putrefazione. Una siringa conficcata nella schiena di uno. Cattiveria o follia, identificazione o sfregio, ecocidio del putrido. Plastiche palle, gioco di cani, mordicchiate e bavose si accumulano sul finale del dosso, che nasconde un altro epilogo. Tragico, smarrito, lo sguardo di una donna con il capo riverso accoglie l’ultima speranza di sopravvivere. Poi una lama affilata affonda in pieno petto e rimane lì qualche istante, un rantolo e di nuovo un colpo. Lo squittire di una pantegana disturba l’azione e l’ombra si sposta rasente i cespugli e cammina fino a raggiungere la prossimità di un altro specchio d’acqua. La donna, occhi a fessura, mugugna, è un lamento sottile, stride, come gesso sulla lavagna. La lama affonda ancora una volta, è letale. Poi più niente. Un freddo spostamento d’aria senza suono fa pensare a un’altra presenza, la sagoma si gira ma non c’è nessuno. Spinge nell’acqua il corpo, lo guarda andare via. Scivola lentamente, non c’è corrente e lentamente affonda, poco sotto. L’uomo getta la borsa, e se ne va.
I
Tutti i cieli azzurri sono uguali. Ogni cielo grigio è grigio a suo modo.
Milano è di piombo. D’inverno non si distingue l’orizzonte dallo skyline. Canna di fucile che entra nell’antracite, vira al cemento-grattacielo e all’argento del ferro, per finire nel madreperlaceo delle pozze d’acqua. Grigio opaco di sera. Periferici, rarefatti, scialli di nebbia a soffundere i profili delle cose, delle case e delle ultime cascine sparse, ammorbidiscono angoli e smussano certezze. Rumori e tremori, malcelati o addirittura nascosti per chi si ostina a strizzare gli occhi, raggiungono un crescendo diurno. Scompaiono ai vespri. Grigio brillante di primavera. Ciuffi bizzarri d’erba invadono parassitati cementi muschiati, prosciugati dal sole. C’è anche qui, rimbalza contro le superfici lisce delle macchine, i parabrezza con i cartoni kitch copri-cruscotto, le pance metallizzate delle moto e finisce per illuminare gli specchi delle finestre antiriflesso, baluginanti occhi da lupo. Trasforma in scaglie ittiche le prospettive, lamelle dorate destinate a friggere in un liquido grigio d’estate, torrida di sandali che affondano nel cemento sciolto dei marciapiedi. A Milano insiste testarda un’apparente via di mezzo, un’ampia, empia aurea mediocritas, senza troppi schieramenti, né schiarite.
II
Al Forlanini sopravvivono patetiche speranze ecologiche. Si può ancora parcheggiare ovunque, mangiare tramezzini originali e hot dog, andare a respirare cloro in piscina, giocare con barchette e motoscafi telecomandati sul laghetto. Carpe rosse grandi come tonni e tartarughe ninja cresciute dopo un abbandono precoce.
Frastagliato, limpido di acqua sorgiva d’estate, rallegrato dai suoni dei bambini nei pomeriggi dopo la scuola, dai latrati dei cani del vicino rifugio. La grande pozza esce dall’inverno sporca e melmosa. Si sarebbe offesa sentendosi appellare pozza, meglio lago, secondo solo all’Idroscalo, mare di Milano bizzarro di piccole onde, di sci nautico, di costumi da bagno. Calmo invece, quello del Forlanini, ma di una tranquillità solo apparente.
Una riva è saturata da un centinaio di persone. Le gare sono già iniziate, si sente lo zanzarare dei telecomandi nell’aria. È sabato, uno dei primi weekend di primavera. Si fatica a distinguere a chi appartengano i bolidi che sfrecciano, perfette riproduzioni in scala di lussuosi originali, vele che strambano e orzano, scafi che schizzano sul pelo dell’acqua. Per scoprirlo basta mettersi in attenta osservazione e seguire le impercettibili espressioni del viso dei ragazzini, concentrati sulle manovre come davanti a un videogioco. In qualche minuto quindici piccoli natanti raggiungono una linea di partenza immaginaria. Sembrano pronti per la sfida. Fanno rombare in folle le loro creature meccaniche. C’è odore di benzina nell’aria. Partono. È in testa un motoscafo rosso. Lo guida un bambino di sette anni con un giubbotto di pelle marrone da aviatore, più grande di almeno due taglie. La frangia bionda gli cade sugli occhi scuri e con uno scatto del collo la sposta a sinistra per quel secondo esatto che serve a guardare davanti senza interferenze. Di fianco a lui un altro, più o meno della stessa età e altezza, riccio e scuro: «Stavolta ti batto Matteo!» e spinge il suo fuoribordo blu più veloce che può.
«E provaci!», risponde Matteo, ma una curva eseguita con audacia provoca un brusco movimento del braccio destro, che lo sbilancia fino a farlo quasi cadere addosso all’amico che reagisce: «Ehi, ma non stai neanche in piedi, cos’hai mangiato oggi?».
Ridono. Ancora la lunga frangia di Matteo sugli occhi e questa volta la sua piccola mano si stacca istintivamente dai comandi per bloccare il ciuffo dietro all’orecchio sinistro. Basta poco per perdere concentrazione e controllo. Il motoscafo rosso cambia direzione, poi si ribalta e imbarca acqua. Da dietro arriva una vela e poi a seguire un galeone d’epoca. Fino al motoscafo blu dell’amico, che accelera e recupera, riprende il gruppo da destra, passa tutti e cerca di portarsi in prima posizione. Il ragazzino esulta di gioia e chiama Matteo, esortandolo a rimettersi in gara, ma l’imbarcazione non si riprende. Il pilota scoraggiato accenna una lacrima di sconforto, la scaccia immediatamente tirando su con il naso, poi si guarda intorno come per cercare qualcuno. Lo fa con metodo, rimanendo alcuni istanti su ciascun punto dell’orizzonte, abbassandosi come a guardare sotto i cespugli, avanzando di qualche metro per liberare un orizzonte nuovo alla vista. Non trova quello che sta cercando. Raccoglie un legno ma lo getta subito dopo, troppo esile e corto. Ne sceglie un altro, robusto e pesante. Solleva il bastone rimestando sterpaglie e rifiuti che lo tengono ancorato al fango freddo e avvista il suo motoscafo che sta andando alla deriva, dall’altra parte dello specchio d’acqua. Inizia a camminare, con passo deciso, a tratti corre sempre più affannato sforzandosi di mantenere in vista il natante e allo stesso tempo cerca qualcuno che non vede.
Il resto del gruppo ha finito la gara. Vince il motoscafo blu. I ragazzini recuperano lentamente i loro bolidi, qualche adulto li aiuta commentando il risultato. Le piccole imbarcazioni vengono appoggiate sul bordo ad asciugare prima di trovare posto nei bagagliai delle macchine. Adulti e bambini complici, sempre, la mattina di tutti i sabati, tra le dieci e le undici, da tempo immemorabile. Un paio di maschietti parlottano sul ciglio della strada, chiamano rinforzi. Una faccia schifata, un urlo breve.
«È ancora vivo!»
«Ma va, non vedi che è stecchito?», un’altra voce.
Segni. Strazi. Una coda carnosa, lunga e viscida. Una madre va a controllare. Li trascina via. Ma loro vogliono guardare. Cercano nelle piccole menti di rispondere alle domande impossibili. Dagli all’untore. Sono animali schifosi. Una siringa. Saranno tossici. Il ratto se n’è andato in overdose. Crudeltà. Sfregio. Linguaggio da rifiuti. Topi impiccati da qualche squilibrato. Parole chiave: bonificare. Ripulire. Un cellulare chiama l’Amsa.
Gli occhi di Matteo sono sempre concentrati sul suo natante, le piccole mani sul bastone pesante. Si sporge bagnandosi i piedi, cercando di recuperare con la punta del legno la chiglia del motoscafo ma non ci arriva e allora si spinge più avanti, sbilanciandosi pericolosamente verso le acque limacciose. La piccola scarpa da ginnastica si affossa nel fango putrido del bordo e il piede destro finisce ben presto coperto dall’acqua, che arriva velocemente fino quasi al ginocchio. Matteo si accorge ma non molla, manca poco e in quel momento anche la coscia viene raggiunta dal freddo bagnato. Qualche amico lo vede in lontananza e avvisa il gruppo degli adulti, che hanno appena il tempo di realizzare cosa stia succedendo, quando già è tardi per intervenire. È stanco, con una mano sposta ancora i capelli che sono appiccicati dal sudore e dal fango. Dall’altra parte del laghetto nessuno si muove, in piedi, fermi a guardare. Solo una madre si accorge del bambino nell’acqua e inizia una corsa disperata, urlando, scomposta. Ha i tacchi, scivola, cade sul pietrisco, si fa male, piange. Qualcuno la raggiunge, la fa sedere, lei indica, urla, ma non c’è niente da fare.
Il ragazzino procede all’interno della pozza come un rabdomante, deve raggiungere il suo giocattolo. Lo chiamano ma lui non risponde, lentamente persegue il suo intento. Senza indugi sposta un piede dopo l’altro. Ma la melma putrida frana. E lui sprofonda. Beve, inizia a tossire. Un uomo lo individua controsole. Ancora giovane, tuta da jogging elegante e scarpe da corsa ultimo modello, capelli tagliati quasi a zero e grande cronografo al polso. Cuffiette stereo alle orecchie, occhiali con lenti azzurrate per schermare la luce, sconosciuta a Milano da troppi mesi. Toglie gli occhiali. Realizza. Inizia a correre più che può. Si agita, muove le braccia in aria. Sembra di colpo rallentare, poi quasi in apnea riprende, senza ossigeno né autocontrollo. Senza forze. Gli occhi del bambino si riempiono di lacrime. È completamente immerso nell’acqua con il piccolo braccio proteso sempre più avanti finché il bastone raggiunge il motoscafo rovesciato, che si è bloccato in un cespuglio di canne. Lo aggancia con fortuna rabbiosa e lo strattona per disincagliarlo. Insieme al natante, il contraccolpo libera un groviglio di schifezze, un misto di spazzatura e foglie marcescenti. Matteo è nel mezzo, qualcosa lo urta. D’istinto si divincola. Poi guarda. È un corpo. Si rende conto, abbandona il suo gioco e cerca di allontanarsi da quel punto.
L’uomo è già nella pozza, avanza a lunghi passi, spingendo l’acqua pesante con le cosce, alzando i piedi in fretta per impedire al fondo di risucchiarli. La sua grande mano afferra la piccola del bambino, tenendola stretta. Ansimante, con il terrore negli occhi, avvicina le spalle al suo petto.
«Ti tengo io, forza», e aggiunge per scacciare l’angoscia: «Mi vuoi spiegare cosa è successo?».
Bagnato fino alla vita, si siede sul bordo di canne, toglie le cuffiette dalle orecchie e guarda intensamente il ragazzino negli occhi.
«Si è fermato e non ho potuto continuare», fa lui, grondante e infreddolito, ginocchia sbucciate e aggiunge: «C’è qualcosa che galleggia là!», e indica con il braccio il punto dove il motoscafo continua la sua deriva insieme a una macchia scura.
Il padre guarda ma non parla.
«Papà, c’è un corpo là, che galleggia!», indicando sempre lo stesso punto e aggiungendo: «Me lo riprendi tu il motoscafo?».
«Certo, lo faccio io», senza distogliere lo sguardo.
«Ma perché non l’hai riportato a riva? Cos’è, te la sei fatta sotto?», diretto, si inserisce il pilota che ha vinto.
«Brando smettila!», lo riprende la madre.
«Brando, che bel nome! È il mio attore preferito, lo sai?», fa il padre cercando di cambiare discorso.
«È un cognome», puntualizza il bambino. «Io mi chiamo con un cognome, come il cane della vicina e non mi piace neanche!», chiudendo il discorso dalla parte della ragione.
III
Lungo un viale che conduce al laghetto, una ragazza strizza gli occhi quasi a sfidare una miopia vissuta senza occhiali, vezzo tipico dell’età che supera di poco i venti. L’avrebbe abbandonato presto come tutte, usando gli occhiali per schermarsi dalla vita e nascondere le rughe. Cerca di sciogliere un’interferenza visiva, mentre il fidanzato con un meticcio al guinzaglio la saluta, sale sulla sua vettura e se ne va. Lei ha il casco in mano. È certa di aver visto qualcosa di strano all’orizzonte, ma è ancora troppo lontana per mettere a fuoco l’ipotesi o una fantasia. Accelera il passo, quasi di corsa restringe le distanze. Una deposizione si staglia sul fondo azzurro del cielo. I capelli neri e la figura gonfia di acqua. Rivoli colano da tutta la superficie lasciando cadere come un mantello di gabardine il soprabito zuppo. I ragazzini guardano, niente affatto sconvolti. Nessuna impressione, né l’intento da pettegolezzo ma solo l’idea di essere dentro alla situazione, per la prima volta testimoni di un gesto pubblico. Natura morta, un assemblaggio di forme. Lentamente il corpo viene calato in una piccola area ben delimitata. A terra sono stati adagiati dei teli di plastica bianca.
«È morto un bambino lo scorso inverno», commenta la madre del vincitore della gara mentre gli pettina i capelli ricci e scompigliati.
«Andava in bici sul ghiaccio e si è rotto», aggiunge il figlio, guardando negli occhi la ragazza miope che si è fermata per raccogliere al volo le parole di un bambino, fanno sempre il loro effetto, prendendo appunti senza lasciarsi sfuggire nulla.
«E adesso cos’è successo?», gli chiede lei per amor di cronaca.
«Boh», fa il ragazzino. «Il mio amico ha trovato un corpo, guarda là», con l’indice piccolo. «Qualcuno dev’essere affogato», poi di scatto alla madre: «Affogato è morto, vero mamma?». «Affogato è come dire che non è più vivo», gli spiega lei con tono da educatrice, infastidita perché costretta a parlare di un argomento tanto scomodo quanto estraneo alla loro esistenza. Il figlio non è ancora soddisfatto, la guarda negli occhi aggiungendo: «Ma se gli togli l’acqua dai polmoni riprende a respirare… no, mamma?».
«A volte sì, altre volte no.»
«E questa volta?»
«Come faccio a saperlo, adesso chiediamo e sentiamo cosa ci dicono», decisamente scocciata, spostando il momento e la responsabilità della risposta e lasciando aperto nella mente del figlio uno dei più grandi quesiti dell’esistenza.
Matteo è ancora lì. Il corpo l’ha trovato lui. È bagnato dalla testa ai piedi, la temperatura frizzante dell’aria somma freddo al freddo. Il padre gli toglie il giubbotto e gli infila il suo golf. Non basta. Lo prende in braccio, lo stringe a sé. Un poliziotto chiede all’uomo di seguirlo per lasciare generalità e indirizzo. Gambe svelte, non se lo fa ripetere. Vorrebbe andarsene subito. Si consola pensando che quella è la stessa strada che avrebbe fatto comunque per arrivare alla sua auto. Il tragitto più breve passa per forza tangente alle transenne che formano il nuovo argine provvisorio, a separare chi guarda dal basso da chi, forse, dall’alto. Cielo e pozza riflettono lo stesso colore.
La testa di Matteo, nel frattempo, si è appoggiata con il mento sulla spalla, come quando era piccolino, si rilassava così fino al sopraggiungere del sonno, poi gambe e braccia cadevano molli, morbide, in totale balia del genitore che lo accoglieva. Il padre avverte ancora la sua indispensabilità, e con tutte le sue forze cerca nell’abbraccio di comunicarlo al figlio. Cammina veloce, felice di sentire quel peso. Come d’istinto getta lo sguardo tra le divise, per compensare la fatica, per curiosità. Appoggia gli occhi tenendoli radenti un po’ su tutto, fino a rallentare, a fermarsi, riempire i contorni. Matteo alza il capo dalla spalla e si gira verso lo sguardo del padre. I due volti osservano lentamente, insieme, un istante lungo, silenzioso, confuso. L’uomo lascia passare visi, legge parole mute sulle labbra, vede mani che spostano, con cura o senza pietà, con sapienza, senza esitazioni. Alzano, stendono, ricompongono. Matteo, costretto dalla pausa forzata del padre, cerca di mettere a fuoco tutto quel movimento. Una draga. Vorrebbe sapere come funziona, a cosa serve, perché è lì. Il padre spiega con automatismo: «A pulire il fondo, a rimuovere ingombri, ogni tanto si fa, per mantenere l’acqua limpida».
«Ho freddo», risponde Matteo, le risposte date così per dovere, non lo coinvolgono, il padre lo sa e stringe ancora di più a sé.
Adesso la ragazza miope ha un tesserino stampa al collo. Osserva quell’uomo in piedi con il figlio in braccio, accenna un sorriso di circostanza, con un certo imbarazzo, nella direzione del bambino. Poi la sua espressione si fa meno incerta, i lineameni si induriscono cercando una seriosa complicità. Il padre la guarda intensamente, è giovane, di una bellezza sobria. Dietro agli occhiali, in altri abiti. Ma non riesce a rispondere a quell’intesa. Poi ci ripensa e sembra quasi volerle dire qualcosa, ma lei ha già il casco in testa, non si fa intercettare e se ne sta andando nella direzione del suo scooter. Pochi secondi dopo è ancora Matteo a parlare: «Papà…».
«Cosa c’è?», domanda l’uomo al figlio.
«Non c’è più niente da fare, vero?»
«Credo di no, Matteo», risponde l’uomo.
«E io?»
«E tu non ti devi preoccupare.»
Matteo ha da poco smesso di piangere quando a cominciare è suo padre. Sono lacrime grosse accompagnate da singulti che bloccano il respiro. Il bambino guarda il padre, aspetta una risposta. Che arriva con un gesto. Il padre lo depone a terra e insieme, lentamente, mano nella mano si avvicinano allo specchio d’acqua e all’ampio telo bianco dove un corpo esile sta per avere un nome. Il bambino osserva, e piano allenta la presa fino a lasciare la mano del padre, poi correndo si butta addosso alla sagoma sdraiata, baciandola tutta da tutte le parti, strofinandosi a lei come a volerla scaldare cercando un movimento anche piccolo delle mani e delle braccia, aprendo le palpebre per riconoscerne lo sguardo e sentirsi ancora una volta cercato. Il padre non prova a trattenerlo, piuttosto deve impegnarsi a respingere la violenza istintiva e giustificata delle forze dell’ordine che bloccano la sua avanzata e cercano di strappare Matteo all’abbraccio della salma. «Ma è sua madre. Mia moglie», dice a bassa voce agli uomini in divisa. E si scontra con la necessaria prassi, proteggere il cadavere, già di per sé corrotto dall’acqua, da qualunque altra contaminazione. Matteo la tocca infilando le mani sporche di terra nelle tasche del soprabito, frugandola come se cercasse la vita in posti sconosciuti, sorprendenti, inaspettati. Sono lì le sue piccole dita a misurare ogni centimetro di pelle cercando di entrare là dove anni prima si era sentito così protetto e al riparo. La forza del destino ha riservato alla donna quell’ultimo contatto con il suo bene più grande. A quel bambino la violenza del dolore più forte. La disperazione sale come una marea ma due braccia grandi e forti fanno appena in tempo a sollevarlo di peso. Il poliziotto Achille Maria Funi lo sta abbracciando, concedendogli un nuovo pianto a dirotto. E mentre le lacrime gli bagnano il collo pensa che deve fare una telefonata. Per forza. Deve chiamare il suo ispettore. Deve farla arrivare al più presto. Prima che questo caso venga affidato a qualcun altro.
Scritto mercoledì, 4 luglio 2007 alle 23:26 nella categoria SEGNALAZIONI E RECENSIONI. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.









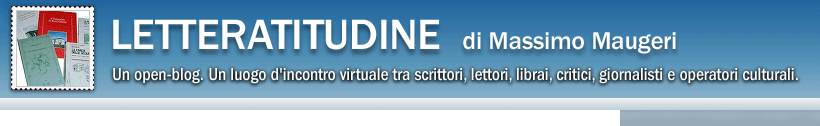














 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI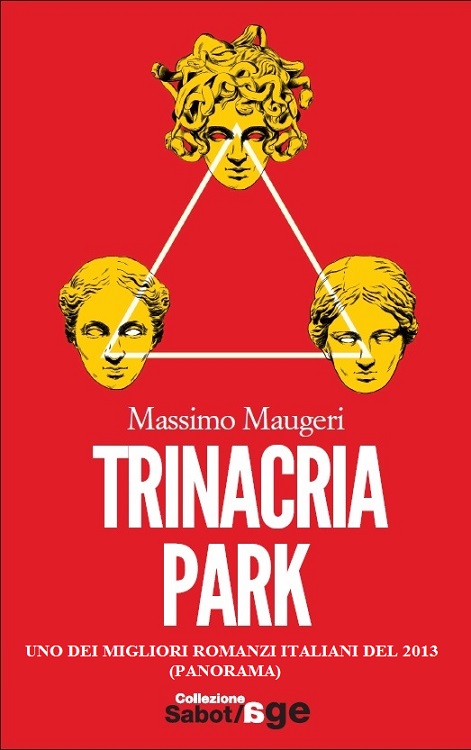
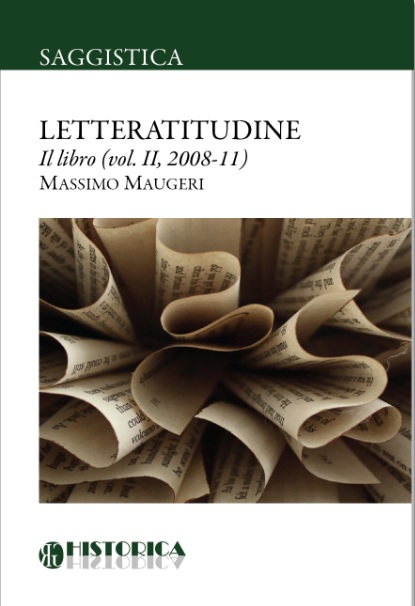


Commenti recenti