domenica, 30 marzo 2008
IL RIBELLE IN GUANTI ROSA. CHARLES BAUDELAIRE di Giuseppe Montesano
Parliamo di Charles Baudelaire. E parliamo di uno dei libri più interessanti pubblicati nel 2007 in Italia: “Il ribelle in guanti rosa” di Giuseppe Montesano.
“Il fondatore della poesia moderna, il poeta maledetto, il critico della borghesia, il più celebrato cantore degli eccessi (il sesso, gli alcol, le droghe) nella modernità: non è facile scrivere di Baudelaire, raccontarne la strepitosa parabola letteraria e umana senza incorrere nei luoghi comuni da una parte e nelle sofisticate distinzioni degli specialisti dall’altra. Il libro di Montesano cerca questa terza via, conducendo il lettore in una Parigi brulicante di teorie, di rêveries, allucinazioni oscure e illuminazioni abbaglianti, incontra una folla di personaggi insigni e oscuri. E soprattutto, se Baudelaire è il poeta che “si è consegnato a molte maschere”, Montesano cerca di indentificarle tutte, di registrarle minuziosamente per poi strapparle, svelandone ora il sovrapporsi al volto ora il confondersi con la carne e il sangue dell’uomo che vi sta sotto”.
Giuseppe Montesano – che è romanziere, ma si occupa anche di letteratura francese (tra le altre cose è curatore con Raboni dei Meridiani Mondadori su Baudelaire) – sceglie di parlare del “poeta maledetto” attraverso un saggio-romanzo frutto, peraltro, di un lavoro decennale.
Credo che questo post possa essere una buona occasione per discutere di Baudelaire e approfondire la conoscenza (o fare la conoscenza) di questo poeta (ma anche scrittore, critico letterario e traduttore) francese.
Ovviamente siete invitati a dire la vostra.
Di seguito potrete leggere la recensione di Andrea Di Consoli, che pubblichiamo all’interno della sua rubrica “La stanza dello scirocco”.
(Massimo Maugeri)
____________
____________
recensione di Andrea Di Consoli (nella foto)

Adesso diranno semplicemente che è uno studioso – “un critico”, per giunta – ma Il ribelle in guanti rosa (Mondadori, 441 pagine, 19,00 euro) di Giuseppe Montesano (Napoli, 1959), autore di fortunati romanzi come Nel corpo di Napoli (1999) e Di questa vita menzognera (2003), è davvero un libro sorprendente e unico, forse uno dei pochissimi grandi romanzi critici degli ultimi anni – un libro che conosce e racchiude tutte le forme e tutti i metodi di camminamento e di discendimento “nel corpo” di un autore e del suo tempo. Come tutti i grandi scrittori novecenteschi, Montesano ha usato, nella sua intensa vita letteraria, più generi espressivi: il racconto, il romanzo, il teatro, la critica letteraria, il romanzo a puntate, la critica musicale e la traduzione (ha tradotto Baudelaire, Villiers de L’Isle-Adam, Flaubert, Gautier), e ha così riconfermato (felicemente) l’assunto che il romanzo è solo la punta di un iceberg in un oceano di cultura e di curiosità. Saggio, certamente; sicuramente critica stilistica, storica, morale e filosofica; biografia, senza dubbio; ma, infine, e sia detto senza nessun ordine di valore, il grande romanzo di un uomo inafferrabile, di un poeta chiuso nella morsa delle sue contraddizioni: Charles Baudelaire (1821-1867), cantore e nemico di Parigi, demone celestiale e infernale, poeta classico e assolutamente moderno, unione di opposti d’inesauribile complessità.
Il romanzo critico di Montesano è un viaggio teso e inquirente in una selva di segni (poesie, lettere e testimonianze) in cui è impigliata e invischiata la tumultuosa vita di Baudelaire, il re dei “maledetti”; anzi, è una specie di “basso” napoletano colmo di vicoli e sotterranei segreti, in cui Montesano ha camminato in tanti anni di oscura “ossessione”, come un pensoso flâneur, un “amante” assetato con la lente d’ingrandimento, un filosofo che sa svelare i segreti sublimi della lirica, senza perdere mai di vista il duro reale, le strade lerce, i vizi, (“l’erotìa e l’interesse”, direbbe Gadda), l’oro del tempo storico che, sotto un luccichio sfavillante, nasconde il “duro metallo della violenza”. E, a proposito di “erotìa”, Montesano cerca anche di sfondare il muro misterioso che ci nasconde la bella Jeanne Duval: “[...] Era bellissima. Non abbiamo fotografie, e l’unico ritratto che la raffigura è un quadro di Manet che la dipinse forse a memoria, atrocemente devastata dalla malattia: ma Jeanne era bellissima”. Il Baudelaire di Montesano è un uomo che si diverte a “dare il cattivo esempio”. E’ un poeta malinconico e irascibile, tormentato dai debiti, dalle cambiali, dalle scadenze e dalla gestione controllata del suo patrimonio (tutti sanno l’odio che provava nei confronti del patrigno Aupick). Scrive Baudelaire alla madre: “Quando si ha un figlio come me non ci si risposa”. E’, Baudelaire, un poeta che vive la sua breve esistenza sotto l’ombra dello spleen. Scrive Montesano: “Lo spleen era l’esperienza della distruzione non definitiva, quel calarsi nella ferita della ragione resistendo in essa [...]“. La sua umanità era fatta di prostitute, illuminati, idealisti, ermetici, ubriaconi, artisti e rivoluzionari (“Baudelaire era attratto dai mistici di ogni genere che affollavano mansarde e abbaini delle vie più povere di Parigi”; e ancora: “
La Parigi per la quale si aggirava il giovane Baudelaire con la curiosità di chi cerca l’eccesso pullulava di mistici da baraccone, di insofferenti al pensiero logico e di rivoluzionari pronti ad appiccare il fuoco all’intera società [...]“). E Montesano si cala totalmente con Baudelaire in quest’inferno paradisiaco, e ingrandisce dettagli, svela segreti (l’Ennui non è altro che Napoleone III), sporca le sue mani con il materiale vischioso dell’esistenza del suo poeta e, abitando interamente l’universo baudeleriano, non può fare a meno di diventare anch’egli (in absentia) un personaggio di quella Parigi lì, restituendoci l’immagine di un detective neoplatonico e barocco, irrazionale e sapienzale, rivoluzionario e apocalittico.Il Baudelaire di Montesano è un barricadiero, un rivoluzionario, (non un “democratico da caffè”), uno che ha sposato la causa della rivolta operaia del 1848, solo in apparenza per ragioni “private” (colpire il suo patrigno-generale). In realtà Montesano ci svela che Baudelaire aveva una salda conoscenza “tecnica” del socialismo: “Negli anni in cui non aveva disdegnato la lettura dei mistici del socialismo, Baudelaire aveva letto attentamente un filosofo che non era un mistico ma si vantava di essere un tecnico dell’amara scienza, che per lui come per Marx aveva in Ricardo il suo vero fondatore: quella scienza era l’economia politica, e quel filosofo si chiamava Pierre-Joseph Proudhon”. Scrive Montesano: “Solo chi scende al livello della strada e abbandona l’egoismo può sposare le folle di Febbraio e di Giugno [...]“. E’ strano scoprire questa “faccia” di Baudelaire, un poeta che “traffica” con Blanqui, Proudhon e il socialismo cristiano, e che non è soltanto (o non è più) un parnassiano, il cantore della modernità della città di Parigi, o il restauratore del classicismo e, al contempo, colui che ha minato dall’interno, con la dissonanza, e con l’asimmetria, la perfezione della poesia. Il poeta sublime attacca l’art pour l’art, e si dichiara commosso dalla poesia “vera” di Dupont. Ma, probabilmente, il “socialismo cristiano” di Baudelaire, come scrisse Walter Benjamin a proposito di Blanqui, non presupponeva affatto la fede nel progresso, ma solo la decisione di farla finita con l’ingiustizia del presente. Delacroix, nel 1849, a un anno dai moti del ‘48, annota sarcastico nel suo diario: “Venuto il signor Baudelaire [...] Le sue idee mi sembrano modernissime e davvero sulla via del progresso. Uscito lui [...] Stato d’animo molto triste”. Era troppo difficile capire il sogno di Baudelaire: unire “i pezzi rotti dell’umanità” non nella purezza astratta dello spirito, “ma nella carne e nel sangue, e contro gli idealisti che escludevano l’eros dall’amore”. Tutto sembra perduto: la malattia, i debiti, le sconfitte del ‘48 (e del ‘52). E la pulsione sovversiva non è altro che il ghigno smorfioso dello spleen. “La catastrofe è che tutto continui come prima”, scrive Baudelaire. Ma la vera catastrofe è l’uomo che aspira all’assoluto, al segreto inafferrabile del tempo e dei simboli del mondo; pure, il senso di estraneità che il poeta prova nella sua Parigi. Scrive Benjamin: “Nessuno si è mai sentito così poco a casa propria a Parigi quanto Baudelaire”. Il povero dandy cambiava continuamente domicilio, dormiva su letti “di fortuna” (“Dentro Parigi, il suo deserto vivente, senza fuoco né luogo”, scrive). E’ quasi una premonizione di quei “non-luoghi” teorizzati, molti anni dopo, dall’antropologo Marc Augé. Le Fleurs du mal Montesano le scandaglia con l’ultravista della dimestichezza: “Le grandi liriche delle Fleurs du mal sono scritte in una lingua doppia, una lingua che nasconde sotto la corazza abbagliante delle immagini le verità che non si possono pronunciare”. Non piacevano, le poesie di Baudelaire; anzi, offendevano, indignavano, inducevano alla censura (la storia dell’immediata [non] ricezione delle poesie baudeleriane viene affrontato in apertura di libro, nel capitolo dal feroce titolo Dategli una lezione, a questo poeta infame). Il clima in cui sorsero le fleurs fu impossibile. Ancora nel 1868, a un anno dalla morte, sua madre scriveva a Charles Asselinau: “Vi chiedo di sopprimere la poesia intitolata Le Reniement de saint Pierre. Come cristiana io non posso, io non devo lasciar ristampare questa cosa. Se mio figlio vivesse, sicuramente oggi non la scriverebbe, avendo avuto, negli ultimi anni, simpatie religiose”. L’attraversamento che Montesano fa dei versi di Baudelaire è impressionante; procede per intuizioni, per collegamenti, per rimandi alla più importante Weltliteratur. Scopriamo, per esempio, il legame con Sade, in specie nella pulsione all’oltraggio della natura (nei versi di A’ celle qui est trop gaie).
Ovviamente è impossibile dare minimamente conto di ciò che accade in questo romanzo-mondo, in questa fitta selva di dettagli, di atmosfere, di “fatti”. E’ sicuramente interessante – prima del capitolo finale: il capitolo della paralisi e della morte – accennare al periodo belga di Baudelaire. Già qualche anno fa Montesano aveva curato e tradotto per Mondadori Il paese delle scimmie, “diario” impietoso e risentito contro il Belgio piccolo-borghese, bigotto, senza grazia. Ma perché Baudelaire, nel 1864, andò in Belgio? Scrive Montesano: “[A Parigi] i debiti crescevano, avere soldi in prestito era sempre più difficile, i giornali non lo pubblicavano, Parigi era un carcere, Jeanne paralizzata: bisognava fare qualcosa, spostarsi, agire. E disperatamente, come un animale notturno intimidito dal frastuono, infastidito dai fuochi d’artificio delle feste di regime, sbattendo le palpebre nella luce che cancellava allegra le vittime, Baudelaire partì per il Belgio”. Come molti grandi poeti, Baudelaire è stato un esiliato, in conflitto con il proprio tempo, dilaniato dalle contraddizioni, continuamente richiamato dalla “strada” (dalla vita) e continuamente respinto. E’ stato l’anima di un paese e di una città e, allo stesso tempo, “cittadino” estraneo, espulso, deriso, rifiutato. In Baudelaire vita e letteratura, sovversione politica ed estasi mistica, “alto” e “basso”, verità e menzogna, erotismo e amore, sensualità e razionalità, inferno e paradiso, ordine e disordine convivono come segni tangibili della massima apertura che un’anima terrena possa raggiungere. Perché solo nella contraddizione lacerante è possibile la grandezza (sfiorare il grande segreto del mondo), solo così è possibile durare in eterno, nonostante la paralisi, nonostante la morte che tutto polverizza. Baudelaire era ossessionato che tutto venisse dimenticato. Anche grazie a libri come Il ribelle in guanti rosa la sua stella lucente indica ancora una rotta precisa nel firmamento della letteratura mondiale.
Andrea Di Consoli
___________
___________
Brano estratto da Il ribelle in guanti rosa. Charles Baudelaire (Mondadori, 2007) di Giuseppe Montesano. Per gentile concessione dell’autore.-
Lui era stato gabbato fino in fondo dalla speranza, lui aveva creduto che fosse possibile un’altra vita, lui aveva creduto che fosse possibile ringiovanire, lui aveva creduto che potesse arrivare il nuovo che capovolge i giorni e li fa risplendere: e il dandy che si voleva straniero al mondo aveva dovuto riconoscere nel corpo della paria la fraternità possibile. Ma quando? E dove? Non poteva essere pronunciato né il dove né il quando, ma il possibile brillava come gli occhi delle ragazzine e i seni radiosi della mendicante, e la salvezza della realtà tutta intera era affidata come una visione, in uno specchio e enigmaticamente, alla poesia: “La poesia è ciò che vi è di più reale, ciò che non è completamente vero che in un altro mondo.” La violenza della morte evocata da Baudelaire deve passare, come passa nella Scrittura la figura di questo mondo, il nuovo non può essere pronunciato finché la vittima è inestricabile dal carnefice, il nuovo non arriverà se non quando tutte le lacrime dei massacrati di Giugno e di ogni tempo che gli stanno ancora piantate nella carne non saranno asciugate, il nuovo sarà solo quando il circolo vizioso dell’eterno ritorno dell’uguale si spezzerà: “E Dio stesso sarà con loro e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non esisterà più, né lutto, né grida, né sofferenza esisteranno più, perché le cose di prima sono scomparse.” Allora la voce di colui che nell’Apocalisse può dire Ecco, io faccio nuova ogni cosa, pronuncerà la parola tornata materna, la lingua finalmente natale, e dall’abisso “interdetto alle nostre sonde” sorgerà la vita vera: “A chi ha sete darò gratuitamente dell’acqua della vita.”
Ma questo non sarà ora, e non qui. A ritmo di galop come nelle detestate operette, l’enigmatica commedia finale è cominciata, la vita non si lascia dire. Rimprovera la madre per aver scritto “inquieta” con due t, piange sulle privazioni come un bambino, il 26 febbraio la sgrida perché ha dimenticato la sua età: “Altro errore: e questo da parte di una mamma è troppo forte: tuo figlio non ha quarantasei anni. Ne avrà quarantacinque solo fra un mese e qualche giorno.” Ma tra quel mese e qualche giorno lui sarà muto, l’afasia lo avrà ingoiato: ci saranno solo le parole della madre che vuole tenerselo “come un bambino piccolo”, che dichiara che dopo gli attacchi di collera il figlio “ha a volte dei lunghi scoppi di risa che mi terrorizzano”, la madre che ancora gli rimprovera “una cura eccessiva della toilette”, che tacendo le bestemmie rabbiose del figlio lo loda perché quando le suore vogliono fargli fare il segno della croce lui si comporta “con una pazienza ammirevole, chiude gli occhi, o volta la testa dall’altra parte senza infastidirsi”, ma che poi afferma: “Ha una sola idea fissa: non essere dominato…” Allora, nel suo mutismo e nei sorrisi da bestia ferita, ci sarà tempo solo per l’eccitazione di sentire ancora una volta la musica che canta l’indistruttibile Venere, per lo stupore che lo coglie nello scoprirsi vivo. Contro la religione della morte è rimasto sempre sveglio, e l’amore è stato la sua misteriosa protezione. E anche se nei giorni prima della paralisi si muove a fatica, per sentire ancora il profumo dell’altro mondo, il profumo del femminile, la lentezza, l’indugio, il non arrivare, lo spreco, la dolcezza, ritorna nella chiesa di Saint-Loup. E nel ventre accogliente del grande catafalco “ricamato in nero, rosa e argento”, dentro l’ultima figura terrena del “gioiello rosa e nero” che conserva la vita, nel rifugio in cui alita il piacere che spinge gli amanti “mollemente bilanciati sull’ala del turbine intelligente” verso il paradiso, in un freddo profumo d’incenso, tornano le immagini della salvezza: sono i piedi di Jeanne che lui ha cullato come bambini facendoli addormentare tra le sue mani “fraterne”, sono gli occhi della passante in cui “fiorisce l’uragano” e il cui sguardo lo ha fatto “improvvisamente rinascere”, è il corpo di Sarah che il ventenne figlio di famiglia ha leccato “con più fervore che la Maddalena i piedi del Salvatore”, sono i seni della mendicante che si intravedono tra gli stracci “radiosi come occhi”, sono i capelli di Jeanne in cui tuffava le mani per respirare “il vino del ricordo” di una vita anteriore. Troppo tardi? All’uscita da Saint-Loup inciampa su un gradino e sviene, la paralisi comincia a diffondersi, detta ancora una lettera dove corregge una poesia che si intitola Bien loin d’ici, pochi versi in cui nella grana della pelle di Jeanne odorosa di olio e di benzoino compare l’altra vita, poi ammutolisce, come un animale. Esiste davvero questo luogo molto lontano da qui? Il 31 Agosto del 1867, Baudelaire muore. Due giorni dopo è inumato nel cimitero di Montparnasse, a fianco del generale Aupick. Fa caldo, Parigi è vuota, gli scrittori e gli editori sono in campagna per il fine settimana. Il Ministero non ha mandato nessuno, la Société des gens des lettres non ha mandato nessuno. Niente sembra cambiare, e fino a quando ci sarà l’eterno ritorno dell’ingiustizia, nemmeno i fantasmi troveranno pace. Più d’uno non verrà più a cercare la zuppa profumata, all’angolo del fuoco, la sera, vicino a un’anima amata. Deve essere sempre così? È sempre troppo tardi per qualsiasi cosa? E’ così, e non è vero. I ragazzi di vent’anni ancora sognano di portare rose rosse sulla sua tomba, e vogliono sputare su quella del generale Aupick. Da qualche parte, in una prigione, in un sotterraneo, la voce dell’insurgé, stanca ma non arresa, mormora: il faut recommencer, bisogna ricominciare. C’è tutta la vita che aspetta di essere risvegliata, chiede di essere sciolta dalle bende sacrificali, vuole parlare nella sua lingua natale. Ci sarà davvero quest’altra vita, molto lontano da qui? Lui aveva ripetuto che la bellezza è la promessa della felicità. E’ vero? Non adesso, non in questa realtà, ma adesso, in questa realtà, non ce ne sono altre, la promessa brilla ancora in tutto il suo splendore.
Pubblicato in SEGNALAZIONI E RECENSIONI 119 commenti »









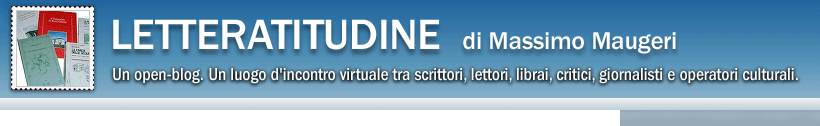

 In questi casi, il classico dei classici è svegliarti una mattina, andare in bagno, sciacquarti la faccia e scrutare nello specchio. Dopodiché accorgerti di qualcosa e avvicinarti ancora un po’ alla tua immagine riflessa per accertarti di aver visto bene. Non può essere. Sì che può essere.
In questi casi, il classico dei classici è svegliarti una mattina, andare in bagno, sciacquarti la faccia e scrutare nello specchio. Dopodiché accorgerti di qualcosa e avvicinarti ancora un po’ alla tua immagine riflessa per accertarti di aver visto bene. Non può essere. Sì che può essere. Quando
Quando 




 Questo è il mio debutto e il mio finale.
Questo è il mio debutto e il mio finale.

 Per una serie di circostanze, che capirà chi avrà la pazienza di leggersi tutti i commenti del post, si è deciso di anticipare la chiusura del gioco alla mezzanotte di mercoledì 12 marzo 2008 procedendo alla votazione dei due libri ammessi al ballottaggio.
Per una serie di circostanze, che capirà chi avrà la pazienza di leggersi tutti i commenti del post, si è deciso di anticipare la chiusura del gioco alla mezzanotte di mercoledì 12 marzo 2008 procedendo alla votazione dei due libri ammessi al ballottaggio. AGGIORNAMENTO di giovedì 13 marzo 2008
AGGIORNAMENTO di giovedì 13 marzo 2008 Le splendide Laura Costantini e Loredana Falcone, coppia di ottime scrittrici, altresì note come
Le splendide Laura Costantini e Loredana Falcone, coppia di ottime scrittrici, altresì note come  Ecco. Quando ho letto per la prima volta il titolo del nuovo romanzo di
Ecco. Quando ho letto per la prima volta il titolo del nuovo romanzo di 













 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI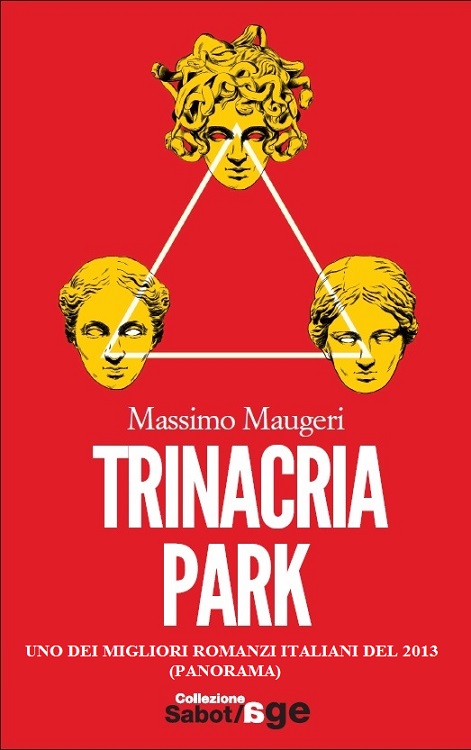
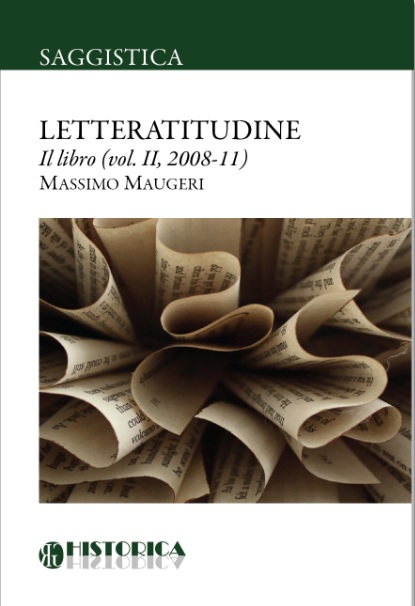


Commenti recenti