martedì, 27 maggio 2008
L’ITALIA TRA LA PAURA DELLO STRANIERO E GLI SGUARDI PERPLESSI DALL’ESTERO
 Sul Domenicale de Il Sole24Ore del 25 maggio sono apparsi due articoli molto interessanti e, almeno a mio avviso, complementari.
Sul Domenicale de Il Sole24Ore del 25 maggio sono apparsi due articoli molto interessanti e, almeno a mio avviso, complementari.
Il primo porta la firma di Remo Bodei ed è incentrato sulla paura dell’altro, dello straniero, del diverso.
“Da tempo immemorabile”, scrive Bodei, “tutte le comunità umane cercano di mantenere la loro coesione nello spazio e nel tempo mediante la separazione dei propri componenti dagli “altri”. Più una società è debole e insicura, più la formazione del “noi” esige rigorosi meccanismi d’esclusione e, generalmente, d’attribuzione al noi di un qualche primato, reale e immaginario, e, per converso, di degradazione, sospetto e timore riguardo all’altro, al diverso. (…) La direzione della paura è storicamente cambiata. Nel passato, anche recente, era soprattutto il potere statale a incuterla (…). Secondo un detto anglosassone, un Paese è democratico quando chi viene alla vostra porta di primo mattino è il lattaio e non la polizia politica.”
Certo, la situazione oggi, da noi, è diversa. La paura pare provenire più – appunto -dall’altro, dallo “straniero”.
Vi giro le stesse domande che pone Bodei nell’articolo.
Che succede se chi vi entra in casa non è né il lattaio, né il poliziotto, ma un rapinatore che, oltre a impossessarsi dei vostri beni, attenta anche alla vostra vita?
Se vostra figlia viene stuprata a una fermata della metropolitana?
(Urge – è evidente – sicurezza).
Ma quale sicurezza?
Quali misure prendere per evitare una militarizzazione della società, una sua chiusura che la esponga a una sorta di malattia del ricambio, che semini il sospetto, che si pieghi a strumentalizzazioni politiche e che delegittimi l’accoglienza dell’altro, vedendovi solo un potenziale nemico?
Belle domande, vero?
Voi che ne pensate?
L’altro articolo, quello di Alessandro Melazzini, affronta un altro problema (per certi versi speculare a quello evidenziato da Bodei). Come ci vedono dagli altri paesi? (Se vi ricordate ne avevamo già discusso, in parte, in questo post nato a seguito della pubblicazione del noto articolo sul New York Times che etichettava gli italiani come un popolo di depressi).
 «Questa è la vecchia Italia. Ammirata e guardata con stupore. Soprattutto derisa» scuote la testa lo Spiegel «una terra di commedianti e imbroglioni, di amabili birbanti, ingannatori ed eterni bambini».
«Questa è la vecchia Italia. Ammirata e guardata con stupore. Soprattutto derisa» scuote la testa lo Spiegel «una terra di commedianti e imbroglioni, di amabili birbanti, ingannatori ed eterni bambini».
Secondo gli occhi dei tedeschi, come scrive Melazzini, l’Italia che emerge è quella che vede “Napoli sommersa dai rifiuti, avanzi di fascismo impenitente à la Ciarrapico in Parlamento, spigliate soubrette innalzate a Ministro, tutto il potere all’incomprensibile Berlusconi (quello dell’indimenticata battuta europea sui kapò), Roma che attacca i campi nomadi, Verona con un sindaco leghista che sposta il ritratto di Napolitano per fare spazio all’effige di un capo di Stato straniero: il Papa.”
Poi, però, vengono riportati pareri positivi (vi invito a leggere l’articolo per intero). Vengono citati “i fatti” di Duisburg e riportate le opinioni di Woller e Ulrich («Sono tutti problemi europei» sostiene lo storico Hans Woller, «basti pensare allo scandalo della Siemens o alla criminalità giovanile in Francia. Marchiare a fuoco lo Stivale è sbagliato: tutta l’Europa a questo riguardo è italiana»).
Da qui si evince che la società tedesca, al di là delle polemiche, sa perfettamente distinguere tra pochi e violenti mafiosi e molti italiani onesti.
Tuttavia, al di là di come ci vedono in Germania, l’immagine dell’Italia all’estero pare un po’… offuscata.
E allora…
Che accade agli italiani? E cosa ne è del loro fascino?
Ma poi… siamo sicuri che il marcio è solo di marca italiana?
Che dire allora degli articoli sulla corruzione, la criminalità e il razzismo di cui si legge in questi giorni sulla stampa tedesca?
Ecco… mi piacerebbe discuterne con voi.
Intanto ne approfitto per ringraziare Remo Bodei e Alessandro Melazzini, nonché gli amici della redazione del Domenicale de Il Sole24Ore che mi hanno concesso la possibilità di riprodurre gli articoli citati.
Li trovate qui di seguito. Riportati integralmente.
Massimo Maugeri
——————-
SOTTO IL REGNO DELLA PAURA di Remo Bodei
Nel 1538 si festeggiava a Città del Messico la pace nella lontana Europa tra Carlo V e Francesco I. Racconta il cronista Bernal Diaz Castillo che all’occasione – nella piazza dove sorgeva il Templo Mayor e dove si stava innalzando al suo fianco la cattedrale – venne allestito uno strano spettacolo. Furono portati migliaia d’alberi, per simulare una selva, immediatamente popolata da villosi selvaggi. Questo ambiente avrebbe dovuto rappresentare il nuovo regno conquistato appena quindici anni prima. Colpisce e meraviglia una doppia incongruità: che nella metropoli circondata (secondo la testimonianza di Cortéz) da quaranta torri alte quasi cento metri, come la Giralda di Siviglia, nel centro di un tessuto urbano monumentale impressionante, si riducessero gli Indios a selvaggi. Ma fa specie, soprattutto, che uomini dal corpo glabro e liscio venissero travestiti ricoprendoli di pellicce. Come era possibile che la realtà venisse alterata sino al punto di negare l’evidenza percettiva? Perché si proiettavano su una nuova esperienza vecchi schemi e pregiudizi, non solo attribuendo il monopolio della civiltà ai conquistatori, ma rappresentando i presunti selvaggi secondo il modello dell’anacoreta villoso – come Sant’Onofrio – che si faceva crescere i capelli nel deserto? La cecità nei confronti delle altre culture è in questo caso evidente ed è mossa dal desiderio e dalla volontà di abbassare gli altri a un livello di primitività che rasenta la vita animale e, nello stesso tempo, di esorcizzare la paura nei loro confronti.
Da tempo immemorabile tutte le comunità umane cercano di mantenere la loro coesione nello spazio e nel tempo mediante la separazione dei propri componenti dagli “altri”. Più una società è debole e insicura, più la formazione del “noi” esige rigorosi meccanismi d’esclusione e, generalmente, d’attribuzione al noi di un qualche primato, reale e immaginario, e, per converso, di degradazione, sospetto e timore riguardo all’altro, al diverso. Eppure, per non soffocare nel proprio isolamento, ogni comunità (specie se evoluta) prevede meccanismi opposti e complementari di inclusione degli altri. In ciascuna permane comunque una costitutiva ambiguità, che può venire efficacemente illustrata a partire da una etimologia. Nel “Vocabolario delle istituzioni indoeuropee” Émile Benveniste ha mostrato come la parola latina “hostis” indichi simultaneamente l’”ospite” e il “nemico”, uniti dalla comune relazione di scambio e di reciprocità: il primo scambia, in positivo, dei doni; il secondo, in negativo, la morte. Lo straniero è così, contemporaneamente, un ponte verso l’alterità e una minaccia per la compattezza della popolazione, un antidoto alla sterile chiusura in se stessi e un condensato di paure.
L’incertezza del vivere deriva oggi, appunto, dalla percezione diffusa che lo straniero costituisce un potenziale nemico piuttosto che un possibile ospite (oltre che una persona che, con il suo lavoro, contribuisce spesso al nostro benessere). Se paura e speranza, nella loro polarità, sono entrambe alimentate dal bisogno di sfuggire ai pericoli del presente e all’incertezza del futuro, viene da chiedersi se non vi sia una proporzione inversa tra il diminuire della speranza in un futuro migliore e la crescita di angosce plurime o senza nome che si catalizzano sullo straniero. I problemi suscitati dall’inserzione impetuosa in altri contesti di milioni di persone di cultura diversa, spinte a emigrare dalla povertà o dalle guerre, certamente non mancano. Pericolosa è tuttavia la generalizzazione di casi singoli (anche se frequenti), il confondere gli individui con un gruppo etnico o religioso o il proiettare su di loro stereotipi o formule ideologiche di comodo.
In un mondo che si restringe e le cui parti divengono interdipendenti non c’è oggi alcuna sensata alternativa all’integrazione, la quale non coincide né con l’assimilazione, né con la creazione di ghetti (e neppure con il cosiddetto buonismo, un alibi per non assumere concrete responsabilità, o con la xenofobia, un acido che corrode la civile convivenza). L’integrazione rappresenta piuttosto un lungo e paziente processo di annodamento delle differenze all’interno di un tessuto sociale che le renda non solo compatibili, ma, in prospettiva, feconde.
La direzione della paura è storicamente cambiata. Nel passato, anche recente, era soprattutto il potere statale a incuterla. Nella filosofia politica veniva messa alla base dei regimi dispotici: dal “phobos”, attribuito dai Greci agli Orientali, i cui sovrani trattano i sudditi come schiavi, sino alla “crainte” che Montesquieu riscontrava al suo tempo dominante nell’Impero Ottomano o in Persia (con l’aiuto della tecnica i totalitarismi del Novecento l’hanno poi resa onnipresente). In maniera più realistica, Hobbes la considerava invece caratteristica imprescindibile di ogni Stato, allorché viene esercitata sia nell’ambito della legge o dell’arbitrio sovrano, sia in quello dell’anarchia, dove si trasforma in terrore o in panico.
Secondo un detto anglosassone, un Paese è democratico quando chi viene alla vostra porta di primo mattino è il lattaio e non la polizia politica. Tale regime è quindi definito dell’assenza o della riduzione della paura, che si manifesta anche nel privilegio accordato all’accettazione del diverso rispetto alla sua espulsione. Le democrazie sviluppano così i semi gettati dal cristianesimo. L’episodio evangelico del Buon Samaritano mostra, infatti, come si venga talvolta aiutati più dagli stranieri che dai propri concittadini. In questo senso, il cristianesimo rappresenta il tentativo più elaborato di abbattere le barriere etniche e statali che separano il “noi” dagli “altri”, il cittadino dallo straniero (il cristiano, del resto, si considera “peregrinus”, “straniero” a questo mondo e “pellegrino” o viandante di passaggio in esso).
Ma che succede se chi vi entra in casa non è né il lattaio, né il poliziotto, ma un rapinatore che, oltre a impossessarsi dei vostri beni, attenta anche alla vostra vita? Se vostra figlia viene stuprata a una fermata della metropolitana? La paura non viene allora più percepita come proveniente dal potere statale, ma, al contrario, da una criminalità che le “forze dell’ordine” stentano a contrastare. L’insicurezza rende gli individui e l’opinione pubblica meno razionali, creando uno stato d’animo di allerta o di psicosi collettiva, che fa di ogni erba un fascio, non tiene conto delle esperienze analoghe nel passato e crea dei capri espiatori.
È evidente che se l’esistenza delle persone fosse resa meno precaria, meno esposta agli imprevisti, la loro tendenza a comportamenti ragionevoli si rafforzerebbe spontaneamente. La sicurezza è dunque indispensabile per restringere l’area della paura. Ma quale sicurezza? Quali misure prendere per evitare una militarizzazione della società, una sua chiusura che la esponga a una sorta di malattia del ricambio, che semini il sospetto, che si pieghi a strumentalizzazioni politiche e che delegittimi l’accoglienza dell’altro, vedendovi solo un potenziale nemico?
Remo Bodei
—————————
ACHTUNG, COMMEDIA ALL’ITALIANA di Alessandro Melazzini
«Che accade agli italiani? E cosa ne è del loro fascino?». Simili dubbi serpeggiano da qualche anno tra i media tedeschi. Ma a leggere certe scorate analisi degli ultimi giorni c’è da credere che il nostro Paese appaia ormai agli occhi tedeschi davvero senza più alcuno slancio. Napoli sommersa dai rifiuti, avanzi di fascismo impenitente à la Ciarrapico in Parlamento, spigliate soubrette innalzate a Ministro, tutto il potere all’incomprensibile Berlusconi (quello dell’indimenticata battuta europea sui kapò), Roma che attacca i campi nomadi, Verona con un sindaco leghista che sposta il ritratto di Napolitano per fare spazio all’effige di un capo di Stato straniero: il Papa. «Questa è la vecchia Italia. Ammirata e guardata con stupore. Soprattutto derisa» scuote la testa lo Spiegel «una terra di commedianti e imbroglioni, di amabili birbanti, ingannatori ed eterni bambini». Bambini pericolosi però, come hanno mostrato l’anno scorso i fatti di Duisburg, quando la “Polizei” s’è resa conto che ormai intere zone del territorio tedesco sono in mano alla Camorra, soprattutto a Est. Se fino ad allora la criminalità organizzata proveniente dal Sud veniva osservata come un pittoresco fenomeno esterno, adesso i detective federali hanno fatto ammenda della loro superficialità e prestano molta più attenzione agli avvertimenti dei loro colleghi italiani. Eppure, anziché puntare il dito indiscriminatamente contro il Belpaese, o risfoderare la famigerata copertina dello Spiegel anni Settanta con la pistola sul piatto di pasta, proprio in quel Ferragosto di sangue la società tedesca ha dimostrato di saper scindere perfettamente tra pericolosi elementi criminali e l’onestà dei suoi 600.000 concittadini di origine italiana. Ci ha guadagnato Roberto Saviano, il cui strabiliante Gomorra con un “timing” perfetto è uscito qui in Germania dieci giorni dopo la strage. A visitare i locali italiani poi non risulta che sia venuta meno la passione con cui i tedeschi, dai massimi vertici della politica berlinese alla famigliola di Würzburg, si dedicano alla gastronomia mediterranea. Forse perché, come si scrisse durante la foga dei Mondiali di calcio, «la più grande innovazione italiana è arrivata in Germania ormai vent’anni fa e si chiama: rucola»? Un’accusa, quella dello scadimento nostrano, rinnovata la settimana scorsa dal pubblicista Gustav Seibt sulle pagine della Süddeutsche Zeitung, secondo cui ormai nessuno si fila più la cultura italiana e tutt’al più al Nord giungono solo i vergognosi spettacoli di quei senatori giubilanti a mortadella per la caduta del precedente governo. Sull’indecorosa scena offerta da certi nostri politici difficile obiettare, ma visto l’interesse con cui si traducono Camilleri, Carofiglio e Calasso, si studia Agamben, s’intervista Claudio Magris e al cinema si guarda Mein Bruder ist ein Einzelkind (l’italianissimo Mio fratello è figlio unico di Daniele Lucchetti), è lecito avanzare qualche dubbio sulla totale disfatta della nostra cultura oltralpe. Insomma, l’«estraniazione strisciante tra Italia e Germania» – per usare il titolo di un volume contemporaneamente in uscita presso Il Mulino e la bavarese Oldenbourg Verlag – sta davvero avendo luogo? «Diversamente da Gian Enrico Rusconi» risponde lo storico Hans Woller, curatore dell’opera insieme al collega italiano, «a mio parere le relazioni tra i due paesi sono quelle di una distesa normalità. E sebbene politicamente ci siano state frizioni e allontanamenti, non bisogna dimenticare le ottime relazioni economiche e sociali in corso. Sempre più studenti tedeschi imparano l’italiano, sempre più studenti italiani vengono in Germania. Pensiamo poi a Eco, Muti, Abbado, Renzo Piano: tutti artisti che hanno conquistato celebrità mondiale! Dal primo cappuccino all’ultima grappa l’Italia qui ci accompagna tutto il giorno». Che dire allora degli articoli sulla corruzione, la criminalità e il razzismo di cui si legge in questi giorni sulla stampa tedesca? «Sono tutti problemi europei» risponde Woller, «basti pensare allo scandalo della Siemens o alla criminalità giovanile in Francia. Marchiare a fuoco lo Stivale è sbagliato: tutta l’Europa a questo riguardo è italiana». Secondo Stefan Ulrich, corrispondente da Roma della Süddeutsche Zeitung, occorre distinguere tra politica e società. «Effettivamente in passato tra Italia e Germania c’erano molti più contatti a livello politico. Ai cristiano-democratici tedeschi corrispondeva la DC, il PCI trovava un punto di riferimento nella SPD. C’erano grandi affinità dovute alla comune esperienza di fascismo e nazismo prima, alla ricostruzione democratica poi». Ma oggi il panorama è drasticamente cambiato. «In Germania non esiste un partito come Forza Italia, né un politico come Berlusconi. E la Lega Nord non è paragonabile alla CSU bavarese. Le due classi politiche hanno perso i loro rispettivi punti di riferimento». Detto questo, la fascinazione turistica verso Sud permane ininterrotta. Non a caso Ulrich nel suo divertente Quattro Stagioni, appena uscito in Germania, racconta che uno dei compiti più duri arrivato a Roma è stato quello di contenere lo sciame di connazionali desideroso di fargli visita. «Non sono così vanitoso da pensare che volessero venire tutti a trovare me. Il fatto è che l’Italia è una delle mete turistiche più attraenti del mondo. Quanto alla cultura, anche in Germania film come Gomorra o Il Divo suscitano interesse, l’attività della Scala viene seguita con attenzione e i grandi eventi di Roma e Venezia non passano certo inosservati. Non è possibile affermare che l’Italia sia culturalmente inaridita». Quindi i limoni italiani fioriscono ancora? Non c’è dubbio, eppure sarebbe esiziale, avverte Ulrich, sottovalutare le tensioni a livello politico: «la storia c’insegna che anche quando i popoli si comprendono bene, se la politica crea rigetto si può velocemente andare incontro a situazioni assai conflittuali».
Alessandro Melazzini ( alessandro at melazzini.com)
Pubblicato in EVENTI, INTERVENTI E APPROFONDIMENTI 277 commenti »









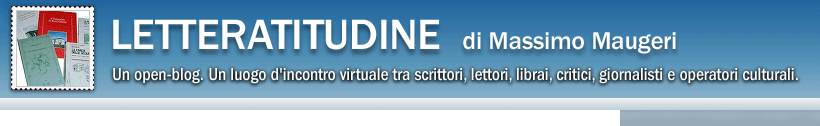
 Nuova puntata delle “recensioni incrociate”.
Nuova puntata delle “recensioni incrociate”. Il titolo di questo post non si riferisce a un romanzo erotico o a un film spinto.
Il titolo di questo post non si riferisce a un romanzo erotico o a un film spinto. Si apre la nuova edizione della
Si apre la nuova edizione della  La letteratura, soprattutto la letteratura recente, ha affrontato più volte il problema dell’anoressia. Un po’ meno quello dell’obesità.
La letteratura, soprattutto la letteratura recente, ha affrontato più volte il problema dell’anoressia. Un po’ meno quello dell’obesità. Questo romanzo parla di un corpo.
Questo romanzo parla di un corpo.













 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI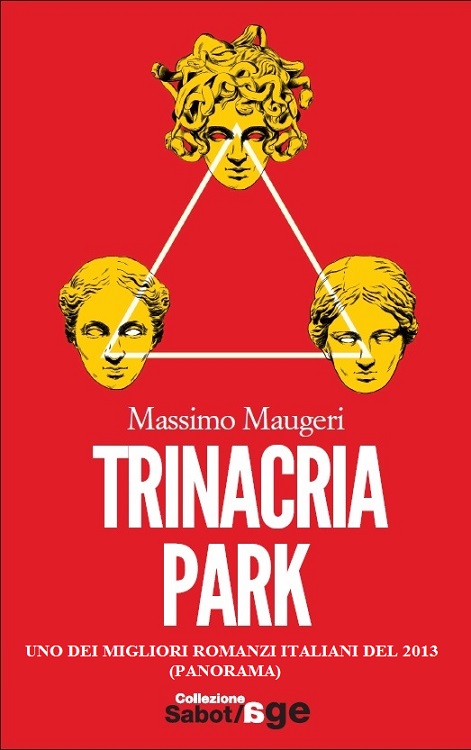
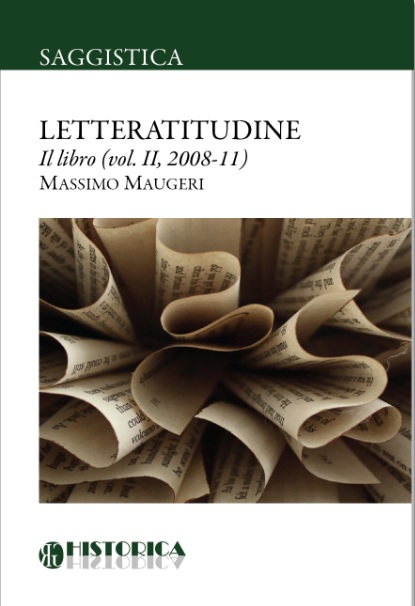


Commenti recenti