
Quando si fallisce nella vita? Può un’aspirazione giovanile non conseguita, condizionare il resto dell’esistenza? La predestinazione è un dato? Sono domande che nascono dalla lettura di Effetto albatro di Fabio Cerretani, un “vecchio” russo fra noi. Tre parti, due “intermezzi”, un epilogo che ci riportano al micragnoso mondo degli scrivani ottocenteschi. Ma il protagonista è un nostro contemporaneo, e gli anni “felici” della sua formazione, sono quelli caldi delle lotte civili e poi assurdi e criminosi dell’assassinio di Aldo Moro. Il protagonista però è avulso da tutto questo, impermeabile alle tensioni e poi alla svagatezza in cui negli anni Ottanta si stemperarono. Come un aratro versoio, la narrazione rivolta i giorni e il tempo nella ricerca della fertilità creativa, unico mezzo per il riscatto sociale di un “predestinato” alla Letteratura. E’ una lettura che stupisce e che scorre veloce alla ricerca di quel respiro, quella realizzazione, che sin dalle prime battute, sappiamo negata, parzialmente negata. Come molti, in quegli anni di scolarizzazione di massa, il protagonista di origini proletarie si ritrova in ambienti “non suoi”, il Classico e l’Università; dibattendosi fra doveri, difficoltà economiche, la meta di un successo o, almeno, di una realizzazione. Uomo di un moderno sottosuolo murato nella sua ostinazione, Genesio Tortolini si confessa cercando nei dati le cause dell’effetto mancato. Una scrittura abile, insolita che rende partecipi offrendoci in Taglia Unica la possibilità di un’autoanalisi, che ognuno può adattare o modificare da sé. Perché il tema del libro è il successo editoriale, come riconoscimento del proprio senso di vita. All’editore Pautassi (oh, potessi!) Tortolini, invia il suo lungo monologo; disincanto, commiserazione, pietà di sé, ironia, rabbia e desiderio impastati in una bella trama giocata sul doppio: Genesio, l’albatro che sta imparando a muoversi sulla terra e Clara Angrisani che come un passero fa mille voli. “La Letteratura però continuava a essere un’abitudine della quale non afferravo le motivazioni profonde, e leggevo nel modo in cui altri fumano: per vizio, per abitudine. Perché non riuscivo a smettere. Comprendevo che spettava alle lettere procurarmi la Gloria, ma capivo anche che era un ben remunerato impiego quello che invece poteva assicurarmi, se non la ricchezza, per lo meno un certo benessere nell’immediato”.
Miriam Ravasio
EFFETTO ALBATRO
di Fabio Cerretani
Robin, 2007 pag. 336, euro 14
- – -
UPLOAD del 29 agosto 2007
Fabio Cerretani, previa autorizzazione del suo editore, mi ha inviato un testo estratto dal suo “Effetto albatro”. Lo pubblico di seguito invitandovi a leggerlo e a commentarlo. (Massimo Maugeri)
- – -
28.
Il dramma del passaggio dalle soglie del successo al rientro nei ranghi non si consumò tutto in una volta, e la patina grigia della sconfitta tornò a discendere su di me un po’ per volta.
Il primo disinganno fu quando, giunto nell’albergo milanese del cui costo era l’Organizzazione a farsi carico, incontrai l’efficiente manager della cultura che mi aveva telefonato la seconda volta:
“Salve, io sono Cinzia Rebaudengo”, mi disse. Era una over fourty bruttina e priva della benché minima attrattiva, alta che mi arrivava a malapena alla spalla, e sì che io tutto sono fuorché un colosso. La dottoressa Rebaudengo era vestita come una bibliotecaria d’altri tempi, che al solo immaginarla intimamente paludata nella lingerie che le avevo cucito addosso mi faceva l’effetto di una caricatura, perché, tanto per farLe capire il tipo mediterraneo, ci sarebbe voluto un reggiseno della seconda e uno slip della sesta.
Insomma, lo so che è antipatico giudicare le donne prima di tutto, se non solo, dal loro aspetto fisico, e infatti questa qui era senza dubbio intelligente, era persona competente e lavoratrice e aveva letto molti libri, era laureata e tutto quello che vuoLe, però cosa dire, certe pessime abitudini maschili, anzi maschiliste, è difficile perderle, e devo ammettere che ci rimasi male. Solo la voce era rimasta quella che al telefono mi aveva spinto a sognare, e questo doveva dipendere dal fatto che nell’immagine ideale che di lei mi ero composto nella mente, il timbro efficientista e leggermente sadomaso da donna dominante era l’unico dato acquisito in maniera
definitiva.
“Lei?”, feci, e dovetti rimanere con la bocca un po’ spalancata, in una espressione facciale in netto contrasto con quella che dovrebbe essere l’espressione acuta e profonda di qualcuno che ambisca fregiarsi del titolo di scrittore; dovevo piuttosto sembrare una recluta del Reggimento Granatieri, uno spilungone cresciuto troppo in fretta fino ai suoi quasi due metri, con un corpaccione in cui gli impulsi in partenza dal cervello giungevano con molta lentezza alle estreme regioni dell’Impero, come messaggeri su strade poco praticabili e irte di pericoli. L’impulso destinato al mio braccio sinistro con un dispaccio che gli intimava di sollevarsi per stringere la mano che la donna già da un po’ mi tendeva dovette perdersi per strada, o essere assalito e trucidato dai briganti, e allora fu la Rebaudengo stessa, da donna energica e decisionista, ad afferrarmi la mano che pendeva inerte lungo il fianco e a stringerla in una di quelle morse che nelle terre settentrionali nemmeno le femmine ti risparmiano, e che a noi amanti prossimi al disarmo evoca a volte con un brivido l’immagine di ben altre strette possibili.
“Com’è andato il viaggio, tutto bene?”, mi chiese.
“Come può andare un viaggio in treno in seconda classe”, risposi con quel mio spirito poco salottiero, in un modo che voleva essere ironico e mondano e che invece inspiegabilmente suonò burbero e scontroso, tanto che lei lo prese per un rimprovero:
“Capisco. Ma purtroppo i fondi ricevuti dall’istituto bancario che patrocina la manifestazione non sono stati sufficienti per offrire l’aereo…”
“Per carità, per carità, non volevo dire questo. Anzi, è già tanto che… questo albergo – mi confusi, lasciando vagare lo sguardo in giro per l’alberghino sciccoso e dall’aria very expensive nel quale sarei stato ospitato gratuitamente per due notti – e anche a prescindere da questo, l’occasione è tale che…”
Vidi che Cinzia Rebaudengo annuiva pietosamente, guardandomi come i componenti della spedizione sul ghiacciaio avrebbero guardato l’Uomo di Similaun nel caso in cui questi, invece che farsi trovare ibernato congelato e perfettamente conservato, si fosse fatto loro incontro cercando di stabilire un dialogo per spiegare che cosa esattamente gli era accaduto migliaia di anni avanti.
“Bene – concluse quando i miei farfugliamenti le furono sembrati sufficienti per ristabilire un corretto funzionamento della dinamica incube/succube – per stasera la lasciamo libero.
Si riposi, che domani è il gran giorno. Ci vediamo qui nella hall alle dieci per l’intervista.”
Avvertii un brivido lungo la schiena, l’ennesimo di quel periodo, tanto che non ci facevo quasi più caso e tutto quello che riuscivo a fare era di attendere che si esaurisse disperdendosi nella regione lombo-sacrale come l’Okavango si perde negli acquitrini del proprio delta, mentre la goffaggine appena esibita mi sconsigliava di avventurarmi nella richiesta di una conferma, ufficiosa ma di fonte ufficiale, di quello che a quel punto mi sembrava ormai certo.
Libero, poi, non lo ero affatto, perché alle undici e mezza avevo appuntamento con Marcello Mascambruno. Il Piccolo Editore Onesto mi aveva cercato un paio di settimane avanti, e la sua telefonata era stato uno dei segnali che più mi avevano persuaso dell’imminenza del Successo, l’altra essendo la volta in cui, preso dall’ansia di non avere ancora nessuna certezza, mi ero provato a fare lo gnorri con quelli della reception dell’albergo: avevo chiamato con una scusa qualsiasi e mi ero qualificato, senza nome e cognome, come il partecipante al Premio Diogene Letterario, quello invitato alla premiazione, e allorché loro avevano fatto mente locale
senza nemmeno chiedermi “Quale, scusi, perché qui ne avremmo più d’uno…”, avevo acquisito la quasi certezza di essere il solo, quindi il vincitore. Ma la certezza, nei limiti ovviamente in cui uno come me può nutrire delle certezze che non siano suffragate da fatti conclamati, me l’aveva però fornita la telefonata del piccolo editore onesto. Il quale si era appunto presentato come tale, calcando il tono della voce sull’aggettivo onesto, come se una caratteristica che dovevano essere semmai gli altri a riconoscerti e che comunque almeno in teoria e salvo prova contraria tutti dovrebbero possedere fosse invece una sua peculiarità esclusiva, e mi aveva parlato in un settentrionale convulso e quasi incalzato dalla fretta di dirmi tutto quello che aveva da dirmi prima che la durata della telefonata interurbana si traducesse in un costo mal tollerabile dal bilancio di un editore delle sue dimensioni:
“Le dicevo che io sono una persona onesta, nel senso che non sono uno di quei… badilanti dell’editoria che si presentano come editori e che poi invece sono poco più che tipografi, disonesti anche come tipografi oltretutto, viste le cifre che riescono a estorcere a degli sprovveduti; quei cosiddetti editori, per capirci, che fanno stampare mille, duemila al limite anche tre o quattromila copie di qualsiasi romanzo venga loro sottoposto, e poi…”
“Ho capito quello che vuole dire, conosco il genere, e mi fa piacere che lei non appartenga a quella categoria, questo le risparmierà di sentirsi riappendere la cornetta del telefono in faccia. Piuttosto, mi faccia capire una cosa: lei come sa di me e del fatto che sono… ehm… che partecipo al Diogene Letterario?”
Mascambruno aveva fatto una risatina chioccia e furbesca, l’equivalente di quello che, se si fosse trattato di un dialogo a quattr’occhi, sarebbe stata una strizzatina d’occhio e magari anche un colpetto di gomito fra le costole:
“Lei è molto più di un partecipante, e lo sa benissimo. Ma sia chiaro, fa bene a mantenere il riserbo su una notizia del genere, che poi è quello che gli organizzatori del Premio si aspettano, a questo punto delle cose è meglio non rischiare, aspetti qualche altro giorno e potrà…”
“Ecco, appunto – lo avevo interrotto di nuovo, che ormai mi sembrava di essere io a tenere il coltello dalla parte del manico nei miei rapporti con gli editori – il riserbo: lei, allora, come ha fatto a…?”
“Ah, niente di poco pulito, sia chiaro; nessun intrallazzo. È che a Milano nell’ambiente tutti mi conoscono come una persona onesta, mi stimano anche se sono solo il proprietario di una piccola casa editrice di qualità, perché comunque sono pu-li-to, ed è una pulizia che io metto in tutte le cose che faccio e che…”
“Quindi?”
“Quindi…: un’indiscrezione – ammise, quasi a malincuore. – Ho delle conoscenze, all’interno del comitato e anche della rivista organizzatrice. Cosa vuole… viviamo in un mondo imperfetto”, concluse, lasciandomi il sospetto che, nonostante tutta la sua onestà, la nuovamente constatata imperfezione del mondo e dei suoi collaudati meccanismi offrisse a Marcello Mascambruno una comoda scappatoia per garantire alla sua piccola casa editrice di qualità la competitività sul mercato.
Un editore che mi telefona, che mi cerca! Certo non era Lei, dottor Pautasso, e non avrebbe nemmeno potuto esserlo, perché immagino che Lei più che scrivere o telefonare ami materializzarsi, andare per Annunciazioni o apparizioni soprannaturali; però era ugualmente un buon inizio, e il segnale di un’inversione di tendenza epocale: per questo non me l’ero sentita di dirgli né sì né no, potevo trovare di meglio ma potevo anche non trovare nient’altro e allora per una volta mi ero comportato saggiamente, prendendo tempo e proponendo una soluzione interlocutoria: sarei stato a Milano dalla sera avanti a quella della premiazione,
e allora avremmo potuto incontrarci e parlare con tutto comodo. Meglio non in albergo, però, perché al riguardo il regolamento era chiaro: colui che avesse pubblicato l’opera premiata prima della proclamazione del vincitore, o ne avesse ceduto i diritti, o anche solo ne avesse parlato con un editore o con persona da questi discendente o a questi ascendente entro i limiti del quarto grado di parentela, sarebbe stato eliminato dalla competizione, a nulla valendo la considerazione che l’editore in questione fosse piccolo e onesto.
E così, mentre i due che sarebbero risultati vincitori ex-aequo andavano a cena da Biffi con i direttori editoriali rispettivamente della Magnusson EdiItalia e della Moltricco & Bignola e poi nelle altrettanto rispettive sedi di rappresentanza in via Montenapoleone e via Solferino per le firme dei contratti di edizione, io mi apprestavo a inoltrarmi nelle vie più malfamate e postribolari della vecchia Milano, perché non solo l’ora ma anche il luogo che Mascambruno aveva scelto per l’appuntamento era quasi da cospiratori: alle 23,30 – chissà perché poi non aveva fatto cifra tonda, scegliendo di incontrarmi a mezzanotte in punto… – in un vicolo oscuro che per essere sicuro di trovarlo mi ero dovuto fotocopiare la relativa pagina della Guida Città della Telecom con la via evidenziata in arancione, e dall’albergo prendere un taxi il cui autista, dopo che gli avevo detto dove volevo che mi portasse, mi aveva guardato con uno sguardo lascivo dicendomi che ne sapeva lui di posti migliori di quello: “Roba dell’Est – mi fece l’occhiolino – carne giovane… anche vergini…”, e devo ammettere che per un paio di istanti l’idea di una vergine dell’est europeo mi aveva anche stuzzicato l’appetito, e se non si fosse trattato del fatto che ancora troppo recente era la delusione che avevo patito con la Rebaudengo, mi sarei fidato di più delle parole del tassista e delle mie suggestioni erotiche senza approdo e avrei accettato l’invito, mandando a farsi fottere il piccolo editore, la sua piccola casa editrice di qualità, la sua onestà e le sue arie da cospiratore, e con tutto questo ben poco per me sarebbe cambiato.
Invece quella sera il sogno di Gloria doveva essere ancora ben vivo in me, perché declinai gentilmente l’invito dicendo che un’altra volta avrei approfittato senz’altro della sua esperienza ma che per quella sera, dissi misteriosamente, c’era prima un’altra faccenda che dovevo sistemare, che era già troppo tempo che andava avanti e dovevo proprio darci un taglio. Il tassista meneghino parve favorevolmente impressionato: annuì con la testa senza chiedere nient’altro, e per tutto il resto del viaggio continuò a guardarmi di tanto in tanto nello specchietto retrovisore, come per imprimersi bene nella mente la fisionomia dell’autore del delitto; quando
mi lasciò nel vicolo male illuminato non volle né la mancia né il supplemento per l’ora notturna.
Anche io sembravo entrato nel personaggio, perché non avvertii nemmeno poi tanto quella paura che in altre occasioni, a sapermi solo, indifeso e nelle vesti di vittima ideale di una rapina, un omicidio o financo dell’estremo oltraggio di uno stupro, mi avrebbe letteralmente paralizzato, tanto che perfino quando dal buio avvertii provenire quella voce, quella roca domanda:
“È solo?” sobbalzai appena, mi voltai con naturalezza e osservai senza punto indietreggiare l’enorme massa scura che si staccava dal buio per venirmi incontro:
“Si è assicurato di non essere pedinato?”, chiese.
Solo quando mi decisi a fare sì con la testa, l’editore Marcello Mascambruno mi tese la mano per il riconoscimento ufficiale: il piccolo editore era un uomo enorme, due metri almeno per un altro di larghezza, ma la sua stretta di mano, dopo la morsa inflittami da Cinzia Rebaudengo, risultò singolarmente molliccia e femminea, e prima che mi immergessi totalmente in un fitto dialogo a base di diritti d’autore e copie da distribuire, mi attraversò la mente il sospetto che magari la donna manager, a dispetto della sua bruttezza, poteva avere delle qualità nascoste.
“È questa la possibilità di parlare con tutto comodo? – chiesi guardandomi intorno, con l’intenzione di fare dell’ironia per mettere l’omone a suo agio. – Non c’è nemmeno un bar aperto…”
“Non ho parlato io di comodità, è stato lei. Possiamo parlare qui, tanto è per pochi minuti, trattenersi di più sarebbe imprudente. E poi lei dovrebbe saperlo: scrivere è fatica, tormento interiore, spesso disagio materiale…”
“Guardi, scrivere non è niente. Sono arrivato a credere che siano sufficienti un po’ di pazienza e niente di meglio da fare – esagerai, e subito dopo mi corressi – oltre a un po’ di inclinazione, ovviamente. Il problema vero, mi creda, è riuscire a pubblicare.”
“Coraggio, lei è quasi alla fine del suo Calvario. Ci sono qua io”, mi fece, poggiandomi una mano sulla spalla. Di persona l’eloquio di Mascambruno, non più incalzato dai costi esorbitanti delle interurbane, fluiva calmo e rilassato, planando fino a me da quelle colossali altitudini come un messaggio di speranza.
“Che cosa ha da offrirmi?”, gli chiesi, senza l’ostilità di quella volta con Bellentani, il quale a ben vedere non aveva mai parlato di onestà, quindi almeno in questo era stato onesto.
Mascambruno non rispose subito. Nonostante la stagione primaverile in corso, a Milano era ancora piuttosto fresco, e in quei bassifondi l’umidità sembrava addensarsi come se vi giungesse seguendo una corsia preferenziale; l’editore doveva saperlo in anticipo, di poter contare su un contesto nebbioso degno di un vecchio film con Christopher Lee, e mentre io rabbrividivo nel giacchino di finta renna, lui era ben coperto da un impermeabile cerato di tipo inglese con tanto
di mantello corto come quello di Sherlock Holmes. Proprio in quel punto, nell’intersezione tra impermeabile e mantella, frugò a lungo come se cercasse qualcosa in una tasca così segreta che sarebbe rimasta tale anche ai segugi del Premio Diogene Letterario che lo avessero eventualmente intercettato e perquisito: “Tenga”, mi disse alla fine di quel lungo lavorio. Presi le carte che mi tendeva e le esaminai spostandomi alla luce di un lampione: erano un assegno della Banca Popolare di Milano di cinquecento euro e un contratto per l’edizione de “La circolare” in duemila copie iniziali.
“Non è molto, mi rendo perfettamente conto – disse. – Ma tenga presente che io non sono Arnoldo Mondadori. La cifra potrebbe addirittura sembrare offensiva, ma spero serva per dimostrarle la mia onestà, e il fatto che io non voglio ingannarla. Insomma, è il gesto che conta…”
“Per compiere un gesto simbolico immagino che un milione delle vecchie lire sia sufficiente”, dissi.
Cominciai a leggere le varie clausole alla luce del lampione, solo che, colto di sorpresa, non riuscivo a concentrarmi sui pro e contro e le eventuali contromisure da inserire, e ciò non solo per colpa dell’oscurità; cercavo soprattutto il punto in cui si dichiarava quanto e in che modo io avrei dovuto pagare all’editore pirata, perché senza dubbio di questo si trattava, e al vedermi curvo in quel modo su un fascicolo un ubriaco di passaggio si fermò dietro di me, mi appoggiò il mento su una spalla e cominciò a leggere anche lui. “Fila via”, gli disse Mascambruno quasi con tenerezza, e l’ubriaco si dissolse nella nebbia.
Insomma, dottore, una serata di quelle che si ricordano, di quelle per le quali da ragazzo mi sarei esaltato: ero solo, di notte, immerso nella nebbia della grande città del nord, in procinto di firmare il mio primo contratto con un editore galantuomo anche se misconosciuto, e alla vigilia della più importante affermazione della mia vita di sconfitto.
Eppure avvertivo che l’atmosfera non era quella che avrebbe dovuto essere, e questo è perfettamente comprensibile viste le modalità, dirà Lei; ma c’era dell’altro, forse qualche reminiscenza letteraria che prendeva corpo nel vicolo buio per trasformarlo in una cava di pietra abbandonata, nella quale io ero giunto seguendo senza ribellarmi i miei due carnefici:
“Come un cane” mormorai allora, citando un po’ a sproposito le ultime parole di Joseph K. Forse quel contratto non mi sembrava una conclusione degna del Sogno, ma solo un boccone di scarto datomi in pasto per pietà, per levarmi di torno, e mi parve che se lo avessi firmato lì, in quel modo, magari appoggiandomi sulla schiena di Mascambruno – ma come?, che era alto due metri – o sul tettino umido di una vettura in sosta… come dire?… la vergogna, proprio come a Joseph K., mi sarebbe sopravvissuta.
Sfumature di poco conto, che il piccolo editore onesto non poteva cogliere: “Come dice?”, mi chiese.
“No, niente. Dicevo che non mi sembra questo né il luogo né il modo. Non è così che ho immaginato la firma di un contratto con un editore” gli dissi, restituendogli l’assegno e il contratto che l’aria umida e misty della notte avevano già accartocciato, e ricordo che pensai che era davvero strano che anche per quanto riguardava l’editoria, quindi in definitiva i libri, tutto dovesse dipendere da imprenditori che vivevano e operavano in una città il cui clima gonfiava, ispessiva, deformava e imbruttiva la carta.
“Siamo un po’ idealisti e romantici, eh?”, mi rispose, ma non nel tono di un rimprovero, cominciando a tastarsi addosso in cerca della tasca segreta dalla quale li aveva estratti poco prima.
“Un po’, sì. Domani, lo prometto – dissi, come una vergine timorosa ma calcolatrice, che resista solo nella speranza di cedere a un miglior offerente l’esclusiva della deflorazione – dopo la premiazione. Lei verrà alla cena?”
“Certo. Sono un editore, e anche se piccolo, la mia fama di onestà è tale…”
“D’accordo-d’accordo-d’accordo – tagliai corto – domani a cena, allora, o anche dopo, tanto quanto potrà durare? Avremo modo di parlarne e, se del caso, trovare un accordo. Okay?”
“O-kay! Mi sembra giusto. E si ricordi: anche se non dovesse vincere, io sono ugualmente interessato al suo romanzo”, mi disse allontanandosi.
Mi toccai in basso, ma senza precipitazione, per dare l’impressione che fosse un gesto della stessa casualità involontaria con cui a volte si controllano il portafoglio o l’orologio o le altre cose preziose che si portano sempre con sé. Il gesto, del resto, non ebbe nessuna efficacia scaramantica perché la mattina seguente, quando dopo una notte fitta di incubi alle dieci in punto feci il mio ingresso nella hall dell’albergo esalando gli ultimi ruttini di assestamento gastrico conseguenza di una colazione a buffet nella quale avevo assaggiato perfino il porridge, vidi che Cinzia Rebaudengo sedeva già in un circolo di poltrone e divani, attorniata da una decina scarsa di persone, che immaginai giornalisti convenuti per una prima informale intervista al vincitore. Ma mentre timidamente cominciavo a girare intorno al consesso con volute dal diametro sempre più ridotto, in attesa che lei notasse che il vincitore era lì e lo invitasse a prendere posto tra di loro, mi resi conto che non era affatto
lei il centro dell’animata riunione, perché l’eminenza grigia… o meglio, il maestro di cerimonie sembrava piuttosto un’anziana signora con i capelli cotonati e virati nei toni di un tenue violetto da fata turchina, che osservava i vari interlocutori come se fossero tutti figli suoi, mentre disputavano animatamente su qualche argomento che doveva prenderli molto. Fu proprio lei che, pur senza conoscermi, a un certo punto dovette accorgersi di quello strano individuo che continuava a girare in tondo osservandoli con la coda dell’occhio, e che non poteva che essere o un emissario di un Premio concorrente, venuto a spiare l’informale cerimoniale per poi riproporlo pari pari in chissà quale oscura manifestazione del centro-sud patrocinata e sponsorizzata da qualche cassa rurale e artigiana di infimo rango, oppure quello degli invitati che ancora mancava all’appello. Per cui, dopo una breve consultazione con la Cinzia Rebaudengo, che interpellata al riguardo ebbe la bontà di riconoscermi quasi subito, la fata turchina mi fece con la mano un cenno regale e nello stesso tempo sbarazzino perché mi appressassi a lei:
“Sono Marisa Botto Ramella di Sanvigognano…”, mi confidò, quasi per spiegare il perché di tanta magnificenza, e per un attimo temetti che volesse proseguire illustrandomi la sua esatta collocazione nell’ambito della genealogia di famiglia; ovviamente rimase seduta, fatto decisamente scusabile in una signora per di più di quella età, ma che mi costrinse a interpretare il resto della conversazione con la schiena dolorosamente curva nella sua direzione, nell’atteggiamento del più servile dei camerieri o dei portaborse, per di più mostrando chiaramente di non sapere se a quel punto, udito nome e patronimico e feudo di provenienza si trattasse di genuflettersi o cosa.
“Ricorda? Ci siamo sentiti al telefono; fu nel febbraio scorso, credo”, e allora sì, allora compresi che era la signora che mi aveva chiamato la prima volta, per dirmi che ero rientrato tra i finalisti. “Ha fatto buon viaggio?”, si informò con sollecitudine e come se davvero gliene importasse qualcosa, e io, che avvertivo ancora vivo l’imbarazzo per la figuraccia del giorno avanti:
“Ottimo, – risposi – molto, molto meglio che in aereo”, intendendo in quel modo rassicurarla sul fatto che proprio non importava che l’Istituto Bancario più trendy della città nonché finanziatore della manifestazione avesse lesinato sulle trasferte degli invitati di seconda fascia.
“Molto bene. E la notte: trascorsa bene?”
“Meravigliosamente bene”, risposi, abbassando lo sguardo nel timore che le occhiaie da panda sconfessassero le mie asserzioni.
“E ha già preso la prima colazione?”
“Vengo ora dal buffet”, risposi, senza riuscire a trattenere la conferma fornita da un conclusivo singulto. Solo una volta esaurita l’intera rassegna di schermaglie di cortesia, la fata turchina si decise ad assestarmi la botta: “Aspetti, che le presento i vincitori.”
Io vacillai: “I vincitori?”, dissi, e lei interpretò male le ragioni del mio turbamento, sul quale per ora eviterei di soffermarmi perché tanto Lei è perfettamente in grado di immaginare quale e quanto possa essere stato:
“Certo, quest’anno c’è un ex-aequo, non lo sapeva? – trillò, come se quella trovata dei due vincitori che non scontentava nessuno tranne me fosse venuta in mente a lei personalmente.
– Allora, guardi: la signora – mi sussurrò, e con gli occhi mi indicò una giovane donna vagamente somigliante a Mariangela come appare nei film di Fantozzi – è un’assistente universitaria in odore di cattedra, per così dire, che ha partecipato e vinto con un’opera quasi sperimentale che innova fortemente il linguaggio. L’altro – e, anche stavolta senza parere, mi fece capire che si riferiva al trentacinquenne piuttosto distinto che ascoltava in silenzio la discussione in corso – è un giornalista free-lance di Milano, che ha scritto un romanzo dal forte impegno civile.”
Logico, sembrava sottintendere, che a lei che non ha scritto né opere di forte impegno politico e sociale né innovatrici sul piano del linguaggio, e che per di più come lavoro fa l’ispettore dell’Agenzia delle Reintroduzioni Contabili, sia toccata quella segnalazione della Giuria che, spero vorrà riconoscerlo, con un curriculum come il suo è anche troppo.
Io non glielo avevo detto che tipo di lavoro facessi, ma dovevano averlo scoperto ugualmente, dovevano avere spie e confidenti ovunque, e adesso si comportavano di conseguenza, tanto che la gentildonna non ritenne nemmeno opportuno interrompere la disputa in corso solo per procedere a delle regolari presentazioni: “Lasciamoli parlare – disse, con un gesto della mano come se scacciasse una mosca – tanto nel corso della giornata avrà più di una occasione per uno scambio di vedute. L’altro, infine – e mi indicò un quarantenne circa, piuttosto grasso e con un viso seminascosto da barba e baffi – è Mantellassi, un critico famoso che ha fatto parte della Giuria ed è qui stamani appunto in sua rappresentanza.”
Tra i membri della giuria, pensai, doveva essere il meno importante, se oltre che la cerimonia di premiazione e la cena che sarebbe seguita gli era toccato sciropparsi anche quell’incontro informale al mattino, nel quale stava sfogando contro il giornalista free-lance la rabbia che non poteva sfogare contro gli altri membri della giuria, contestando la mancanza di non so bene quale requisito di forma al romanzo che pure aveva vinto, e non mandando indenne neppure l’opera dell’assistente universitaria da una quasi complementare carenza sul piano del contenuto. Sembrava indiavolato contro i due ex-aequo, i quali da veri marpioni navigati nel giornalismo l’uno e nell’ambiente universitario l’altra, mi davano una lezione di vita nonostante fossero entrambi più giovani di me di dieci anni almeno, annuendo volonterosamente e incassando con il sorriso sulle labbra laddove io avrei morso, inveito e dilaniato. Quando infine la nobildonna di Sanvigognano lo interruppe per dirgli chi ero, Mantellassi mi tese la mano e la depose dentro la mia come se invece che stringerla si trattasse di baciarla, e non mi guardò nemmeno in viso.
“Ma venga, si accomodi qui”, mi fece la Botto Ramella, colpendo con un buffetto l’esiguo rettangolo di divano che residuava tra il ponderoso didietro della giornalista che prendeva appunti frenetici e le di lei scheletrite chiappe.
“Allora, è contento?”, mi chiese, quando mi fui sistemato.
“Di cosa, scusi?”
“Ma… di essere qui!”, mi fece, meravigliandosi di genuina meraviglia, e lì per lì, già alle prese con i miei meccanismi interiori di elaborazione della sconfitta, non compresi nemmeno se si riferisse all’essere comunque rientrato nell’elite di quella edizione del Diogene Letterario oppure semplicemente – ma meno verosimilmente – all’essere seduto tra l’alfa e l’omega in fatto di culi femminili, e forse fu per questo che la bassezza delle mie origini si fece sentire in maniera greve e inopportuna:
“Se devo essere sincero, io pensavo di aver vinto…”, le sparai a bruciapelo, e vidi subito che quella doveva essere la prima esperienza che la signora aveva di fenomeni paranormali come la spontaneità e la franchezza.
“Vinto? Noooo… oh mio Dio, noooo – mi fece, battendosi entrambe le mani sulle guance, inorridita e insieme divertita da quella mia assurda pretesa. – Ma è una fissazione la sua! Ma davvero non capisce l’importanza di una segnalazione al Premio Diogene Letterario? Gente come la Tandurro e la Chiavancini ottennero un piazzamento pari al suo e non se ne lamentarono mica! E poi, guardi che sui giornali comparirà anche il suo nome!”
“…Sai che novità, comparire sui giornali!” risposi, scrollando le spalle in un modo che persuase la fata turchina del fatto che con me non c’era niente da fare, che piuttosto che sprecare una prestigiosa segnalazione per un buzzurro irriconoscente come me molto meglio sarebbe stato segnalare quel torinese così compitino e dai modi di una squisitezza quasi sabauda, che era arrivato quarto di poco, in fondo non lo stava dicendo anche Mantellassi che le Lettere sono anche Forma? Magari era vero che ignorava i congiuntivi e che scriveva accelerare con due elle, però anche a basarsi unicamente sulle opere ecco che cosa succedeva, che un cafone
quasi meridionale si piazzava praticamente terzo in una manifestazione importante come il Diogene Letterario, rischiando di venire proiettato nella scena letteraria nazionale e di inquinarla in maniera forse irrimediabile.










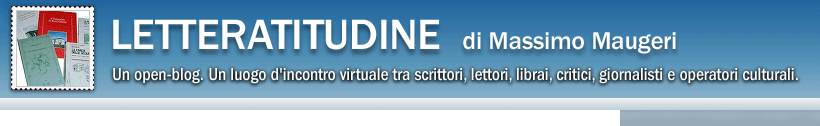
 Un altro grande autore della nostra letteratura ci ha appena lasciato. Noi di Letteratitudine vogliamo ricordarlo partendo proprio dai suoi esordi letterari.
Un altro grande autore della nostra letteratura ci ha appena lasciato. Noi di Letteratitudine vogliamo ricordarlo partendo proprio dai suoi esordi letterari. 






 “Si può dire che la regia cinematografica consiste nel trasformare le visioni, le idee e i sogni, le stesse speranze, in immagini capaci di trasmettere poi questi sentimenti agli spettatori nel modo più efficace possibile. Si crea una sorta di veicolo: questa lunga striscia di pellicola che, tramite un complesso di macchine, trasmette sogni personali.”
“Si può dire che la regia cinematografica consiste nel trasformare le visioni, le idee e i sogni, le stesse speranze, in immagini capaci di trasmettere poi questi sentimenti agli spettatori nel modo più efficace possibile. Si crea una sorta di veicolo: questa lunga striscia di pellicola che, tramite un complesso di macchine, trasmette sogni personali.” 













 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI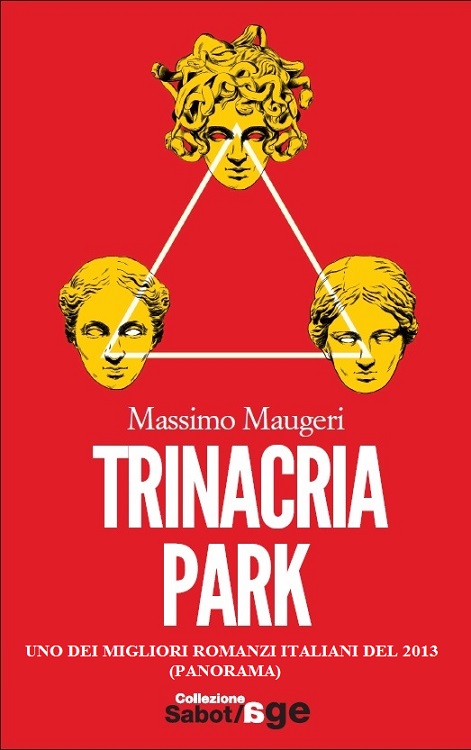
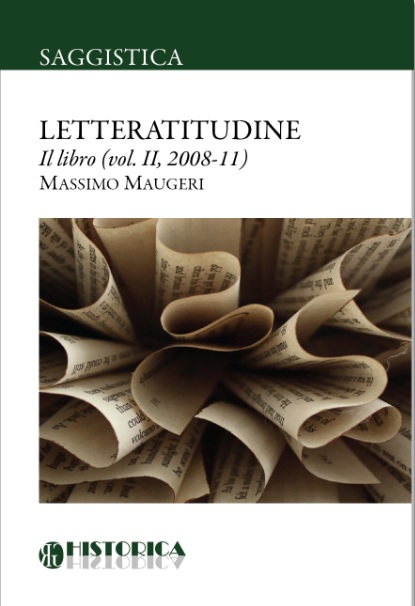


Commenti recenti