martedì, 17 luglio 2007
PORTARE IL PANE A CASA (di Dora Albanese)
In Italia tra gli addetti ai lavori si dice che uno scrittore è giovane fino all’età di cinquant’anni. Di conseguenza gli under quaranta si possono considerare giovanissimi. E gli under trenta dei veri e propri poppanti delle lettere.
Apro una nuova rubrica qui a Letteratitudine dedicandola proprio agli under trenta della scrittura; a coloro che, in così giovane età, cominciano a muovere i primi passi a livello letterario-editoriale.
La rubrica si intitola Giovani scrittori crescono (selezione under trenta) e ospiterà racconti, o stralci di racconti, o brani di giovanissimi regolarmente pubblicati – o in via di pubblicazione – per i tipi di editori grandi, medi e piccoli.
Inauguro la rubrica presentandovi il bel racconto Portare il pane a casa della ventiduenne Dora Albanese (nella foto). Il racconto farà parte di una raccolta di autori vari che sarà pubblicata da Coniglio editore.
Dora Albanese è nata a Matera nel 1985. Studia lettere moderne e pubblica racconti su giornali e riviste. Vive a Roma.
PORTARE IL PANE A CASA
di Dora Albanese
.
Sono ancora a letto, Vita e Michele, rannicchiati tra le lenzuola, anche se è mattina tardi. I fili di luce si poggiano proprio sul lato destro del loro volto, e sembra non diano alcun fastidio, perché non c’è ribellione – né agitazione contro quel calore.
Vita è sveglia già da un po’, ma resta ferma, e a tratti apre gli occhi e guarda Michele. Lo guarda come si guarda, nei film, la persona amata: con lo stesso amore e la stessa passione – ed è pronta di nuovo a essere sua senza pretese.
Sono le otto di mattina e Michele dovrebbe già essere a lavoro; invece dorme ancora, e Vita non vuole svegliarlo. Decide di tenerlo al suo fianco, prigioniero tra le lenzuola – lui che non sarà mai suo fino in fondo. Adesso Michele stringe la mano destra – “forse sta sognando”, pensa Vita – e nella stretta prende anche un po’ di pelle del seno, perché è li che ha fermato la mano, da molte ore ormai, su di lei, e mugugna un po’ quando Vita, a bassa voce, cerca di svegliarlo; poi nasconde infastidito il volto sotto la mano, lasciando scivolare i raggi di luce sulle lenzuola, che ora s’illuminano. Rafforza la presa, e si aggancia a Vita, come avesse un uncino al posto delle dita – e lei resta ferma con gli occhi spalancati, tra il bianco delle lenzuola.
Vita adesso pensa che sarebbe bello avere accanto quel profilo maschile – sempre lo stesso – per l’intera vita, ed essere la sua confidente, l’amica intima del suo corpo; ma un po’ le fanno paura questi pensieri a cuore aperto: i pensieri del mattino, quelli più veri e più bisognosi d’ascolto, figli dei sogni e dei turbamenti notturni – quelli che non si possono ignorare.
Sono i pensieri che scendono dall’Olimpo, i pensieri del mattino; custoditi dagli Dèi durante il buio; e quando scendono in noi, sono carichi di magia, ed è vero, non si possono ignorare. Poi, con l’andare del giorno, si allontanano, e si smentiscono, ma poi tornano limpidi all’alba, o all’imbrunire, quando le anime raggiungono di nuovo l’Olimpo e fanno il resoconto della giornata, affidando ai custodi del sonno i desideri più veri e irrealizzabili.
Vita si allunga un poco sotto le lenzuola, dopo aver riflettuto a lungo, e bacia la mano di Michele, che ancora dorme.
Lo guarda da vicino e, di nuovo, lo bacia – le tempie, il volto, le labbra secche di sonno e gli occhi che si muovono un poco. “Chissà se in quel movimento di palpebre ci sono anch’io… chissà…” pensa senza parlare, sfiorando con le labbra l’orecchio destro di Michele che, solleticato, sposta un po’ la testa.
Vita decide di alzarsi. E’ ormai giorno, e non vuole dar fastidio a Michele che dorme. Deve iniziare a organizzare la giornata e decidere quante visite a domicilio sarà costretta a fare. Scosta le lenzuola e si infila le babbucce sedendosi al bordo del letto – e dà, senza pensarci, le spalle a Michele, e non si accorge di quegli occhi quasi aperti che vogliono giocare. Distende le braccia verso il soffitto e prova sollievo a raddrizzare il corpo un poco aggrinzito dalla notte, e si lascia andare a qualche smorfia mattutina del viso, fatta contro il muro, di nascosto – perché il volto del mattino, per chi si ama solo di notte, può rendere imbarazzante il risveglio.
Michele la guarda dallo specchio e sorride di fronte a quell’accortezza, e subito la blocca, mentre Vita sta per alzarsi, e le salta addosso – la solletica e la butta giù, sotto di lui, sul letto ancora caldo.
Le voci dei bambini che vanno a scuola stanno riscaldando la giornata.
Anche lui dovrebbe andare, uscire e prendersi in mano questa nuova mattinata, invece resta a letto un po’ stordito e un po’ contento di essersi svegliato in un letto a due piazze.
“Ma cosa fai? Stavi dormendo poco fa. Che spavento” dice Vita, sorridente.
“E adesso sono sveglio. Ero già sveglio da un po’, ma mi andava di stare con gli occhi chiusi accanto a te”.
“E cosa penseranno di te i tuoi pazienti? Lo sai che devi aprire lo studio?”
“Penseranno che non sono un medico puntuale, questo penseranno. Ma sta tranquilla, esiste il perdono. Buongiorno Vita!”
“Buongiorno a te” risponde, ma subito pensa: “Perché non mi ha chiamato amore? Sarebbe stato bello” e afferra una ciocca di capelli tra le mani.
Vita è una donna di trentacinque anni, non molto alta, ma bella. Ha negli occhi il colore vivo dei campi verdi lucani, e il rosso dei papaveri tra i capelli, una piccola cicatrice sul collo, il ricordo di una brutta caduta dalle scale, quando era piccola, nella casa di famiglia in montagna, in un piccolo paesino vicino Matera.
Michele, invece, è alto e moro: moro come le olive nere seccate al sole, e ha gli occhi grigi come il pelo dei gatti randagi.
“Sei in piedi da tanto” dice Michele, sornione, “che hai fatto mentre io dormivo?”
“Ti ho guardato” risponde Vita, di nuovo seduta sul bordo del letto.
“Dai!” risponde Michele, e si fa una risata, nascondendosi sotto le coperte. “E perché? Perché mi hai guardato?”
“Non posso guardarti?”
“Ma certo che puoi” e sbuca fuori con i capelli scomposti, come un bambino dispettoso. “E’ che non sono abituato a tutte queste attenzioni…”.
“Sì, tu le donne le usi. Che stupida sono, a darti ancora retta”.
“Diventi rossa quando ti arrabbi. Dopotutto… dopotutto sono il tuo futuro marito, no?” dice Michele con una smorfia, “ho tutto il diritto di farti arrabbiare”.
“Ma che dici?”
“Vita, ho deciso che mi voglio sposare” e porta, scanzonato, le braccia dietro la testa.
“Che dici? Ma tu… dai, smettila… davvero?”
“Davvero… l’ho pensato stanotte, quando ho aperto gli occhi e ti ho trovata al mio fianco. Sei l’unica donna con cui riesco a dormire… non è poco, credimi, il sonno è importante… ”
“E perché non mi hai svegliata… ti avrei… io ti avrei…”.
“Avrei voluto entrarti dentro, Vita”.
“Come? Ma che dici?”
“Dentro la testa, spiarti da dentro…”.
“Non avresti trovato molto”.
“Invece sono sicuro che avrei trovato tutto: il luogo preciso dove sei caduta e ti sei procurata questa cicatrice sulla schiena, il primo letto dove ti hanno spogliata, il primo paziente che hai visitato… tutto avrei trovato, tutti i tuoi ricordi…”.
“Il passato è passato. E’ roba vecchia, come me”.
“Vecchia… e perché vecchia? ”
“Perché ho già raggiunto l’altare una volta, perché so tutto… conosco il prezzo da pagare… in cambio di un bel matrimonio… e il mio è stato bellissimo… ma non è servito a molto… non mi è servito a niente l’abito bianco, non certo a far durare il mio matrimonio. Ho venduto tutto, dopo il divorzio, a un mercatino dell’usato, compresa la giarrettiera rossa contro la iella. Michele… io l’ho già pagata la mia parte…”.
Vita si allontana dal letto, poggia la schiena all’armadio e, con i polpastrelli, raggiunge la cicatrice dietro la spalla. E’ felice che Michele l’abbia notata, che abbia toccato quella ferita, anche se era buio e avevano bevuto.
“Adesso non mi va più di credere alle belle parole, siamo adulti… è meglio che le cosi restino così!”
Michele le chiede di raggiungerlo sul letto.
“Vita, io non dormo con tutte le donne che… insomma…”.
“Con tutte le donne che ti scopi? ”
“No, no… con te ci riesco, ci riesco a chiudere gli occhi”.
“Ma davvero vuoi sposarmi? Perché se è vero… se è vero… mi sembra di sognare… che bel risveglio… dobbiamo organizzare tutto allora… ma non preoccuparti… lo sai no… sono esperta… ritentare non è poi così impossibile… allora adesso dobbiamo…”.
“Frena, piano. Piano, Vita. Hai visto che alla fine hai ceduto… sono proprio un uomo da sposare… Sei buffa… mi fai sorridere. Sei così legata all’amore che non ti rendi conto che ti sto prendendo in giro. Diventi una bambina, di fronte a certi argomenti.”
“Cioè… che vuoi dire?… non capisco…”.
“Vita, lo sai, ci conosciamo da tempo, hai capito come sono fatto, no? Davvero credi che io possa sposarmi?” e si solleva dal letto, serioso e un po’ turbato. “E’ stato solo uno scherzo, scusami, non volevo ferirti”.
“Sì, certo, solo uno scherzo… l’hai fatto… mi hai ferita… per avere la conferma narcisistica che volevi. Povero! Tutte le donne sono pronte a sposarti, ti fa piacere? Ma chi ti credi di essere? Sei solo un uomo che ha paura… paura di mettersi in discussione… tu vivi il dietro le quinte della vita… non capisci davvero niente… sei un povero vigliacco… giocare coi sentimenti della gente… la verità è che ti manca il coraggio… sposarsi è una cosa seria…”.
Michele si infila il jeans, perché la situazione si sta facendo pesante, e prova imbarazzo a restarsene in mutande, di fronte a Vita, e si sente un po’ bambino ad aver fatto quello scherzo. Lei subito si copre il petto con una t-shirt – un abito lo può fare: può marcare le distanze; e basta coprirsi il petto, o indossare un paio di mutande dopo aver fatto l’amore, per annullare la convivenza intima dei corpi. Vita, nervosamente, mette addosso le prime cose che trova, come per ristabilire i ruoli, e mantenere le distanze.
“Che stupida, avrei dovuto immaginarlo” – e sbatte i pugni sul tavolo – “come fa uno come te a parlare di cose serie!” – e getta uno sguardo distratto in cucina.
“Il caffè è nella moca, basta accenderlo. Io vado a lavorare.”
Si aggiusta la maglietta e prende le chiavi dal tavolo, poi va via, sbattendo la porta.
“Grazie. Poi magari ti chiamo da studio” dice Michele, imbarazzato.
“Comunque non è vero che sei l’uomo che amo. Per me è solo sesso” grida dal portone, prima di scendere di corsa, e con il batticuore, le scale di casa.
“Mi piaci quando cerchi di fare la dura!” risponde Michele, alzando la voce, ma Vita è già lontana, e lui si sente ridicolo. La porta però, dopo qualche secondo, si riapre. Vita è tornata con la scusa di aver dimenticato il cellulare.
“Io non sono come te… ai miei pazienti ci tengo, io… non voglio che il telefono squilli a vuoto… sono un medico vero, io… me lo ricordo sempre che sono un medico, io… e comunque non ti sopporto più… vai al diavolo”.
E, questa volta, va via per davvero.
Michele parla da solo, e forse ignora di essere davvero solo.
“Rovino tutto, hai ragione… Vita cara… ma solo perché ho paura, ho paura…” confessa Michele alla casa vuota; poi si alza dal letto e guarda l’orologio. Accende il cellulare, che subito inizia a suonare.
“Che suoni pure a vuoto, io non sono perfetto, sono un uomo, un semplice uomo”.
Butta il telefono sotto le coperte e va verso la cucina. La moca è sul gas e l’accende. “L’avrà preparata stanotte, mentre io dormivo” pensa Michele, pentito di aver rovinato quel risveglio. “Quanto è premurosa, lo è sempre stata… e io… io… non l’ho mai trattata bene… sarebbe davvero bello vivere con lei… condividiamo tutto da molto tempo, anche questa casa… la sento mia, questa casa… basterebbe così poco, invece resto fermo, paralizzato come uno stupido…”.
Vorrebbe non averlo mai fatto, questo scherzo. Ma Vita è via, immersa nei rumori della città – lontano da lui.
“Le scriverò una lettera… mi farò perdonare… sono un uomo di cinquant’anni… lei capirà tutto”.
Michele si siede e inizia a scrivere sulla carta gialla del pane – è l’unica carta che riesce a trovare in casa.
.
.
Matera, sette novembre ‘97
Per Vita
.
Cara Vita, ho pensato a lungo alla discussione fatta, non meriti di soffrire, e non è giusto che io distrugga tutto ogni volta che riesco a creare con te una certa armonia; hai ragione tu quando dici che sono detestabile, ma non voglio perderti… ti racconterò tutto.
Giocavo allegramente con le gambe delle donne quando ero un bambino. Perché mia madre era una sarta, e casa mia era sempre piena di colori, vestiti, pizzi e donne, tante donne. Avevo solo cinque anni, ma ricordo tutto ciò che mi accadde, come fosse ieri.
Mi piaceva aggrapparmi stretto a quelle gambe un po’ pungenti, come una scimmia al suo ramo, ed ero considerato da tutte un figlio.
Mi piaceva spiare le donne in intimità fra di loro.
Mi piaceva guardare in alto e trovare orli di mutandine bianche che si intravedevano dalle sottovesti e, anche se ero piccolo, lo trovavo divertente.
Spesso rimanevo in un angolino della casa, in silenzio ad ascoltare, anche se non li capivo, i sogni di quelle donne. Ricordo che si parlava di matrimoni e di doti.
Un pomeriggio Giacinta, la mia dirimpettaia zitella, intima amica di mia madre, mi chiese di andarle a comprare una pagnotta. Lei frequentava casa mia tutti i giorni, e rimaneva spesso a pranzare da noi, perché era sola e a mia madre dispiaceva. Era una di casa, insomma, una vera zia. Mi disse di comprarle il pane, perché avrebbe mangiato a casa sua quel giorno, e con i soldi restanti avrei potuto comprare delle caramelle, come ricompensa per il favore.
Accettai la proposta, soddisfatto di essere stato scelto per un servizio così importante – io che avevo solo cinque anni, per la prima volta mi trovavo tra le mani dei soldi da gestire, come un vero capo famiglia.
Dovevo portare il pane a casa, e questa cosa mi faceva sentire un piccolo uomo. Quanto mi piaceva, Vita!
A testa alta camminavo per la via del ritorno, portando in una mano la busta bianca del pane e, nell’altra, la ricompensa: dieci caramelle. Era la prima volta che non dovevo condividere nulla con gli altri miei fratelli. Ero felice.
Raggiunsi correndo il portone grande della signora.
Lo aprii con tutta l’energia di quegli anni, e correndo verso il corridoio, raggiunsi la casa di Giacinta, e trovai la porta aperta.
Ero riuscito a fare tutto. Credimi Vita cara, ero felice.
Entrai, come fossi il padrone, e chiamai la signora per nome, anche se lei non mi rispose.
La casa era vuota, e io non capivo.
Dopo poco la signora mi chiamò, era nel bagno che si stava lavando la faccia. Così mi disse da lontano, ma io non la vedevo.. Mi disse di raggiungerla, e io obbedii.
La raggiunsi, e la trovai tutta nuda seduta sul bidè. Subito mi voltai, ma lei mi prese… prese la mia mano… ancora lo ricordo… mi prese la destra, quella che stanotte hai tenuto sul tuo seno.
Dalla tasca sinistra mi caddero le caramelle… e poi mi usò… mi ha usato a suo piacere… mi capisci?
Voglio riprovare, di tempo ne è passato. E se ti va ancora di sopportarmi, voglio riprovare a portare il pane a casa senz’avere paura… sì, io voglio portarti il pane a casa… e questa volta non per gioco.
Tuo, Michele.
Scritto martedì, 17 luglio 2007 alle 18:23 nella categoria Senza categoria. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.









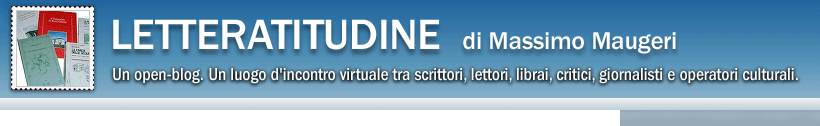















 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI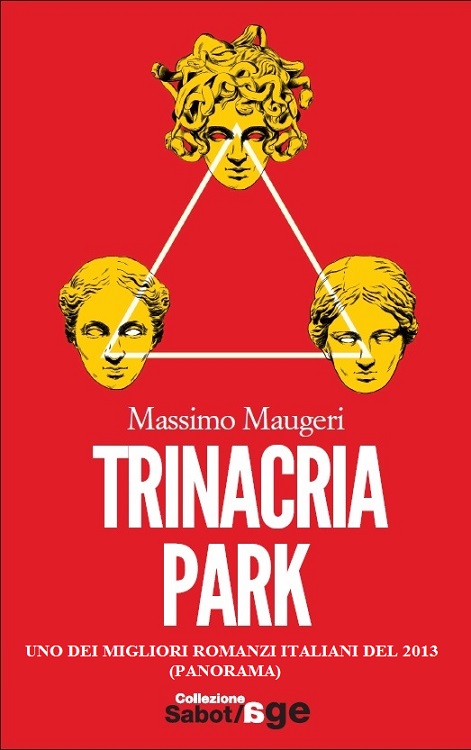
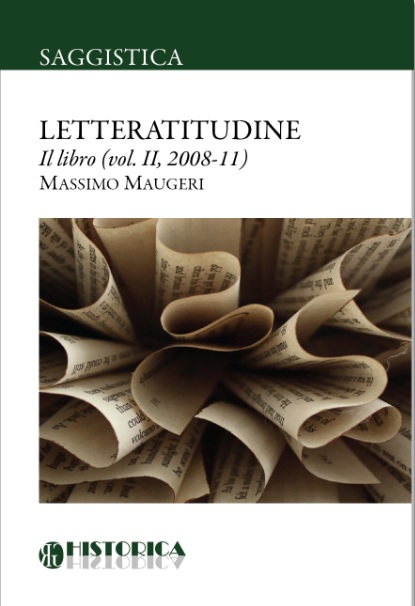


Commenti recenti