giovedì, 19 luglio 2007
MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO: MENARSI NEL BUIO (di Gabriele Montemagno)

Mio fratello è figlio unico, l’ultima pellicola di Daniele Luchetti, uscita di recente nei nostri cinema, è un’opera che per il suo contenuto, sembra avere un’ideale parentela con film quali: Pasolini, un delitto italiano (1995) di Marco Tullio Giordana, Buongiorno, notte (2003) di Marco Bellocchio, L’odore del sangue (2004) di Mario Martone e Romanzo criminale (2005) di Michele Placido. E ciò per più motivi. Innanzitutto perché gli anni ’70 costituiscono lo sfondo principale (e l’oggetto) delle loro storie; poi perché la realtà di quegli anni è il loro campo d’indagine; in ultimo, i loro titoli richiamano tutti qualcosa di violento, oscuro, separato. Quasi che quel decennio del nostro recente passato abbia continuato a visitare la sensibilità di alcuni fra i nostri autori cinematografici, ispirandoli per mezzo dei suoi lati negativi. Per carità, nulla di nuovo o di inaudito: il cinema italiano è sempre stato sensibile alla realtà, al punto da dare vita, col Neorealismo, a quel glorioso periodo su cui molto è stato detto e molto si continuerà a dire, sebbene lì si raccontava il presente e non il passato prossimo. Tuttavia, ciò che qui preme sottolineare (e che può costituire un motivo di interesse e dibattito per i lettori di questo mio intervento) è un aspetto che i film su elencati sembrano suggerire; aspetto che la pellicola di Luchetti pare recepire e far proprio. Infatti, quelle opere non solo raccontano i cosiddetti “anni di piombo” (sebbene il film di Martone sia ambientato ai giorni nostri, ma, come si sa, è tratto dall’omonimo e postumo romanzo di Goffredo Parise, quasi un testamento spirituale sugli anni Settanta) a partire da quei fatti (la morte di Pasolini, il terrorismo e il sequestro Moro, la banda della Magliana) che li hanno maggiormente contrassegnati, ma in esse vi è la consapevolezza che la scomoda ed inquietante presenza di quegli anni non sia, ad oggi, del tutto esaurita. E ciò tanto più, in quanto, in forza della loro accesa efficacia visiva e narrativa nell’evocare le atmosfere cupe di quegli anni, tali film riescono ad esprimere adeguatamente gli effetti che i fatti vissuti dai protagonisti hanno causato nelle loro psicologie individuali (penso, soprattutto a Buongiorno, notte e a Romanzo criminale). Effetti che sono restituiti nella loro integrità ed attualità allo spettatore di oggi.
Mio fratello è figlio unico ha come teatro della vicenda narrata Latina (e come non pensare anche al recente e ottimo film L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino, anch’esso ambientato a Latina!), mostrata nella sua realtà di città di provincia e di ricettacolo degli echi di quel mondo, quale quello degli anni ’70 in Italia, complesso ed estremista (ma solo quello?). Echi che appaiono macroscopici e violenti. Viene filmata, infatti, una provincia in cui i conflitti si insinuano persino all’interno delle famiglie, anche di quelle più povere. Come quella dei due protagonisti, i due fratelli Benassi, uno (interpretato da Riccardo Scamarcio che, liberatosi qui, finalmente, dal clichè di “bello e dannato”, ha acquisito uno sguardo che rivela profonde inquietudini e sofferenze) di solida fede comunista, e l’altro, Accio, (reso da un sorprendente Elio Germano, che riesce a dare pienamente corpo a tutta la rabbia e a quella profonda ricerca di verità che anima questo personaggio) prima convinto fascista, e poi anche lui comunista, ma meno puro (e più maturo) del fratello.
In questo film, Luchetti, liberandosi di cavalletti, gru e di tutto ciò che può rendere lineari ed eleganti le inquadrature, muove con sicurezza la sua macchina da presa (tenuta sempre rigorosamente a spalla, cioè ad altezza d’uomo) in modo da mantenere uno sguardo che “pedina” i suoi personaggi, per rivelarne la loro interiorità attraverso immagini che dietro ad un equilibrato realismo non nascondono, a volte, anche un significato metaforico. Si pensi, ad esempio, alla sequenza in cui Accio viene picchiato dai suoi camerati di partito poiché si è rifiutato di bruciare le auto di alcuni comunisti suoi conoscenti (tra cui c’è anche quella del fratello): dentro la sede del partito, che diviene sempre più buia, il piccolo gruppetto di uomini continua a menare le mani con una violenza sempre più incomprensibile, fino a costituire un insieme indistinto in cui si agitano braccia e teste nella controluce di un’unica finestra. Tale sequenza pare proprio racchiudere il giudizio secondo cui gli anni ’70 furono anni di violenza provocata da menti oscurate da passioni confuse e immature. E ci induce a pensare che, forse, quegli anni non siano poi così lontani dai nostri, nei quali alcuni accampano passioni che, spesso altrettanto confuse, possono ingenerare contrapposizioni (politiche, religiose, ecc.) le quali non sono meno oscure e pericolose per la pace e per il progresso civile e democratico. Chissà se, a questo proposito, la narrazione (cinematografica, letteraria o di qualunque altro genere) non ci possa illuminare ogni qual volta ci racconta queste buie ed efferate passioni, rivelandocele per quello che sono. Già, chissà. Se ne potrebbe discutere.
Gabriele Montemagno
Scritto giovedì, 19 luglio 2007 alle 11:57 nella categoria Senza categoria. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.









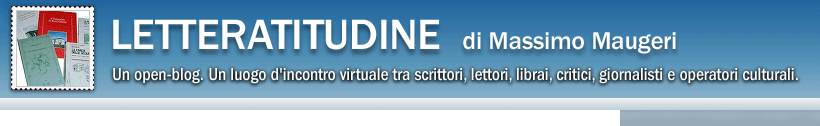














 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI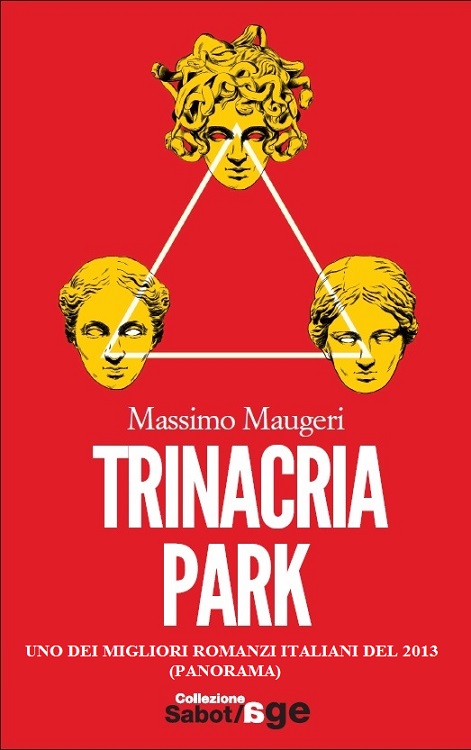
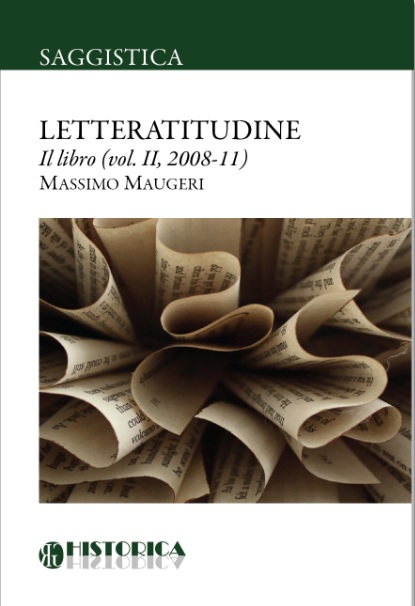


Commenti recenti