domenica, 28 aprile 2019
IL GATTOPARDO di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Leggerenza n. 5)
Senza il pregiudizio ideologico apposto dalla critica di sinistra, sia accademica che militante, Il Gattopardo non sarebbe stato ricordato in chiave politica ma unicamente come romanzo storico, secondo le intenzioni del suo autore. Invece continua a gravare su di esso una doppia ipoteca reazionaria e riduzionista: la prima voluta da un’ottica aristocratica che non vede né il progresso né i proletari, ma solo la conservazione di un retaggio di casta; la seconda imposta da un gurgite sicilianista che, secondo Sciascia, porta Tomasi a comprendere i mali della Sicilia come “vizio di astrazione geografico-climatica” che ne ricondurrebbe la causa essenzialmente al tormento del caldo torrido, indicato invero dall’autore quale “autentico sovrano della Sicilia”, “collera divina”, “grande lutto”, “maledizione annuale”, segno di cattiva giornata.
Astrazione che è però anche storica nella rappresentazione della Sicilia che il principe (offrendo la miglior prova di sicilianismo) fa a Chevalley, da un lato con l’imputare alle dominazioni straniere le gravi condizioni sociali dell’isola e da un altro con il deplorare le caratteristiche endemiche dei siciliani che amano il sonno, condannano il fare e si credono il sale della terra. In questo quadro le critiche al romanzo sono fondate, perché Il Gattopardo non concede scampo alcuno alla “irredimibilità” (termine coniato da Tomasi e fatto proprio da Sciascia) della Sicilia, strozzata in un’impossibilità di sviluppo che è anche un arroccamento volontario. Il romanzo storico cui per anni, almeno dal referendum costituzionale, pensa l’autore palermitano è inteso a celebrare i fasti di una classe sociale per millenni al potere allo scopo di intonarne il de profundis: alla ricerca delle cause del declino, Tomasi trova che i primi segni di cedimento della aristocrazia siciliana si siano avuti in occasione della campagna di Garibaldi: evento al quale la Sicilia assiste in un’accidiosa insipienza, incapace anche di formarsi un’opinione condivisa.  L’antistoricismo imputato a Tomasi trova quindi ragione nella pusillanimità che l’autore attribuisce a una classe incapace di cogliere l’ultima occasione che la storia le offre non tanto per salvarsi quanto per rigenerarsi. Il giudizio di disprezzo che il principe di Salina esprime al ricevimento della lettera di un nobile che invita anche lui a lasciare Palermo dopo lo sbarco dei Mille segna il momento di rottura dell’asse che regge la classe dominante.
L’antistoricismo imputato a Tomasi trova quindi ragione nella pusillanimità che l’autore attribuisce a una classe incapace di cogliere l’ultima occasione che la storia le offre non tanto per salvarsi quanto per rigenerarsi. Il giudizio di disprezzo che il principe di Salina esprime al ricevimento della lettera di un nobile che invita anche lui a lasciare Palermo dopo lo sbarco dei Mille segna il momento di rottura dell’asse che regge la classe dominante.
Di fronte alla divisione della nobiltà tra liberali e lealisti, il principe di Salina dà credito all’iniziativa mediana e ruffiana, ma di estrema intelligenza per un ceto così miope, che si intesta il nipote Tancredi, pronto a combattere per il nuovo re contro il vecchio solo per ottenere che nulla cambi nella sfera di privilegi del casato. Fermo in questa strategia, don Fabrizio vota perciò a favore dell’annessione e incoraggia i villani di Donnafugata a fare altrettanto, mostrandosi moderno per restare infine non tanto antico ma sulla scena, sennonché altro non conquista che un limbo nel quale, durante il gran ballo, gli apparirà evidente la vacuità dello sforzo compiuto in favore di un cambiamento che fosse un adattamento, perché vedrà danzare in un palazzo lasciato nello stile antico, insieme con i vieti modi e la moda passatista, un mondo immoto inconsciamente e irresponsabilmente in corsa verso il precipizio.
È una derelizione che Tomasi preconizza sin dal momento dell’arrivo del principe e della famiglia a Donnafugata. Prima ancora che don Ciccio Tumeo insorga e dichiari “una porcheria” lo sproposito che un Falconeri sposi una Sedara, presagio della fine dei Falconeri e degli stessi Salina, è la popolazione (la stessa che, pensando a una preterizione, dubita circa la sincerità del suo invito a votare l’annessione) a trovare il principe cambiato quando gli sente dire che la sera vorrà incontrare tutti gli amici e che si augura la pioggia: l’eccessiva cortesia indebita mostrata ai contadini viene vista come segno del declino del suo prestigio, giacché mai il principe aveva ricevuto villani né gli era importato nulla che piovesse o meno.
 Tomasi intende allora il suo romanzo storico, al cambio di un’epoca con un’altra, come testimonianza personale di un mondo del quale è egli stesso l’epigonale sopravvissuto rimasto con le dita prive di anelli e titoli senza valore. E non sa se identificarsi appieno in esso, dal momento che a volte parla della Sicilia scrivendo “da noi” e a volte “in quel remoto paese”. Né sceglie un tempo narrativo continuo e progressivo, perché si serve molto dell’analessi, preferendo il recupero di fatti già avvenuti e il ritorno al passato anche prossimo, e della prolessi anticipando pure di moltissimi anni vicende che non verranno mai riprese. Il romanzo appare agitato da una febbre e da un intento di documentazione storica che volendo essere quanto più oggettiva – di qui il velo di ironia, a volte malriuscita – si rivela piuttosto estremamente sentita e partecipata. Tomasi vuole da un lato, per riferirsi al suo presente e all’esiziale futuro di casta, dipingere un’epoca con i suoi drammatici rivolgimenti e da un altro dare lustro alla propria casata, elevando lodi agli avi santi e gloriosi. E questo fa in realtà per coprire un lato oscuro della propria genealogia, sul quale tace ma che sente come una vergogna più che una colpa. Il Gattopardo può essere dunque anche un’operazione a nascondere nel proposito di far pendere da un lato la bilancia del fas et nefas. C’è una storia di casa e di casato che il romanzo, pur preferendo fare in esergo quella complementare ma esornativa di padre Pirrone, lascia fuori ma che pure è ben dentro il suo tessuto e la sua scaturigine. La gran mole di studi dal 1958 ad oggi ha pressoché ignorato questo fondo di rimandi, che tuttavia merita di essere tenuto presente e indagato. Lo stesso Tomasi cercò in tutti i modi di tenere sepolto l’umiliante segreto di famiglia, ma dovette fare, forse inconsciamente, i conti con esso. Sicché è bene parlarne apertis verbis.
Tomasi intende allora il suo romanzo storico, al cambio di un’epoca con un’altra, come testimonianza personale di un mondo del quale è egli stesso l’epigonale sopravvissuto rimasto con le dita prive di anelli e titoli senza valore. E non sa se identificarsi appieno in esso, dal momento che a volte parla della Sicilia scrivendo “da noi” e a volte “in quel remoto paese”. Né sceglie un tempo narrativo continuo e progressivo, perché si serve molto dell’analessi, preferendo il recupero di fatti già avvenuti e il ritorno al passato anche prossimo, e della prolessi anticipando pure di moltissimi anni vicende che non verranno mai riprese. Il romanzo appare agitato da una febbre e da un intento di documentazione storica che volendo essere quanto più oggettiva – di qui il velo di ironia, a volte malriuscita – si rivela piuttosto estremamente sentita e partecipata. Tomasi vuole da un lato, per riferirsi al suo presente e all’esiziale futuro di casta, dipingere un’epoca con i suoi drammatici rivolgimenti e da un altro dare lustro alla propria casata, elevando lodi agli avi santi e gloriosi. E questo fa in realtà per coprire un lato oscuro della propria genealogia, sul quale tace ma che sente come una vergogna più che una colpa. Il Gattopardo può essere dunque anche un’operazione a nascondere nel proposito di far pendere da un lato la bilancia del fas et nefas. C’è una storia di casa e di casato che il romanzo, pur preferendo fare in esergo quella complementare ma esornativa di padre Pirrone, lascia fuori ma che pure è ben dentro il suo tessuto e la sua scaturigine. La gran mole di studi dal 1958 ad oggi ha pressoché ignorato questo fondo di rimandi, che tuttavia merita di essere tenuto presente e indagato. Lo stesso Tomasi cercò in tutti i modi di tenere sepolto l’umiliante segreto di famiglia, ma dovette fare, forse inconsciamente, i conti con esso. Sicché è bene parlarne apertis verbis.
Tomasi non andò certamente a Simancas, dove dal Cinquecento è attivo il più grande archivio militare dell’epopea spagnola, perché se l’avesse fatto avrebbe trovato quanto un altro palermitano, Giovanni Marrone, pubblicherà nel 1995 in appendice al suo Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna (Palumbo): gli atti del processo che nel 1583 fu celebrato contro tale Mario de Tomasi, un capitano d’arme di Licata di cui Marrone fu pronto a rilevare l’“esemplare carriera”, perché comune a quella dei masnadieri che si resero famigerati per nefandezza ed efferatezza e che prepararono la campagna siciliana alle future bande mafiose dei campieri. Un processo concluso (nonostante la documentata pratica delittuosa esercitata dalle compagnie d’arme come mezzo di controllo poliziesco per conto di Carlo V) con una blanda condanna all’inabilitazione e perciò servito a porre le remote premesse ai patti di collusione tra Stato e mafia.
Mario de Tomasi era il peggiore dei suoi pari e Marrone vide bene elevandolo a campione della risma con una fedina da brivido: «Autore di infiniti abusi e di crimini che, in un crescendo continuo, andavano dalle estorsioni alle concussioni, ai furti, fino alle crudeltà più impressionanti, provocando la morte di numerosi infelici, accumulò un patrimonio valutato intorno a ventimila scudi». Un patrimonio provento della sua più lucrosa attività: il commercio delle teste di banditi alla macchia, ognuna delle quali poteva valere fino a mille scudi perché legalmente e abitualmente accettata come partita per liberare un prigioniero pur’anche da designare. Marrone però non si avvide o non volle avvedersi che il “tale” Mario de Tomasi altri non era che il capostipite dei Tomasi di Lampedusa, lo stesso Mario Tomasi che nel 1987 era comparso in cima all’albero genealogico pubblicato da Andrea Vitello nella sua ponderosa biografia omonima dello scrittore uscita da Sellerio.
Epperò, in un gioco di continue distrazioni, nemmeno l’acribitico Vitello, pure lodevole per il frutto della sua ricerca (che partiva già nel ’63 da Flaccovio con I Gattopardi di Donnafugata: dove però si taceva ancora la vera natura del capostipite), capì con chi avesse a che fare o più probabilmente finse di non capire: e, definendo Mario Tomasi appena «un oscuro armigero», si limitò a segnalare che aveva sposato, proprio nell’anno del processo, una Francesca Caro, baronessa di Montechiaro e signora di Lampedusa. È infatti con l’attribuzione di “primo barone di Montechiaro” che il capostipite scrive una memoria difensiva di almeno due volumi indirizzata al re di Spagna e rivolta contro il “visitador” regio che istruisce il suo processo, perché ne sia impedita la prosecuzione. Ne avrà, come si ricava dal testamento del figlio Giovanni, la condanna anche all’esilio – un caso fallito di ricorso all’autorità superiore, costume molto diffuso nell’altera nobiltà siciliana che si rivolgeva a Madrid per scavalcare Palermo.
Il frontespizio del lungo ricorso costituirà la seconda illustrazione del libro di Gioacchino Lanza Tomasi Biografia per immagini di Tomasi (Enzo Sellerio, 1998) ed è proveniente dai documenti di casa Tomasi andati in gran parte distrutti nel bombardamento del ’43. Giuseppe Tomasi non poteva dunque non conoscerne l’esistenza né ignorare che artefice della “razza di santi” lampedusiana e dell’ingente fortuna accumulata fosse stato un delinquente della peggiore cotta. Se dunque non andò mai a Simancas fu perché non aveva bisogno di sapere oppure non voleva sapere di più, ipotesi che è più verosimile. Le indagini di Andrea Vitello permisero di accertare che Lampedusa ne parlava tuttavia al cugino Lucio Piccolo, dal quale qualche confidenza è arrivata poi a uno studioso di Capo d’Orlando, attento al proprio anonimato. Ma cosa sapeva esattamente Lampedusa circa il suo capostipite? Certamente era al corrente del processo e dunque (se ha avuto in mano la mole dei documenti andati perduti) di tutte le accuse, compresi gli eccessi del cacciatore di teste.
Se le cose stanno così, Il Gattopardo ci appare sotto una luce nuova e spiega la celebre frase che suggella la parabola dell’aristocrazia siciliana al fondo di un’esperienza personale, quella del principe: «Noi fummo i gattopardi, i leoni, quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene», immagine dove animali necrofagi sembrano evocare uomini come il capostipite negli «smisurati ritratti equestri dei Salina trapassati» e nella «doppia fila di antenati corazzati e infiocchettati». Un peccato originale che integra una nemesi, la condanna all’estinzione di una stirpe che cova il germe dell’illecito e della nequizia? La domanda deve trovare risposta nella rilettura dell’opera complessiva di Lampedusa.
Vitello volle scorgere l’ombra di Mario Tomasi nel commento di Lampedusa al Caesar di Gundolf sul mensile “Le Opere e i Giorni”, dove l’autore del Gattopardo teorizza il diritto ad una seconda biografia, «senza confini di tempo o di spazio, che narri l’aggirarsi dell’ombra» e le «conseguenze delle sue apparizioni». Il riferimento alla macchia originaria può sembrare esplicito se di Lampedusa si accoglie l’idea di un uomo che del travestimento e della finzione fa uno stile di vita, tanto da nascondere a se stesso e agli altri il tumore che lo ucciderà. La “naturale tendenza” del principe di Salina «a rimuovere ogni minaccia alla sua calma» è perciò la stessa di Lampedusa che rifugge la realtà e la verità, così come per esempio è sua abitudine gettare via la posta senza nemmeno aprirla, rispondendo a un ideale elusione del presente che è il cuore del Gattopardo. Più che il bisnonno Giulio Fabrizio, il principe ci appare allora lo stesso Lampedusa, trasposto nella coscienza dell’ultimo discendente cui spetta con la propria morte, tanto «corteggiata» e ricercata, di interpretare un destino generazionale ubbidendo al credo in una ananké. Don Fabrizio è il «primo ed ultimo di un casato» tenuto in spregio che nutra dichiarato «disprezzo per i suoi parenti e amici che gli sembrava andassero alla deriva nel lento fiume pragmatistico siciliano». Lo stesso Lampedusa si sente alla deriva e nell’opera di annichilimento che compie del proprio mondo dorato individua un simbolo della caduta degli dei, per quanto scrive nella lettera al suo amico Enrico Merlo, in Bendicò, che è per lui la chiave del romanzo. Il cane, i cui resti impagliati resistono quasi trent’anni per poi disfarsi nell’aria, salvo ricomporsi nella postrema sagoma di un gattopardo, è «il personaggio» laterale e scorciato che assiste a tutte le vicende incombendo come uno stemma o uno stigma, il segno che l’elemento di maggiore consistenza e durata non appartiene alla natura umana. Nella stessa lettera del ’57 a Merlo Lampedusa rivela anche: «Angelica non so chi sia, ma ricorda che Sedàra, come nome, rassomiglia molto a Favara». E Favara è la roccaforte nella quale il capitano d’arme Mario de Tomasi guida per 22 giorni un saccheggio senza risparmio. Sicché sui modi volgari di Sedàra si possono sovrapporre quelli del primo Tomasi, barone per solo effetto del matrimonio e villano senza emuli: nessuno dei Lampedusa porterà infatti – e non a caso – il suo nome.
Del resto quando, inopinatamente, Lampedusa scorge negli occhi di Concetta «un bagliore ferrigno» e le riconosce «il sangue violento dei Salina», il loro «impeto rabbioso», non può che pensare a Mario Tomasi, il cui spirito nefasto si è trasfuso nell’unica figura di casa Salina che è vista con sfavore (ma anche il figlio Francesco Paolo è gradito appena per la sua «balordaggine», entro un intento di derelizione della propria linea ereditaria a vantaggio invece di quella collaterale propria di un Tancredi il cui sangue è immune da ogni veleno, l’uomo nuovo che «avrebbe potuto essere l’alfiere di un contrattacco che la nobiltà, sotto mutate uniformi, poteva portare contro il nuovo ordine politico») e che finirà per addirsi al mercimonio di reliquie compiendo dunque, se non reiterando, un reato che suona come rifiuto della vocazione alla santità dei Lampedusa. La «fine di tutto», se tale dev’essere, non può che colpire tutti i componenti di una schiatta nata con un male inestirpabile. E di un male incurabile Lampedusa infatti muore, senza sapere che il romanzo più volte rifiutato avrà un successo al di sopra di ogni aspettativa, ma porterà alla scoperta di una macchia indelebile proprio in capo all’albero genealogico.
(È vietata la riproduzione anche parziale)
* * *
[Tutte le puntate di Leggerenza sono disponibili cliccando qui]
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo
Seguici su Facebook e su Twitter
Tags: gianni bonina, Giuseppe Bonaviri, Il Gattopardo, Leggerenza
Scritto domenica, 28 aprile 2019 alle 08:00 nella categoria LEGGERENZA (a cura di Gianni Bonina). Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.









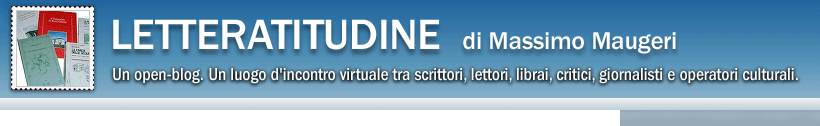















 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI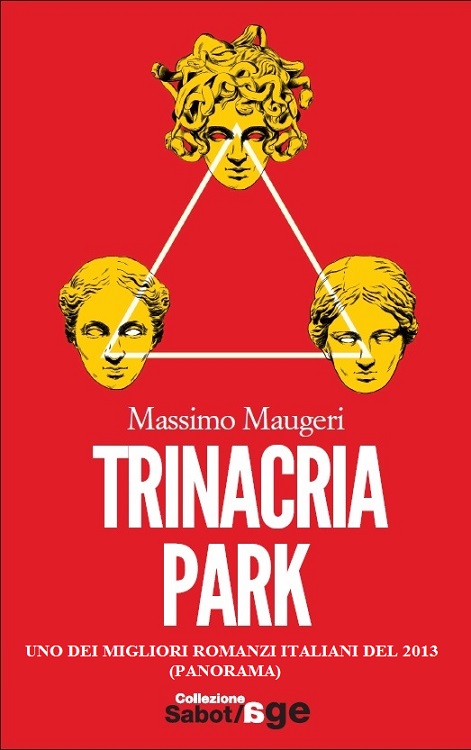
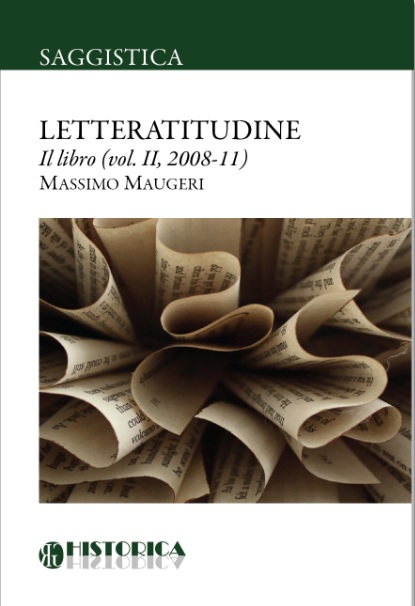


Commenti recenti