domenica, 9 dicembre 2007
MI DISPIACE, NON SONO UN PERSONAGGIO di Antonella Cilento
Quello che vi propongo di seguito è un intervento caustico e sentito che Antonella Cilento (nella foto sotto) mi ha inviato per la sua rubrica “L’ombra e la penna“.
Già il titolo, “Mi dispiace, non sono un personaggio”, anticipa in maniera chiara il contenuto del testo.
Ringrazio Antonella perché mi pare che ci abbia fornito un’ottima occasione per dibattere di un argomento attuale e coinvolgente; soprattutto per coloro che, per un motivo o per l’altro, sono vicini all’ambiente letterario/editoriale. Vi chiedo di discuterne assieme con passione, ma senza tradire i toni e lo stile che caratterizzano questo blog.
Vi ringrazio.
(Massimo Maugeri)
________________________________________
________________________________________
 Ormai per essere pubblicati bisogna passare un casting. Sei interessante? Sai parlare in pubblico? Sei un attore/attrice? Sei strano/a? Trasgredisci, porti le giarrettiere, sei sexy? Hai la faccia giusta, incuriosisci, puoi andare in tv, hai i denti a posto? Manca poco al Grande Fratello degli scrittori, in questo spaventoso vuoto pneumatico della progettualità editoriale. Da tempo non si leggono i libri ma si guardano le facce degli scrittori, li si chiama, nelle riunioni editoriali o nelle cene fra addetti, per cognome: ce l’ho, ce l’ho, mi manca. Siamo figurine dei calciatori. E poiché non tutti vendiamo le cifre che agli editori fanno comodo, siamo spesso calciatori di serie B. Quello non lo voglio perché c’ha troppa storia (cioè ha segnato poco, un’intera stagione in panchina), quella la tengo come fiore all’occhiello anche se mi va sempre in fuori gioco. Ovviamente nell’editoria (italiana) non ci sono in gioco le cifre del calcio, ma hai voglia a star lì a scrivere davvero, a lavorare tutti i giorni, a non fare la velina della letteratura: hai perso. C’è una schiera di bellocci, furbastri e manovratori che ti passa avanti.
Ormai per essere pubblicati bisogna passare un casting. Sei interessante? Sai parlare in pubblico? Sei un attore/attrice? Sei strano/a? Trasgredisci, porti le giarrettiere, sei sexy? Hai la faccia giusta, incuriosisci, puoi andare in tv, hai i denti a posto? Manca poco al Grande Fratello degli scrittori, in questo spaventoso vuoto pneumatico della progettualità editoriale. Da tempo non si leggono i libri ma si guardano le facce degli scrittori, li si chiama, nelle riunioni editoriali o nelle cene fra addetti, per cognome: ce l’ho, ce l’ho, mi manca. Siamo figurine dei calciatori. E poiché non tutti vendiamo le cifre che agli editori fanno comodo, siamo spesso calciatori di serie B. Quello non lo voglio perché c’ha troppa storia (cioè ha segnato poco, un’intera stagione in panchina), quella la tengo come fiore all’occhiello anche se mi va sempre in fuori gioco. Ovviamente nell’editoria (italiana) non ci sono in gioco le cifre del calcio, ma hai voglia a star lì a scrivere davvero, a lavorare tutti i giorni, a non fare la velina della letteratura: hai perso. C’è una schiera di bellocci, furbastri e manovratori che ti passa avanti.
Li avrei voluti vedere i nostri tecnici dell’editoria risolvere il problema fino a qualche decennio fa, o magari cento anni fa: dove lo mandavano Giovanni Verga? Dalla De Filippi? E anche Pavese dalla Dandini non avrebbe funzionato granché. Ma oggi, in fondo, che importa? Viviamo in un paese in cui per la stragrande maggioranza delle persone la letteratura italiana del Novecento manco esiste, figuriamoci quella di altre epoche. Siamo precisi: non esiste per quasi nessuno la letteratura in generale. E non come negli anni Sessanta quando il romanzo impegnato lo leggeva una fascia elitaria ma una fascia più ampia leggeva il romanzo popolare e poi la maggioranza doveva essere ancora alfabetizzata. No, adesso il romanzo impegnato è scomparso, scrivere bene è un disvalore, il romanzo popolare lo fa la televisione e il grande romanzo, se siamo fortunati, ce lo riduce il cinema. Serve una fiction per tornare a leggere Tolstoj, magari il film di Faenza per ributtare un’occhiata al dimenticato De Roberto e nei prossimi mesi, chissà (mica è detto) il film di Martone per riparlare di Noi credevamo di Anna Banti.
E non è detto perché questo romanzo non si trova: per comperarlo mi ha aiutato la bravissima Francesca Branca, che cura un documentatissimo e appassionato blog dedicato a questa grande scrittrice morta da nemmeno vent’anni e caduta nel peggiore degli oblii (www.annabanti.splinder.com), dove per altro (vera novità!) presta sulla fiducia le sue copie personali dell’autrice, altrimenti acquistabili con difficoltà in librerie antiquarie, in prime edizioni costosissime. Un giorno Francesca mi scrive, mi cerca e poi ci incontriamo e fra le tante cose che ci raccontiamo c’è anche la storia di questo libro, uscito nel 1964, che Mario Martone ha scelto per girare un film di ambito risorgimentale (i diktat della nostra cultura ufficiale ci sollecitano: prego, signori, Dante e il Risorgimento. Niente di male in questo se non diventassero scelte obbligate, specie Dante…). Ma il libro si trova a fatica su E-bay, gli editori non ci provano nemmeno a ristamparlo. Certo, la Banti, che qualcuno ricorderà per il suo romanzo più celebre, Artemisia, dedicato alla vita della pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi, ma che ha scritto decine di libri e racconti spettacolari (Lavinia fuggita, magnifico, I porci, Tela e cenere e moltissimi altri, la raccolta più completa s’intitola Campi Elisi), non doveva essere un personaggio facilissimo (vedi l’autobiografia romanzata Un grido lacerante, uscita pochi anni prima della morte). Ah, proprio non ce l’avrebbe fatta la nostra editoria a portarla in tv. Una signora delle lettere, una vera maestra. Dirigeva una rivista fondamentale nella nostra storia letteraria, Paragone, con piglio feroce, bacchettando tutti, aspettandosi il meglio da tutti (vedi la raccolta di lettere di Alberto Arbasino pubblicata di recente da Archinto). Ah, come mi piacerebbe oggi dover litigare con una Banti, con un Vittorini, beccarmi una lettera di rifiuto da Calvino! Ci sarebbe gusto, almeno. Non dovrei passare il tempo a spiegare a qualche giovanissimo correttore di bozze a contratto cocoprò le regole della lingua italiana (perché ci sono regole?) e aiutarlo a distinguere l’errore dall’invenzione. Povera creatura, fra due mesi sarà di nuovo in strada, ne sa meno di chiunque altro, che deve fare? Ma niente, questo destino ci è negato, dobbiamo rassegnarci a litigare con l’aria, spesso a scusarci con gli editori per aver scritto cose appena più complesse del libro di barzellette. Torniamo perciò a Noi credevamo e spendiamoci due parole: il romanzo racconta l’epopea del repubblicano Domenico Lopresti, avo calabrese della Banti. Domenico, ormai vecchio e trapiantato contro voglia nella Torino che ha fatto a suo dispetto l’Italia, circondato dall’affetto dei figli cui non lascerà niente salvo le sue memorie, critico verso di sé e il mondo, si decide, suo malgrado, a scrivere le sue memorie. Le lunghe prigionie toccategli per la spiata dell’ipocrita Cassieri lo vedono, dopo una giovinezza da filadelfo entusiasta e speranzoso, recluso a Montefusco, a Procida e a Montesarchio insieme a Carlo Poerio. E’ il 1883 mentre scrive e gli anni da cospiratore trascorsi facendo il corriere e visitando a Lugano Cattaneo gli sembrano davvero distanti. Anche la spettacolare fuga da Livorno, anche il nuovo tentativo garibaldino in Aspromonte gli appaiono velati dall’occhio dell’età. Il paese, che pure ha contribuito a formare, non lo riconosce, lo ha condannato, le relega a una vita da diseredato nella città dei tanto detestati Savoia. La storia di una delusione, quindi, di un fallimento che fonda la contemporaneità. La vicenda di Domenico è dentro la linea del grande romanzo italiano che va dal Diavolo a Pontelungo di Bacchelli a Noi credevamo a Il resto di niente di Striano. Una linea che si interseca con L’isola di Arturo (Noi credevamo è del ’64, il romanzo della Morante di poco precedente) non solo per la vicinanza degli scorci procidani, ma per la potenza dell’io narrante che poco ha da invidiare all’Adriano della Yourcenar. La vicinanza con Striano, edito molti anni dopo, poi è straordinaria: i ritratti dei camorristi e dei contadini incontrati in carcere che Domenico compie, lui nei panni del galantuomo povero in canna ma animato dal fuoco della libertà, ricordano in forma speculare il celebre dialogo fra i rivoluzionari e i capipopolo della Napoli di Maria Carolina. Scrive Domenico: “Non mi piacciono le favole e diffido dei romanzieri. Per chi scrivono costoro? Come possono giocare la loro vita componendo storie inventate? Le donne le leggono avidamente (…) Va bene, anche le donne sono un pubblico. E tuttavia scrivere per un pubblico cosiffatto non mi piacerebbe. Sono intelligenti, le donne? (…) Fino a un certo segno penso che la loro condizione coincida con quella del romanziere, il quale più che viverla, costruisce la vita.” Molta amarezza, in trasparenza. Un destino letterario già vinto che passa da queste pagine.
Vedremo se il film di Martone aiuterà a far ripartire il dibattito e magari a riportare sui banchi dei librai questo romanzo come in questi giorni capita ai Viceré, ristampati in edizioni supereconomiche.
Chissà se qualcuno ha davvero voglia di discutere il lato non eroico, non illuso del nostro Risorgimento. E chissà se si potrà parlare di un libro senza un’autrice che vada a chiacchierare in fascia pomeridiana su Rai 2 del destino dei figli, degli spinelli e dei casi di cronaca.
Antonella Cilento
Pubblicato in L'OMBRA E LA PENNA (con il contributo di Antonella Cilento) 177 commenti »









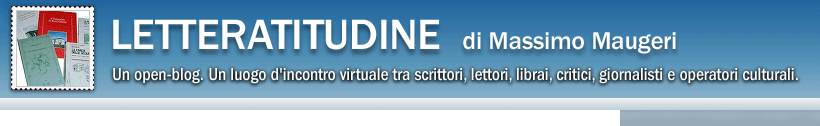














 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI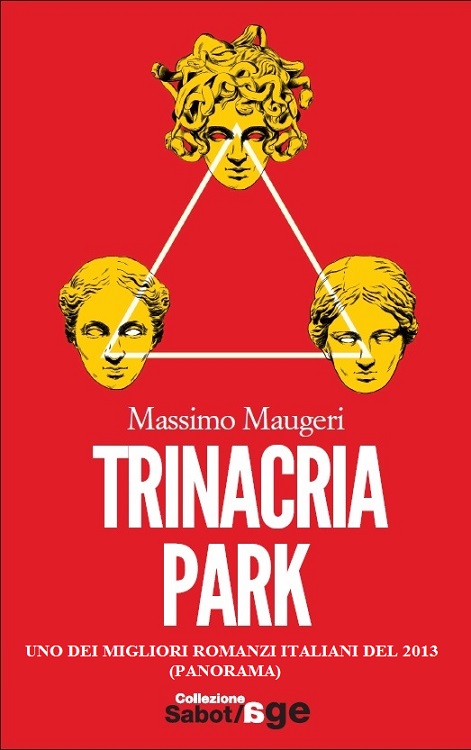
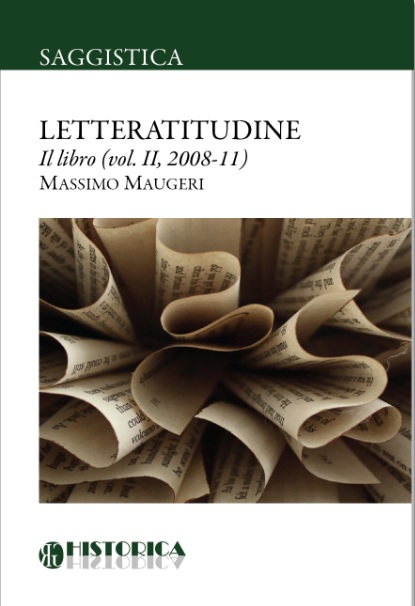


Commenti recenti