venerdì, 23 marzo 2018
NON SO PERCHÉ NON HO FATTO IL PITTORE di Alberto Moravia
 Il nuovo appuntamento della rubrica di Letteratitudine chiamata “Saggistica Letteraria” è dedicato al volume “Non so perchè non ho fatto il pittore. Scritti d’arte (1934-1990)” di Alberto Moravia (Bompiani).
Il nuovo appuntamento della rubrica di Letteratitudine chiamata “Saggistica Letteraria” è dedicato al volume “Non so perchè non ho fatto il pittore. Scritti d’arte (1934-1990)” di Alberto Moravia (Bompiani).
Il volume è stato ottimamente curato da Alessandra Grandelis, che svolge la sua attività di ricerca all’università di Pavia, e offre vari scritti che permettono di comprendere come Moravia abbia contaminato arte e letteratura, letteratura e arte… con particolare riferimento al mondo della pittura.
Ne discutiamo con Alessandra Grandelis. In coda all’intervista (per gentile concessione dell’editore e degli eredi di Moravia) pubblichiamo un estratto del libro: uno scritto intitolato Rembrandt pittore dell’inquietudine
* * *
“Non so perchè non ho fatto il pittore. Scritti d’arte (1934-1990)” di Alberto Moravia (Bompiani, a cura di Alessandra Grandelis)
- Cara Alessandra, partiamo dal titolo del libro: “Non so perché non ho fatto il pittore”. È una frase dello stesso Moravia che, in effetti, colpisce. Al di là di questa considerazione, perché hai scelto (o la casa editrice ha scelto) proprio questa frase come titolo del libro?
In molte occasioni Moravia ha dichiarato di preferire la pittura alla letteratura. Lo affascinava il mistero che circonda l’artista e la sua opera d’arte, l’impossibilità di spiegare la traduzione del pensiero in immagine. E quello del pittore gli appariva un mestiere più attraente anche per la sua dimensione artigianale, diversamente negata allo scrittore, impegnato a battagliare con le parole. Con questi presupposti “Non so perché non ho fatto il pittore” è parso da subito il titolo giusto per la raccolta dei testi d’argomento artistico: nella spontaneità dell’espressione sono racchiuse queste idee alla base della fascinazione moraviana per l’arte.

- Da dove trae origine l’amore di Moravia per la pittura?
Di certo il fascino nasce in famiglia. Il padre era un architetto che si dedicava alla pittura come dilettante; ogni anno ritornava nella città natale, Venezia, per dipingerne le vedute che solitamente copiava prima di darle in dono. Non va nemmeno dimenticato che la sorella Adriana diventerà una pittrice affermata, il cui espressionismo ricorda l’arte di Matisse. È lo stesso Moravia a ricordare che da bambino, durante le vacanze familiari, trascorreva lunghe ore davanti alle tele presenti nel villino estivo a Viareggio: fantasticare sui soggetti mitologici dei quadri ha avuto una grande ripercussione sull’immaginario moraviano.
- Lo hai accennato anche tu: in varie occasioni Moravia sostiene di preferire la pittura alla letteratura. Sembrerebbe un paradosso. Potresti approfondire questo aspetto?
Oltre a quanto detto in precedenza, aggiungerei che Moravia attribuisce all’arte una caratteristica di grande valore: l’universalità. A differenza di quanto accade per la letteratura, secondo Moravia l’arte può essere compresa da tutti, da chi possiede gli strumenti per decrittarla e da chi ne è del tutto sprovvisto. Ciò significa considerare l’arte una forma di espressione capace di interagire con l’osservatore senza alcuna mediazione.
- Rimanendo sull’argomento, in altri casi Moravia teorizza una supremazia della pittura sulla letteratura (la prima rappresenterebbe meglio la storia artistica italiana). Cosa puoi dirci da questo punto di vista?
 Semplicemente Moravia riteneva che alcuni Paesi fossero meglio rappresentati dalla letteratura, come nel caso della Francia, ed altri dalla pittura, come l’Italia. Ha sempre sostenuto che la cultura e la storia italiane vadano ricercate nell’arte e non altrove, perché le stagioni pittoriche che hanno visto protagonisti Piero della Francesca, Masaccio, Giotto, Giorgione non avrebbero corrispondenza in letteratura.
Semplicemente Moravia riteneva che alcuni Paesi fossero meglio rappresentati dalla letteratura, come nel caso della Francia, ed altri dalla pittura, come l’Italia. Ha sempre sostenuto che la cultura e la storia italiane vadano ricercate nell’arte e non altrove, perché le stagioni pittoriche che hanno visto protagonisti Piero della Francesca, Masaccio, Giotto, Giorgione non avrebbero corrispondenza in letteratura.
In generale è utile ricordare che nella sua attività giornalistica, nei suoi numerosi reportage, Moravia ricorre spesso all’arte per entrare nella storia di un Paese, per capirne aspetti altrimenti sfuggenti.
- Quali sono gli elementi dell’arte pittorica che hanno affascinato di più Moravia?
Come ho anticipato, Moravia valorizza l’aspetto misterioso e universale dell’arte, e insieme la sua polisemia, la capacità di andare ben oltre ciò che l’artista crede di avere espresso con la sua opera. Un quadro può conciliare le contraddizioni “senza sacrificarne alcuna”, catturando la complessità della vita. Inoltre nella collettività l’arte sa esprimere il represso sociale, come il sogno esprime l’inconscio del singolo: su questo concetto di evidente matrice freudiana si fonda l’interpretazione critica moraviana.
 - Quali sono state le sue predilezioni? Chi sono stati i pittori che ha ammirato di più?
- Quali sono state le sue predilezioni? Chi sono stati i pittori che ha ammirato di più?
Sarebbero molti i nomi da fare. Al di là di quelli che ho già fatto (Piero della Francesca, Masaccio, Giotto), nel pantheon artistico di Moravia figurano tra gli altri i preraffaelliti, i surrealisti, Rembrandt, Van Gogh.
- Al di là dell’ammirazione, chi sono stati i pittori che ha frequentato di più e con cui si è sentito maggiormente in sintonia?
Pochi scrittori come Moravia si sono circondati di artisti appartenenti a diverse generazioni e a diverse correnti. A partire dagli anni Trenta, molti sono i pittori che frequenta e su cui scrive. Nel periodo della gioventù ricorderei Carlo Levi e soprattutto Renato Guttuso, a cui rimane sempre legato da una profonda amicizia. Negli anni Sessanta frequenta artisti come Cremonini, Recalcati, Schifano che Moravia ammira sia per la pittura sia per il carisma che li contraddistingue.
- In che modo la pittura entra nella scrittura di Moravia? Viene in mente il romanzo “La noia“…
La contaminazione con la scrittura avviene in molti modi, ma due sono i principali. Innanzittutto la pittura, e in generale le arti visive, entrano nella pagina in forma di citazioni, palesi e nascoste, in molti casi determinanti anche per la struttura del racconto e del romanzo. Inoltre la scrittura adotta le coordinate della pittura – lo spazio, la luce, il colore, la prospettiva – per la descrizione degli ambienti e dei personaggi. L’opera di Moravia è uno straordinario inventario di ritratti.
Tra i personaggi-pittori vanno certamente ricordati il protagonista e l’antagonista della Noia (1960): con grande acume e prima di altri, attraverso le figure di Dino, un astrattista, e del rivale Balestrieri, un figurativo, Moravia rappresenta la crisi dell’artista e dell’intellettuale dentro la trasformazione del miracolo economico.
- Approfondiamo la conoscenza del libro dal punto di vista “strutturale”. Che tipo di criteri hai utilizzato nella scelta (e nell’ordine) dei testi da pubblicare?
Il volume raccoglie per la prima volta tutti i testi di Moravia rivolti alle arti visive. Questi sono ordinati cronologicamente in base alla data della prima uscita, riportata in calce a ogni scritto insieme alle successive riproposizioni. Ben si comprende come l’interesse per l’arte non si sia mai affievolito, dal 1934 al 1990, sino a pochi mesi prima della morte.
- Se tra i vari testi contenuti nel libro dovessi scegliere quello più “rappresentativo”, quale sceglieresti? E perché?
È molto difficile fare una scelta perché ogni testo ha un suo valore nella singolarità e nell’insieme. In questa occasione proporrei il primo testo, quello che Moravia dedica a Rembrandt nel 1934 dopo un viaggio in Olanda. Lo sceglierei per due motivi: esemplifica il modo con cui Moravia ricorre alla letteratura per decifrare l’arte; dimostra come sia possibile parlare della propria narrativa mediante la critica artistica. Attraverso le luci e le ombre di Rembrandt Moravia rinvia ai giochi chiaroscurali degli Indifferenti.
- Il volume contiene un importante corredo iconografico curato da Nour Melehi. Cosa puoi dirci da questo punto di vista?
Da subito si è pensato a un apparato iconografico per il volume. La curatrice, Nour Melehi, ha ben scelto di restituire con le immagini una rete di relazioni, l’“ambiente artistico” di Moravia. Le opere riprodotte sono suddivise in due blocchi cronologici – anni trenta-cinquanta e anni settanta ottanta – che identificano diversi momenti culturali e artistici, diverse frequentazioni. Guardando le opere, molte delle quali provengono dalla collezione di Casa Moravia, si ha la sensazione di entrare dentro il mondo artistico dello scrittore.
- Grazie mille, cara Alessandra.
* * *
Estratto da “Non so perchè non ho fatto il pittore. Scritti d’arte (1934-1990)” di Alberto Moravia (Bompiani, a cura di Alessandra Grandelis)
Rembrandt pittore dell’inquietudine
di Alberto Moravia
 Può darsi che sia ingiusto giudicare Rembrandt in termini che per comodità chiamerò letterari; e può anche darsi che ad uscire dal campo dell’indagine strettamente estetica si operi una confusione piuttosto che una chiarificazione. Ma il caso di Rembrandt è di quelli in cui questa confusione è necessaria e salutare perché corrisponde ad una confusione analoga nell’opera del pittore. Rembrandt non è infatti un pittore che si accontenti di trarre dalle sue riflessioni sulla vita soltanto dei pretesti per dipingere; né come accade per i primitivi italiani il sentimento religioso e morale si rasserena in lui in una narrazione distesa e ingenua. C’è invece in lui una curiosità, un’attesa, un’inquietudine messianiche di una profondità tutta sentimentale e fisica le quali come non sembrano accontentarsi nel campo morale della precettistica consacrata così nel campo pittorico non riescono mai a trovare figurazioni adeguate e definitive. In altri termini Rembrandt è per eccellenza il creatore senza catarsi e in questo senso potrebbe essere chiamato un romantico. Ma i romantici erano dei soggettivi e volentieri sacrificavano una realtà complessa e contradittoria all’espressione compiaciuta di un solo particolare, di un solo sentimento. In Rembrandt si notano invece, accanto ai più violenti sentimenti personali, un rispetto accanito e deliberato di ogni contraddizione, una perfetta onestà rappresentativa, una volontà insomma di non girare gli ostacoli, di non annullare i contrarii ma fonderli in una sola armonia; e questo è bene un assunto classico. Dal contrasto tra questo rigore del mestiere e il sentimento personale deriva la caratteristica maggiore di Rembrandt: d’essere insieme artista fantastico e realissimo, coi piedi ben fermi al suolo, l’occhio preciso, e l’attenzione studiosa e scaltra.
Può darsi che sia ingiusto giudicare Rembrandt in termini che per comodità chiamerò letterari; e può anche darsi che ad uscire dal campo dell’indagine strettamente estetica si operi una confusione piuttosto che una chiarificazione. Ma il caso di Rembrandt è di quelli in cui questa confusione è necessaria e salutare perché corrisponde ad una confusione analoga nell’opera del pittore. Rembrandt non è infatti un pittore che si accontenti di trarre dalle sue riflessioni sulla vita soltanto dei pretesti per dipingere; né come accade per i primitivi italiani il sentimento religioso e morale si rasserena in lui in una narrazione distesa e ingenua. C’è invece in lui una curiosità, un’attesa, un’inquietudine messianiche di una profondità tutta sentimentale e fisica le quali come non sembrano accontentarsi nel campo morale della precettistica consacrata così nel campo pittorico non riescono mai a trovare figurazioni adeguate e definitive. In altri termini Rembrandt è per eccellenza il creatore senza catarsi e in questo senso potrebbe essere chiamato un romantico. Ma i romantici erano dei soggettivi e volentieri sacrificavano una realtà complessa e contradittoria all’espressione compiaciuta di un solo particolare, di un solo sentimento. In Rembrandt si notano invece, accanto ai più violenti sentimenti personali, un rispetto accanito e deliberato di ogni contraddizione, una perfetta onestà rappresentativa, una volontà insomma di non girare gli ostacoli, di non annullare i contrarii ma fonderli in una sola armonia; e questo è bene un assunto classico. Dal contrasto tra questo rigore del mestiere e il sentimento personale deriva la caratteristica maggiore di Rembrandt: d’essere insieme artista fantastico e realissimo, coi piedi ben fermi al suolo, l’occhio preciso, e l’attenzione studiosa e scaltra.
La capacità di Rembrandt di sdoppiarsi e decentrarsi pur mantenendosi dentro i limiti di un mondo concreto è sbalorditiva e non trova riscontro che fuori della pittura, nell’opera di un romanziere come Dostoevskij o di un tragico come Shakespeare. In tutti i suoi quadri i particolari fuggono dal centro e tendono a vivere di vita loro, ogni figura va per conto suo, nulla le accomuna all’infuori di un giuoco abilissimo di luci e di tenebre che stanno lì ad esprimere quel generale e inscrutabile mistero che avvolge le troppe diversità della vita. Già nella prima versione della Lezione di anatomia il personaggio che sta ritto in piedi accanto la tavola non ha nulla a che fare con l’esanime carogna umana ritratta alla maniera del Cristo del Mantegna, di scorcio, col capo scotennato chino e avvolto in un’ombra grigia, una caverna verdastra al posto del ventre, e i lividi piedi divaricati e inerti. Nulla lega il personaggio al cadavere, né misericordia né curiosità scientifica, da una certa malinconica pensosità degli sguardi pare che egli rivolga la mente a cose tutte diverse da quelle che gli stanno sotto gli occhi. Nella seconda Lezione di anatomia la luce lunare che investe il cadavere è ben diversa da quella calda e serena che batte sui visi dei medici, niente potrebbe essere più sconcertante del contrasto tra quelle figure vive e ilari disposte come quelle di un banchetto moderno di fronte all’obbiettivo del più banale e convenzionale dei fotografi e la spoglia verdognola dalle occhiaie piene di ombra e dal rosso braccio sparato. Ma questa capacità sdoppiatrice e centrifuga raggiunge la sua espressione massima e più scomoda nel gran quadro della Ronda di notte. Di fronte a questa tela affollata e disordinata si capisce la perplessità del Fromentin, scrittore e pittore romantico ma critico di gusti classici, il quale senza tante ambagi la giudica un’opera slegata, incerta, e nel complesso fallita. E veramente, a prima vista, si è quasi tentati di dargli ragione tanta è l’incoerenza tumultuosa dei particolari, l’arbitrio dell’illuminazione, la maniera urtante e ingiustificata con la quale sono disposte le figure. Il quadro manca di centro, la soglia è nell’ombra, i due personaggi principali sono illuminati di sotto in su come dal fuoco di una ribalta, ci si aspetterebbe che l’oscurità riavvolgesse alle spalle di questi due personaggi tutto il rimanente del quadro, e invece, vista quanto mai strana, a sinistra dietro il capitano della ronda, avvolta in una luce folgorante e aurea, passa una figuretta puerile con una lanterna in mano e un pollo legato per le zampe alla cintura. Tutt’intorno questa immagine che col suo splendore rende il quadro singolarmente squilibrato e asimmetrico, le altre figure dei soldati sembrano, attraverso l’oscurità rossastra, voler uscire dai limiti stessi della cornice, noncuranti di ogni specie di rapporti coi capitani e con la personcina del pollo. Dicono che questo disordine sia destinato a dare l’impressione del trambusto di un allarme notturno in una piccola città. Quest’impressione c’è; come anche, con tante picche, tanti vessilli e tamburi, non si sa che tono strenuo e guerriero che ha fatto soprannominare il quadro una Marcia eroica; ma ciò non toglie che altri pittori hanno dato il senso della confusione marziale in ben altro modo, si pensi per esempio a Paolo Uccello, e che quell’accozzare insieme elementi eterogenei come i soldati e la figuretta del pollo, quel dare ad ogni personaggio una direzione diversa, quell’accendere luci dove dovrebbero essere ombre e viceversa è una caratteristica costante di Rembrandt.
 Rembrandt è il pittore della speranza e della riverenza di fronte al mistero. La maniera insieme attonita e avida con la quale nell’acquaforte famosa Faust vegliardo si leva pian piano dalla tavola a guardare l’insegna diabolica che risplende nella vetrata della finestra, rende da sola, e meglio che tutto il poema di Goethe, l’ansietà di palingenesi che torna a rinascere nell’uomo stanco e deluso. Altrove, nelle pitture e nelle acqueforti di argomento religioso questa speranza e questa riverenza si vedono chiaramente nelle tenebre fitte in fondo alle quali, abbaglianti di fulgore bianco, vagiscono e si dibattono i suoi brutti e umanissimi Gesù Bambini; nei vecchioni ammantati di magnifiche zimarre e sormontati di turbanti orientali che chinano le facce barbute su quel fulgore; nelle volte dorate e altissime che si intravvedono nell’ombra dietro quei personaggi. E a questo punto giova notare che il chiaroscuro di Rembrandt è assai diverso da quello poniamo di Caravaggio. Nel pittore italiano le luci e le ombre sono disposte con freddezza consapevole e sperimentale e si sente che le figure potrebbero benissimo svestirsi delle tenebre che le avvolgono; in Rembrandt invece il buio è caldo, grasso, ricco di riflessi rossastri e dorati.
Rembrandt è il pittore della speranza e della riverenza di fronte al mistero. La maniera insieme attonita e avida con la quale nell’acquaforte famosa Faust vegliardo si leva pian piano dalla tavola a guardare l’insegna diabolica che risplende nella vetrata della finestra, rende da sola, e meglio che tutto il poema di Goethe, l’ansietà di palingenesi che torna a rinascere nell’uomo stanco e deluso. Altrove, nelle pitture e nelle acqueforti di argomento religioso questa speranza e questa riverenza si vedono chiaramente nelle tenebre fitte in fondo alle quali, abbaglianti di fulgore bianco, vagiscono e si dibattono i suoi brutti e umanissimi Gesù Bambini; nei vecchioni ammantati di magnifiche zimarre e sormontati di turbanti orientali che chinano le facce barbute su quel fulgore; nelle volte dorate e altissime che si intravvedono nell’ombra dietro quei personaggi. E a questo punto giova notare che il chiaroscuro di Rembrandt è assai diverso da quello poniamo di Caravaggio. Nel pittore italiano le luci e le ombre sono disposte con freddezza consapevole e sperimentale e si sente che le figure potrebbero benissimo svestirsi delle tenebre che le avvolgono; in Rembrandt invece il buio è caldo, grasso, ricco di riflessi rossastri e dorati.
E, finalmente, Rembrandt è il pittore di un certo tipo di donna nella quale la bruttezza vergognosa, e talvolta persino sordida, è corretta dalla patetica tenerezza propria alle creature infelici. Le donne di Rembrandt hanno visi grossolani, seni penzolanti, ventri gonfi, natiche scure e informi, gambe tozze, ma sono atteggiate come se fossero bellissime, e nei loro volti c’è altrettanto pudore e altrettanta civetteria che nelle dee di Tiziano o di Palma. Stanno accovacciate presso bacini pieni di acqua sporca o sopra giacigli impuri, ma non c’è dubbio che siano ritratte con una sensualità precisa e perfettamente consapevole dei propri gusti. Sono donne quali le poteva immaginare un uomo lontano dai concetti classici e fortemente impastoiato nel terrore della colpa e della perdizione.
È oltremodo difficile dare una definizione esauriente di Rembrandt e della sua arte. Chiamarlo il pittore del chiaroscuro è ingiusto, tutti i suoi ultimi quadri sono in piena luce, e la ricchissima materia come qualche minerale prezioso a lungo giaciuto sottoterra e finalmente riscavato s’è liberata d’ogni nerume e non si giova d’altri contrasti che di quelli tra un volume e un altro, tra una faccetta di colore e un’altra. Perciò, dopo avere indicati i tratti essenziali e contradittorii della sua personalità bisogna dire che essa sfugge all’indagine critica come probabilmente sfuggiva a lui stesso. Pochi pittori infatti si sono autoritrattati quanto Rembrandt. Ma non v’è traccia nei suoi autoritratti del narcisismo esteriore che si nota per esempio negli autoritratti di Caravaggio o di Courbet. Ci sono invece una curiosità ansiosa, un dubbio malinconico, fin troppo immuni di qualsiasi compiacimento. Sono gli autoritratti di un uomo che sta solo davanti allo specchio, e tenta ogni via per conoscersi. L’ultimo di questi autoritratti, fatto poco tempo prima della morte, insieme con una furia pittorica straordinaria attesta questa inquietudine: vi si vede Rembrandt coi riccioli incanutiti e il viso arrossato e indurito dalla robusta vecchiaia. L’esame del quadro rivela una materia di una eccezionale complessità ora fluida ora raggrumata, intrisa di luce, violentemente plastica e voluminosa, la medesima, seppure più ricca, delle prime opere. E negli occhi e nella espressione del viso la medesima insoddisfatta domanda.
[Rembrandt pittore dell’inquietudine, “Gazzetta del Popolo”, 8 settembre 1934, p. 3]
(Riproduzione riservata)
© Bompiani – Gruppo Giunti Editore
* * *
 La scheda del libro
La scheda del libro
Scritti che permettono di comprendere come l’autore contamini arte e letteratura, letteratura e arte, tra potenzialità e limiti, allusioni, rimandi cifrati e dichiarati, capacità iconica di una lingua che rivaleggia con le altre arti nella rappresenzatazione del mondo
Alberto Moravia ha sempre dichiarato di preferire la pittura alla letteratura perché fatta di «colori e di forme» e non di un continuo «battagliare con le parole». Per questo motivo si circonda di artisti e per tutta la vita si dedica all’arte, come appassionato e come scrittore. Questo volume raccoglie per la prima volta la copiosa e pregevole produzione di argomento artistico: novanta testi, scritti tra il 1934 e il 1990, testimoniano l’interesse che Moravia ha sempre coltivato tanto per i classici quanto per i contemporanei e il suo sguardo acuto nei confronti dell’arte, attraverso cui parlare anche di letteratura e del mondo. L’introduzione di Alessandra Grandelis ricostruisce la formazione artistica di Moravia, i suoi legami, rievoca gli ambienti frequentati da pittori e scrittori e svela le costanti critiche e tematiche di questo saggismo da considerarsi parte integrante dell’opera. La raccolta è accompagnata da un apparato iconografico che propone una scelta delle opere prese in esame e alcune fotografie che illustrano il rapporto di Moravia con gli artisti.


* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo
Seguici su Facebook e su Twitter
Tags: alberto moravia, Alessandra Grandelis, bompiani, Non so perchè non ho fatto il pittore, Non so perchè non ho fatto il pittore. Scritti d'arte (1934-1990)
Scritto venerdì, 23 marzo 2018 alle 17:19 nella categoria SAGGISTICA LETTERARIA. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.









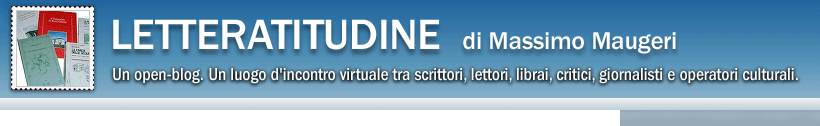














 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI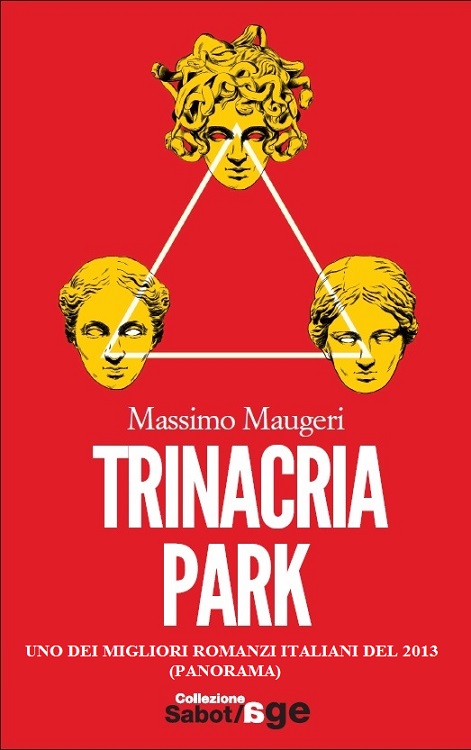
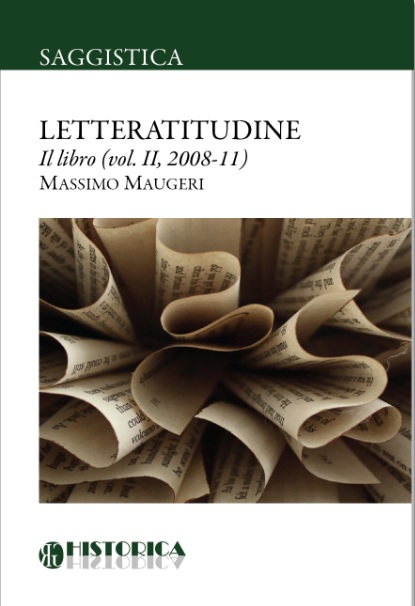


Commenti recenti