domenica, 30 novembre 2008
8 DOMANDE SU SCRITTORI E POLITICA, parte I
 Vi propongo un post in collaborazione con il trimestrale Nuovi Argomenti, fondato nel 1953 da Alberto Carocci e Alberto Moravia.
Vi propongo un post in collaborazione con il trimestrale Nuovi Argomenti, fondato nel 1953 da Alberto Carocci e Alberto Moravia.
Il numero dell’ultimo trimestre dell’anno scorso (n. 40, quinta serie, ottobre-dicembre 2007, “Moravia un secolo”) fu dedicato proprio ad Alberto Moravia in occasione del centenario (ne abbiamo discusso anche su Letteratitudine qui). Tra le altre cose, in quel numero, figura un interessante “questionario”. Premetto che il “questionario” è stato uno dei più caratteristici strumenti di indagine di Nuovi Argomenti sin dai suoi inizi. Il suo ideatore e promotore fu proprio Alberto Moravia. Anche per questa ragione, nel numero sopraindicato di NA, al sostantivo “questionario” è stato aggiunto l’aggettivo “moraviano”. Nella fattispecie alcuni scrittori contemporanei sono stati invitati a rispondere a otto domande sul tema “letteratura e politica”. In particolare: Rossana Campo, Paola Capriolo, Angelo Ferracuti, Giuseppe Genna, Nicola Lagioia, Valerio Magrelli, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Valeria Parrella, Antonio Pascale, Claudio Piersanti, Elisabetta Rasy, Roberto Saviano, Antonio Scurati, Walter Siti.
In questo post propongo a voi le prime quattro domande del “questionario”; le altre quattro ve le proporrò in un post successivo.
Vi invito a dare la vostra risposta, poi – tra un paio di giorni – inserirò le risposte fornite dagli scrittori interpellati, infine vi chiederò di individuare – tra le risposte degli scrittori – quella con cui vi sentite più in linea (o che sembra a voi più congeniale) spiegandone le ragioni.
Si tratta, per certi versi, di una sorta di gioco che offre una possibilità di confronto su un tema interessante.
Ne approfitto per ringraziare il poeta Carlo Carabba, nuovo capo redattore del trimestrale, per avermi inviato il “materiale” che troverete in questo post (autorizzandomi a pubblicarlo).
Ed ecco le prime quattro domande…
1. Ha senso oggi parlare di impegno per uno scrittore? Cioè esiste una responsabilità specifica degli scrittori in quanto scrittori?
2. Qual è oggi l’equilibrio possibile fra interessi privati e responsabilità collettiva?
3. Se il governo assume a tecnica politica l’organizzazione culturale, la partecipazione di uno scrittore, il suo impegno, non si riduce a un contributo più o meno significativo alla creazione del consenso?
4. Vi sentite più vicini al pragmatismo pessimista di Sciascia o all’indignazione lirica e visionaria di Pasolini di fronte ai guai della società italiana?
In merito alla prima domanda, “letteratura e impegno”, segnalo che in occasione della visita di Stato del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si sono aperti a Gerusalemme i «Dialoghi italo-israeliani» tra scrittori, critici, letterati e traduttori dei due paesi. Il tema degli incontri (che sono durati tre giorni e si sono conclusi il 27 novembre) è stato – appunto - «Letteratura e impegno». Vi riporto uno stralcio dell’intervento di Giulio Ferroni (nella foto), critico e storico della letteratura italiana (potete leggere il testo per intero sul sito del quotidiano “La Stampa”):
“I rivolgimenti che si sono dati alla fine del XX secolo e gli sconvolgimenti con cui ha avuto inizio il nuovo millennio hanno categoricamente smentito le ipotesi politiche e rivoluzionarie su cui si era a lungo sostenuto l’impegno degli intellettuali: e in molti casi hanno mostrato la natura illusoria e mistificatoria di quell’impegno, le contraddizioni e gli equivoci che lo costituivano. (…)
Insieme al crollo del comunismo sono crollati gran parte dei presupposti di quell’engagement, mentre si è data una vera e propria saturazione della modernità, interpretata in termini incongruamente ottimistici dagli apologeti del postmoderno, ma prolungatasi come frana, deriva, accelerazione indeterminata, incontrollabilità dei processi, rigurgiti di pregiudizi e fondamentalismi, intreccio perverso tra violenza e virtualità. In questo percorso [...] un autentico impegno non può coincidere più con la collaborazione ad un percorso storico, ad una tendenza o ad una linea politica, ma può svolgersi solo come conoscenza e testimonianza, ricerca di verità, lotta contro la saturazione del linguaggio, attenzione a vicende che riguardano luoghi concreti, situazioni specifiche, persone reali, a conflitti che chiedono una conciliazione, un arresto della violenza e dell’orrore. Responsabilità dell’intellettuale sarà allora in primo luogo, come ebbe a suggerire Elias Canetti, «responsabilità per la vita che si distrugge», impegno a dar voce alla resistenza dell’umano e della natura, alle ipotesi di equilibrio e di razionalità che si sono faticosamente costruite nei secoli, alla salvaguardia delle vite e degli spazi dalle oppressioni che le attanagliano e dalle molteplici minacce che gravano sulle esistenze individuali, sullo spazio civile, sull’ambiente sociale e naturale.
In questa chiave, l’impegno della letteratura si trova necessariamente ad essere «a parte»; non può mai risolversi nell’adesione a qualche gruppo precostituito; e tanto meno può porsi dalla parte del presunto cammino della storia, di quelle che i media considerano le tendenze vincenti, gli orizzonti del futuro. Lo scrittore non può condividere in nessun modo la sfrontata aggressività di chi, credendo di aver capito quali siano le tendenze profonde verso cui si muove il mondo, pretende di farsene carico, di cavalcare quel movimento verso il futuro. [...]
All’evanescenza del reale, alla difficoltà di percepirlo, corrisponde peraltro la difficoltà di identificare la verità, di intendersi su quale sia la verità: può essere allora molto rischioso postulare uno stretto collegamento tra impegno della letteratura e ricerca della verità, in un universo in cui tra l’altro sono in conflitto molteplici verità, che spesso si considerano nemiche, tendono a combattersi e reciprocamente ad annullarsi. La letteratura, proprio in virtù del sapere accumulato nel proprio passato, può dar luogo a sempre nuovi confronti con la pluralità e la relatività della verità, conducendo necessariamente ad un’apertura verso più verità date e verso più verità possibili: in una negoziazione tra verità, che non può prescindere da un’ottica critica, da uno sguardo critico agli effetti che ogni verità possono avere sulla vita, al suo possibile contributo alla sua difesa dalle minacce che su di essa incombono. Non la verità come distruzione (era il sogno di tanto nichilismo rivoluzionario che ha ancora accecati adepti), non la ricerca di una trasparenza assoluta rivolta a squarciare i fragili veli su cui si regge l’equilibrio delle società umane, ma una scommessa per una verità plurale che aiuti a resistere alla distruzione, a difendere la vita minacciata degli individui, dei gruppi sociali, dei popoli, dell’intero pianeta. (…)”
E ora… a voi, come sempre, la parola.
Massimo Maugeri
P.s. Segnalo inoltre questo sito su “Nuovi Argomenti” (che è però ancora in fase di costruzione).
____________________
____________________
AGGIORNAMENTO DEL 2 DICEMBRE 2008
Tempo fa mi ha scritto Sofia Assirelli, studentessa in Scienze della Comunicazione pubblica, politica e sociale dell’Università di Bologna:
Gentilissimo Massimo Maugeri,
mi chiamo Sofia Assirelli, sono una studentessa della Laurea specialistica in Scienze della Comunicazione pubblica, politica e sociale dell’università di Bologna. Per motivi di studio sto seguendo il progetto della collana editoriale Verdenero – Noir di ecomafia (www.verdenero.it) e delle attuali tendenze letterarie italiane nei confronti della società e dei suoi problemi.
Sarebbe molto interessante conoscere l’opinione dei lettori del suo blog su questa collana e in generale sul rapporto tra problemi sociali e romanzi o racconti di finzione. Pensa che sia possibile proporre una discussione di questo tipo?
La ringrazio per l’attenzione resto in attesa di un suo gentile riscontro.
Sofia Assirelli
A seguito di quella mail ho dato piena disponibilità a Sofia, invitandola a scrivere un “pezzo” che poi avrei utilizzato per avviare una discussione. Siccome questo post mi pare piuttosto “in linea” con la proposta della Assirelli, ho pensato di inserire il suo contributo qui di seguito (vi invito a leggerlo con attenzione):
 Se il romanzo possa o meno raccontare la società e le sue ombre più inquietanti è una domanda che ci si pone dal momento in cui, a fatica, il romanzo è riuscito a vincere le diffidenze legate al suo essere/non essere veritiero e ad affermarsi presso un ampio pubblico. Questa riflessione ha poi sempre trascinato con sé alcuni corollari concettuali che riguardano il rapporto tra finzione letteraria e realtà, il ruolo degli scrittori tra intrattenimento e denuncia, il discorso sui generi e le retoriche, sulle loro ibridazioni e convergenze. Scema però intanto sempre di più la diffidenza nei confronti della fiction in generale e aumenta la consapevolezza del suo potere seduttivo, tanto che essa viene sfruttata – e a volte abusata – come grimaldello per catturare l’attenzione delle persone negli ambiti più differenti. Tra questi si può anche considerare la comunicazione sociale che ha iniziato proprio recentemente ad apprezzare e studiare criticamente le implicazioni dell’utilizzo di meccanismi come la fiction teatrale o cinematografica per ottenere nuove possibilità di accesso al pubblico.
Se il romanzo possa o meno raccontare la società e le sue ombre più inquietanti è una domanda che ci si pone dal momento in cui, a fatica, il romanzo è riuscito a vincere le diffidenze legate al suo essere/non essere veritiero e ad affermarsi presso un ampio pubblico. Questa riflessione ha poi sempre trascinato con sé alcuni corollari concettuali che riguardano il rapporto tra finzione letteraria e realtà, il ruolo degli scrittori tra intrattenimento e denuncia, il discorso sui generi e le retoriche, sulle loro ibridazioni e convergenze. Scema però intanto sempre di più la diffidenza nei confronti della fiction in generale e aumenta la consapevolezza del suo potere seduttivo, tanto che essa viene sfruttata – e a volte abusata – come grimaldello per catturare l’attenzione delle persone negli ambiti più differenti. Tra questi si può anche considerare la comunicazione sociale che ha iniziato proprio recentemente ad apprezzare e studiare criticamente le implicazioni dell’utilizzo di meccanismi come la fiction teatrale o cinematografica per ottenere nuove possibilità di accesso al pubblico.
Ora anche la fiction letteraria si occupa di comunicazione sociale: di novità e particolare interesse risulta infatti essere il progetto VERDENERO ideato dalla casa editrice “Edizioni Ambiente”, che propone proprio di utilizzare testi di narrativa di finzione di grandi firme italiane (Macchiavelli, Vinci, De Cataldo, Colaprico, Dazieri, Wu Ming …), come parte di un progetto integrato di comunicazione in collaborazione con Legambiente, per sensibilizzare il più ampio numero possibile di persone su un complesso di fenomeni criminali poco conosciuti che rientrano sotto il termine di “Ecomafia”.
Le ragioni dell’interesse di questo progetto sono molte. Innanzitutto la sua origine: “Edizioni Ambiente”, casa editrice specializzata in saggistica di tema ambientale ed ecologico, si è trovata a pubblicare il “Rapporto annuale Ecomafia di Legambiente”, riconoscendolo come uno strumento di conoscenza eccezionale, giacimento di molte storie che però restavano quasi completamente inascoltate e ignorate. Felice intuizione di “Edizioni Ambiente” è stata di provare a fare raccontare da autori molto conosciuti del panorama letterario italiano le stesse storie con i meccanismi tipici della finzione letteraria. Un’altra particolarità riguarda il processo di creazione delle storie, dal rapporto Ecomafia all’invenzione artistica: la casa editrice propone agli autori le storie e li accompagna sia nel processo di definizione dei contenuti (seppur lasciando ampie libertà all’interpretazione dell’autore) sia per quanto riguarda la raccolta delle informazioni (“Edizioni Ambiente” fornisce agli autori reportage, articoli, ricerche, incontri con specialisti). Infine, un altro punto da sottolineare (anche se ovviamente l’interesse della collana non si esaurisce in questi tre punti) è l’integrazione e l’interrelazione dei romanzi con molti altri strumenti comunicativi (identità visiva e grafica forte, sito, blog, manifesti, merchandising, organizzazione di eventi) che rendono la collana sia oggetto di un efficace marketing editoriale sia uno dei motori attivi e propulsivi di un’ampia campagna di marketing sociale.
Questi e molti altri elementi, oltre alle dinamiche virtuose che questo progetto editoriale ha innescato e gli ottimi risultati (in termini di vendite, di attenzione mediatica, di apprezzamento della comunità degli autori e dei lettori ecc.) rendono il progetto VERDENERO un esempio da studiare attentamente in quanto si presenta come occasione per sollevare varie questioni e avanzare proposte operative per il futuro della comunicazione sociale. Quello che vi chiediamo è:
- Per chi ha letto uno o più titoli della collana, cosa ne pensate del progetto editoriale in generale e dei romanzi nello specifico?
- In che modo e con quali limiti i romanzi possono parlare dei problemi sociali?
- I romanzi possono essere strumenti di comunicazione sociale? Avete qualche esempio da portare?
(Sofia Assirelli) Ecco… vi sarei grato se poteste provare a rispondere alle domande di Sofia. Inoltre ne approfitto per invitare a partecipare al dibattito il dr. Alberto Ibba, direttore commerciale di “Edizioni Ambiente”. ————————————–
Paola Avidgor dell’ufficio stampa di Guanda, invece, mi segnala l’uscita dell’Almanacco Guanda 2008 curato da Ranieri Polese (è già in libreria dal 13 novembre).
L’Almanacco Guanda 2008 (Guanda, euro 22, pagg. 192) si intitola “Il romanzo della politica. La politica del romanzo” ed è perfettamente in linea con questo post. Esso intende esplorare il fenomeno recente di un ritorno dei narratori italiani a temi-personaggi-questioni di politica, a cui risponde, specularmente, un altro ritorno: quello del giornalismo politico d’impianto fortemente romanzesco.
All’interno del volume troverete una riflessione a più voci sul tema proposto, con interventi di Bruno Arpaia, Gianni Biondillo, Marzio Breda, Fulvia Caprara, Alberto Casadei, Roberto Casalini, Franco Cordelli, Andrea Cortellessa, Giancarlo De Cataldo, Mario Desiati, Paolo Franchi, Giuseppe Genna, Ranieri Polese, Alberto Rebori, Gaetano Savatteri, Corrado Stajano.
Approfondimenti… qui.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Massimo Maugeri
Tags: alberto moravia, Almanacco Guanda, Angelo Ferracuti, Antonio Pascale, Antonio Scurati, carlo carabba, Claudio Piersanti, Dacia Maraini, Elisabetta Rasy, giulio ferroni, Giuseppe Genna, letteratura e politica, Melania G. Mazzucco, Nicola Lagioia, nuovi argomenti, Paola Capriolo, questionario, Roberto Saviano, Rossana Campo, scrittori e politica, Valeria Parrella, Valerio Magrelli, Verdenero, Walter Siti
Scritto domenica, 30 novembre 2008 alle 01:07 nella categoria EVENTI, INTERVENTI E APPROFONDIMENTI. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.




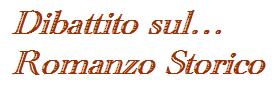
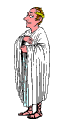
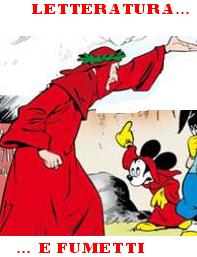


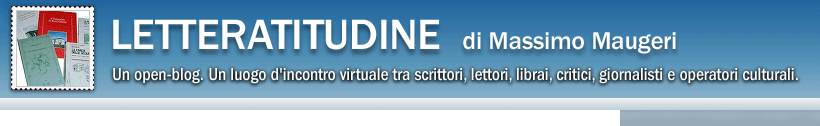














 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)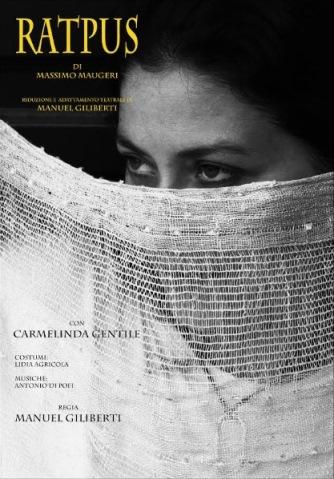

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI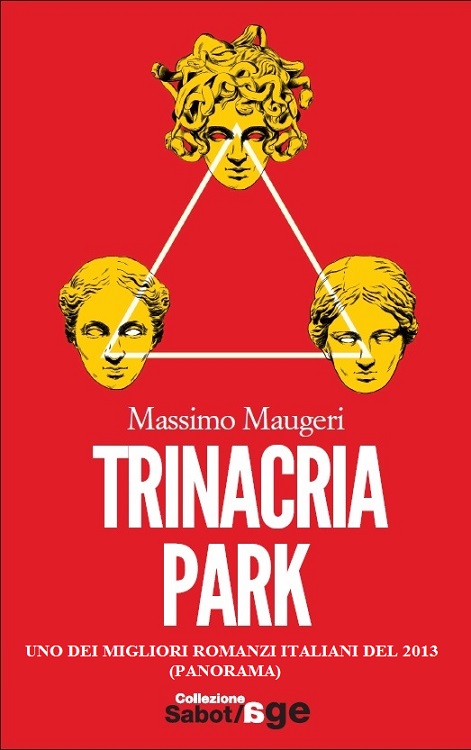
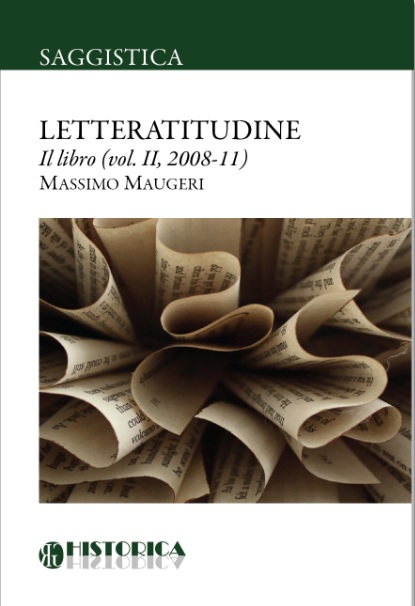
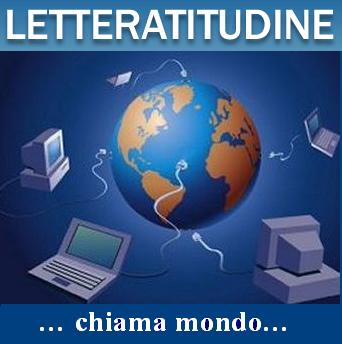
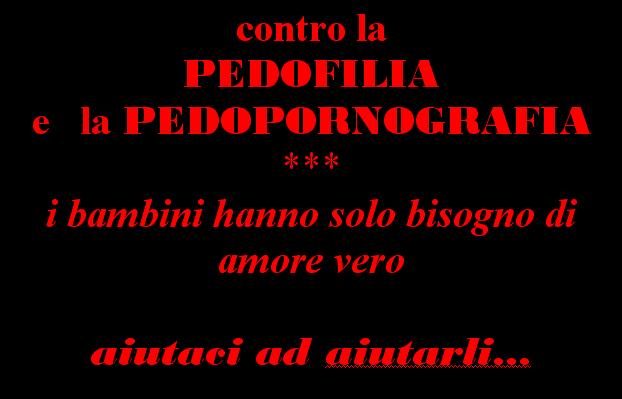
Commenti recenti