mercoledì, 30 novembre 2016
RAVEL di Jean Echenoz

Il nuovo appuntamento del forum di Letteratitudine intitolato “LETTERATURA E MUSICA” è dedicato al romanzo “Ravel” di Jean Echenoz (Adelphi – Traduzione di Giorgio Pinotti)
* * *
(Adelphi, 2007 - Traduzione di Giorgio Pinotti)
recensione di Claudio Morandini
 Jean Echenoz è riuscito, con il breve romanzo “Ravel”, a creare un’ingegnosa opera à la Ravel: nel senso che con precisione da compositore-orologiaio, con distacco, nonchalance, una facilità ingannevole, un calibrato rispetto di tempi e forme, ha costruito un libro in cui sembra davvero di ascoltare, convertite in parole, le musiche del compositore francese. La fine traduzione di Giorgio Pinotti per Adelphi preserva l’eleganza mai fatua e spesso tendente all’eccentrico dello stile raveliano di Echenoz.
Jean Echenoz è riuscito, con il breve romanzo “Ravel”, a creare un’ingegnosa opera à la Ravel: nel senso che con precisione da compositore-orologiaio, con distacco, nonchalance, una facilità ingannevole, un calibrato rispetto di tempi e forme, ha costruito un libro in cui sembra davvero di ascoltare, convertite in parole, le musiche del compositore francese. La fine traduzione di Giorgio Pinotti per Adelphi preserva l’eleganza mai fatua e spesso tendente all’eccentrico dello stile raveliano di Echenoz.
Ravel ci è restituito innanzitutto attraverso gli oggetti, i vestiti, i feticci di cui si circonda nella angusta e impossibile casetta di Montfort e con cui riempie le numerose valigie e bauli che lo accompagnano in tournée o in villeggiatura. L’omino Maurice, sotto quell’armatura di originale eleganza che lo protegge dalle insidie del mondo, è sempre inappuntabile, anche quando è in ritardo (cioè, sempre), e lo sarà anche negli anni del declino, quando perderà memoria e facoltà fisiche e intellettive e si aggirerà per concerti e vernissage scortato dagli amici più fidati che terranno lontani i cacciatori di autografi (ignari che il celebre compositore non sa nemmeno più scrivere il suo nome). È un mondo protettivo, di ninnoli, abitudini consolidate, sofisticati automatismi, squisitezze varie, una boîte à musique in cui anche il tormento dell’insonnia è sopportabile, anche le smemoratezze sembrano accettabili. Pare di sentir risuonare, in questo mondo ovattato e un po’ fuori dal tempo, le armonie raffinate e fintamente algide del “Tombeau de Couperin”, le fantasticherie rassicuranti e inquiete di “Ma mère l’Oye”.
A proposito: il sospetto di fatuità, di jeu un po’ fine a se stesso, di meccanismo alla fine disumano, che può cogliere il lettore alle prime pagine (o l’ascoltatore alle prime battute) svanisce ben presto: il romanzo di Echenoz, seguendo i movimenti di Ravel, da commedia brillante (la tournée negli Stati Uniti, la spossatezza caricaturale che coglie il compositore dinanzi a spostamenti in carrozze di lusso, gli entusiasmi iperbolici del pubblico di amateurs) si tramuta progressivamente in descrizione degli ultimi anni di vita, quelli della malattia, rimasta misteriosa, e dei vani tentativi di cura. Diventa, cioè, un vero e proprio tombeau, in cui l’imperturbabile, clinica precisione risulta paradossalmente toccante (e sfido chiunque a leggere l’ultima parte senza magone).
C’è molta musica, ovviamente, nel breve romanzo di Echenoz. Ravel all’epoca è uno dei compositori più apprezzati al mondo, lo si pone accanto a Stravinskij, in lui il brivido della modernità e della sfida si concilia sempre con uno charme che sa sedurre le masse, spaventate invece dalla piega che ha preso altra musica moderna. È così autorevole che, di fronte agli attacchi dei più giovani leoni del gruppo Les Six, in particolare di Milhaud e Auric, reagisce con superiore tolleranza, e anzi con simpatia e comprensione. La musica, che pure è la sua vita, ed è parte fondamentale della sua persona, non è sempre al centro dei suoi pensieri: a volte, vinto da una sorta di superiore indolenza, Ravel resta inerte, cincischia, si perde senza grande convinzione dietro a progetti che non porterà a termine. Il suo rapporto con la tradizione è fondato su una sorta di singolare sfida: con le forme (trio, quartetto, sonata) “salda i conti” affrontandole una volta sola, in opere uniche che suonano come suggelli definitivi. Solo con il Concerto per pianoforte la sfida è duplice, tant’è che verranno tormentosamente composti negli stessi mesi due concerti, uno in Re maggiore per la mano sinistra (commissionato da Paul Wittgenstein, che lo eseguirà strapazzandolo in modo insopportabile per il compositore) e l’altro in Sol.
Anche il rapporto con gli interpreti merita qualche riga. Ravel, che predilige una lettura fedele, perfettamente calibrata delle sue opere, detesta le personalizzazioni di Wittgenstein, i virtuosismi rodomonteschi che distorcono e rompono la tensione in perfetto equilibrio tra strumento solista e orchestra; e detesta pure il “Bolero” velocizzato e accelerato sotto la direzione di Toscanini (si ascolti la vecchia incisione del 1930 in cui Ravel dirige la propria opera più famosa: la lentezza garantisce cesello su ogni singola nota). Egli stesso, però, quando non può farne a meno, si presta a esecuzioni approssimative delle sue opere pianistiche, perché pianista non è e ciò che scrive per il pianoforte è spesso al di là delle sue possibilità tecniche: confida, in tali casi, sull’indulgenza, la disattenzione o l’incompetenza del pubblico.
Affascinato dalla meccanica, concepisce la musica come un linguaggio puramente formale, in cui tout se tient – in questo è vicino al concetto di musica assoluta che in quei decenni era rappresentato da compositori come Stravinskij o Hindemith. Tutto è forma, dosaggio, equilibrio, struttura, nel meccanismo che è un pezzo musicale, nel gioco serio e svagato che è la musica. La musica è motore in movimento, orologio, nave, treno (sempre di prima classe, naturalmente): da qui nasce anche l’idea (impossibile, provocatoria, allora) di un pezzo privo di sviluppo in senso musicale ma tutto giocato sulla ripetizione, melodica e ritmica, in cui solo il timbro (l’orchestrazione di cui Ravel era maestro) cambia e crea movimento (il “Bolero”, appunto). En passant, vi sono anche studi, che Echenoz per fortuna non cita, in cui neurologi interpretano i diversi aspetti della musica di Ravel, e del “Bolero” in particolare, come sintomi di differenti neuropatie: ma lasciamo stare.
Il processo compositivo è ben raccontato da Echenoz, che riprende quanto confidato (con qualche esagerazione) da Ravel durante una conferenza a New York: il compositore resta a pensare a lungo, anche per anni, senza scrivere una sola nota, e intanto le idee germinano nella sua mente un po’ alla volta, e solo dopo che si sono adattate in una struttura arriva il momento della stesura, che può essere anche rapido e coincide sempre con la fase della ripulitura, della sottrazione del superfluo. Non crede nell’ispirazione, Ravel, la tastiera (quella vera del pianoforte, o quella immaginaria sempre aperta nella mente) è tutto. Nemmeno la natura sembra offrire motivi di ispirazione: mentre contempla l’orizzonte marino dal ponte della nave che lo porta in America, Ravel prova a tradurre la superficie del mare in una linea melodica o in un ritmo, ma desiste subito, per noia e per scetticismo. Né sembra aver dato risultati più duraturi la trascrizione del canto degli uccelli compiuta in certi momenti di inerzia della Prima Guerra Mondiale, quando Ravel, spinto da un sentimento di sincero patriottismo che sorprese molti e che ha il sapore di un beau geste, era riuscito a farsi arruolare come autista di mezzi pesanti.
* * *
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo
Tags: Adelphi, Jean Echenoz, Ravel
Scritto mercoledì, 30 novembre 2016 alle 15:00 nella categoria LETTERATURA E MUSICA. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.









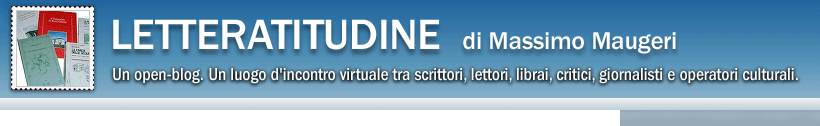














 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI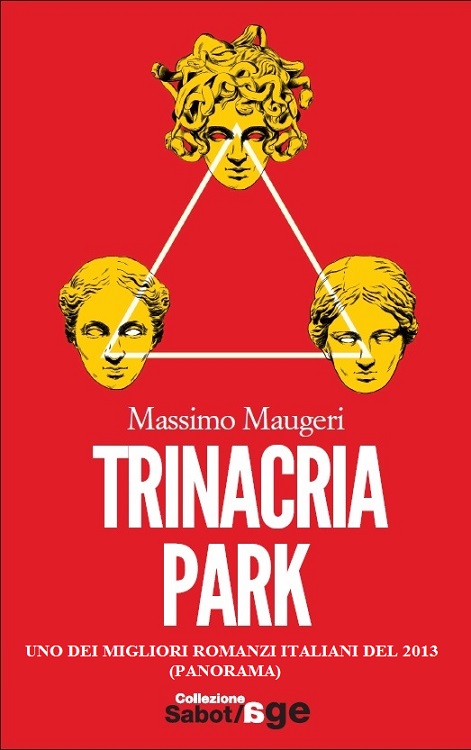
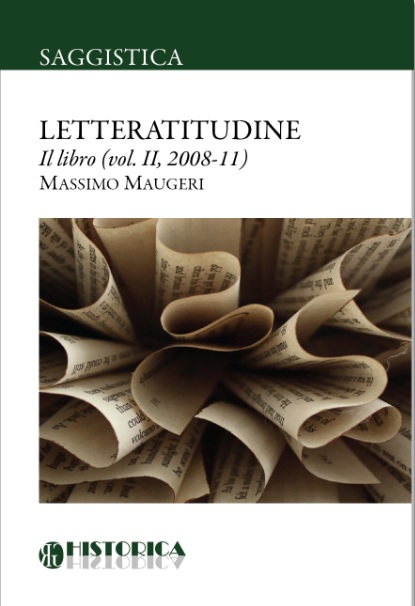


Commenti recenti