mercoledì, 15 luglio 2020
OMAGGIO A SEBASTIANO ADDAMO
 In occasione del ventennale della morte di Sebastiano Addamo (Catania, 18 febbraio 1925 – Catania, 9 luglio 2000) mettiamo in primo piano questo post (con relativo dibattito online) incentrato sull’opera principale dello scrittore catanese: “Il giudizio della sera”
In occasione del ventennale della morte di Sebastiano Addamo (Catania, 18 febbraio 1925 – Catania, 9 luglio 2000) mettiamo in primo piano questo post (con relativo dibattito online) incentrato sull’opera principale dello scrittore catanese: “Il giudizio della sera”
* * *
IL GIUDIZIO DELLA SERA di Sebastiano Addamo
È arduo pensare di riproporre ai lettori di oggi un romanzo uscito senza alcun clamore 35 anni fa. Arduo se non altro perché le novità editoriali sono tante da creare tempeste sui banconi dei librai. Eppure la qualità letteraria di alcuni vecchi libri è tale da giustificare l’azzardo.
Con queste parole Matteo Collura inizia la recensione del romanzo “Il giudizio della sera”, di Sebastiano Addamo (nella foto), ripubblicato da Bompiani nel 2008 a cura di Sarah Zappulla Muscarà (originariamente pubblicato, nel 1974, da Garzanti).
Poi, lo stesso Collura, nella suddetta recensione (pubblicata sul Corriere della Sera del 14 ottobre 2008) conclude: Non è da credere in un successo postumo di questo narratore, che fu preside di liceo e fine intellettuale, ma in una sua giusta collocazione nell’ambito dei valori letterari del secondo Novecento italiano, sì. E va dato atto alla Bompiani di tentarci (…).
Sebastiano Addamo, mio conterraneo, è nato a Catania, nel 1925 e ivi si è spento nel 2000. Non lo so se – riprendo le parole di Collura – il successo postumo arriderà ad Addamo, ma (nel mio piccolo) avverto l’esigenza di fare quanto possibile per divulgare la conoscenza di questo autore e delle sue opere; proprio a partire da questo romanzo: “Il giudizio della sera”.
Sulla nota in quarta di copertina del libro, leggiamo quanto segue: “Narratore, poeta, saggista, Sebastiano Addamo ha percorso un cammino coerente, sostenuto sempre da rigore stilistico e morale. È l’universo siciliano a nutrire l’immaginario dello scrittore, che già pienamente si esprime in questo romanzo di formazione, toccando corde tematiche di grande intensità emotiva: il viaggio di conoscenza reale e simbolico di cinque adolescenti. La Catania di Addamo non è quella “molle e pastosa” che da l’impressione di “camminare in mezzo al sole” di Vitaliano Brancati, né quella aperta sul mare, “luccicante sotto il sole a picco” di Ercole Patti, ma quella misera, squallida, del quartiere della prostituzione, teatro della guerra e del fascismo. Un quartiere che diviene il simbolo del degrado del nostro tempo.”
Vi invito a leggere questo post, e a discutere di questo libro e della figura Sebastiano Addamo, partendo dai contributi che troverete di seguito: la recensione di Laura Marullo (che mi darà una mano a coordinare e a moderare il post), quella – già citata – di Matteo Collura e la prefazione della curatrice del libro: Sarah Zappulla Muscarà.
Inoltre, come sempre, mi piacerebbe avviare una discussione parallela a quella sul libro. Mi colpisce molto il titolo di questo romanzo di Addamo (Il giudizio della sera). Un titolo che – come meglio evidenziato dai contributi a seguire – ha una forte valenza “nicciana”.
A me il giudizio della sera evoca l’immagine di uno specchio in cui ciascuno di noi – volente o nolente – è costretto a guardarsi… alla fine di un giorno della nostra vita, o di un periodo, o di un’esistenza intera.
Vi chiedo di affondare lo sguardo in quello specchio e vi domando (domanda difficilissima): qual è il giudizio della vostra sera?
(chi avrà il coraggio di rispondere?)
E poi (domanda più generica): il giudizio della sera è più un trampolino di lancio o un ostacolo per il giorno (o il periodo) che verrà?
Attendo i vostri contributi.
Massimo Maugeri
* * *
Sebastiano Addamo, “Il giudizio della sera”, a cura di Sarah Zappulla Muscarà, Milano, Bompiani, 2008, pp. 159.
recensione di Laura Marullo
Una deflagrante ansia di annientamento sottende il vitalistico moto di rivolta di cinque adolescenti lentinesi contro la tanatofila “era dei Padri” di una Catania asservita al fascismo e sconciata dal secondo conflitto mondiale nel romanzo di Sebastiano Addamo “Il giudizio della sera”, apparso da Garzanti nel 1974 ed ora pubblicato per i tipi di Bompiani a cura di Sarah Zappulla Muscarà. Un’opera di rilevante interesse nell’ambito della letteratura siciliana di fine secolo per avere indagato, con impietoso mordente demistificatorio, la crisi dei sistemi di valore di una società e di un’intera epoca, la delusione ideologica del Novecento che apre inaspettatamente alla speranza sia pure attraverso la freudiana esperienza, dolorosa ma necessaria, del “parricidio”. Vi riconduce il nicciano titolo che, per il tramite dell’ambigua immediatezza dell’aforisma, forma prediletta perché assiduamente praticata da Addamo, immette nella dimensione dell’attivismo superomistico che invita a superare l’inquietudine esistenziale provocata dalla guerra ed affermare l’esigenza di un radicale rinnovamento etico.
Romanzo di formazione in cui fa incursione l’autobiografia, “Il giudizio della sera” ripercorre il tortuoso itinerario di conoscenza dei giovani protagonisti, Gino, “alter ego” dello scrittore, Pippo, Carletto, Gianni e Morico, in un’avventura vitale alla scoperta del sesso che si contrappone allo scenario di “morte immanente” di cui è espressione il capillare luridume del quartiere a luci rosse di San Berillo, “regno delle prostitute”, dove aleggia “odor di cesso e di piscio di gatto […], odore di putrefazione e di liquami infetti”, funerea metafora del degrado materiale e morale di un “mondo borghese che ancora non sapeva di contemplare la propria morte”. Come sottolinea la curatrice nel lucido saggio introduttivo, “l’istintualità esuberante, il febbrile desiderio di sperimentazione fortemente collide con la sempre più stagnante, fatiscente, truce atmosfera cittadina soffocata dal giogo del fascismo e della guerra”. Immersa nel torpore e nell’indolenza, la “vecchia siciliana malinconia della morte e del disfacimento”, in quell’oblomovismo che afferma l’esistere astenendosi dall’agire, la Catania di Addamo, materica più che immaginifica, esibisce i sintomi di quella letale “malattia che era la guerra” già impressi sui volti di un’umanità derelitta, di esseri disperati preda di un’ancestrale inedia, in cui la reificazione e la mercificazione sanciscono l’alienazione e l’angoscia del nulla. Ne emerge un’antropologia negativa, ritratta con cruda deformazione espressionistica ma sempre con forte partecipazione emotiva, in cui orde fameliche di prostitute sciamano, lasciando echi lugubri e perverse, lungo le vie del sesso, via delle Finanze, via Coppola, via Di Prima, via di Sangiuliano, imbrattate di quel “vasto putrescente addobbo escrementizio” che è a un tempo simbolo e rifiuto della guerra: “Tutto divenne guerra. […] Sopravvenne l’odore di piscio. Inopinatamente, senza alcun preavviso, dilagò, s’impose, si impossessò della città. […] La guerra dilagò con tale odore”. È una ferale sociologia degli odori quella di cui si serve Addamo per mostrare le ferite suppuranti di una città ammorbata e ribadire il suo atto di accusa nei confronti delle distorsioni del potere e dell’abiezione della guerra. Ma la guerra, osserva acutamente Sarah Zappulla Muscarà, “non è quella di lunghe, inespugnabili trincee, di mirabolanti avanzate, di manovre vittoriose propagandate da mendaci bollettini del regime. […] È quella delle ‘carte da lutto’ affisse alle porte delle vedove ridotte alla prostituzione, dei volti sformati, disperati di creature forsennate”.
Accentuando una disposizione analitica favorita dal fertile humus di Lentini, patria di Gorgia, Sebastiano Addamo, “poeta-pensatore” come non a caso lo definì Leonardo Sciascia cui lo unì una comunione d’intenti letterari ed esistenziali, l’impegno civile, la tensione morale, il pessimismo ontologico, armato degli strumenti della riflessione filosofica, evidenti in un tessuto narrativo intramato da un fitto citazionismo puntualmente decriptato dalla curatrice che ne individua la fonte nell’opera di Kirkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Heidegger, Husserl, Sartre, fra gli altri, ingaggia una strenua lotta di liberazione da tutte le forme di ipocrisia sulle quali ha allignato la civiltà occidentale e la cultura meridionale. Lo documenta la dissacrazione di archetipi a falsi miti di cui è sconcertante metafora l’insano amplesso del giovane Gino con la degenere, laida figura materna della padrona della squallida pensione e infine lo scenario apocalittico del bombardamento aereo su Catania che traduce l’attesa palingenetica di un mondo migliore da quello consegnato dai Padri.
L’ironia provocatoria, il raziocinare pensoso, il moralismo risentito, innervano un impianto narrativo sdoppiato nei piani paralleli della memoria e della riflessione, destrutturando la tradizionale forma romanzesca mediante l’intervento di “chiose spiegative” che, come un manzoniano “cantuccio dell’autore”, danno voce al grido di protesta di quei “chierici traditi”, quegli intellettuali ai quali, ribadisce lo scrittore, bisogna “guardare per sapere quale è la posizione più utile”.
Sospinto da un sentimento di “laica trascendenza” che miri alla rivelazione dell’“oltre” a partire dall’oscurità in cui vive l’uomo moderno in seguito al crepuscolo degli idoli, come il nicciano viandante con la lanterna in mano, Sebastiano Addamo stana, lumeggiandola con i lampi della sua scrittura, la scotofilia di anonimi piccolo-borghesi, sempre animato dal raggiungimento di un superiore imperativo etico che dà corpo alla cifra stilistica di tutta l’opera sua.
Laura Marullo
—————
Addamo, la Sicilia come filosofia
di Matteo Collura
da il Corriere della Sera del 14-8-2008
È arduo pensare di riproporre ai lettori di oggi un romanzo uscito senza alcun clamore 35 anni fa. Arduo se non altro perché le novità editoriali sono tante da creare tempeste sui banconi dei librai. Eppure la qualità letteraria di alcuni vecchi libri è tale da giustificare l’ azzardo. È il caso del breve romanzo di Sebastiano Addamo dal bel titolo Il giudizio della sera, pubblicato da Garzanti nel 1974 e ora ristampato da Bompiani (pp. 159, 8,60), con una nota critica di Sarah Zappulla Muscarà, cui certamente si deve la riproposta. Addamo racconta di una comunità siciliana negli anni della Seconda guerra mondiale vista con gli occhi di alcuni adolescenti. Una sorta di romanzo di formazione, dove prevale l’ abilità narrativa, senza eccessivi ricami e tuttavia complessa, piena, fortemente evocativa e in grado di restituire il senso di un momento storico in quel particolare luogo, Catania. Niente a che vedere – sia ben chiaro – con Brancati o con Ercole Patti o con Vittorini (e facciamo questi nomi perché il luogo di cui Addamo racconta è una città della Sicilia orientale e perché nella scoperta del sesso, evento centrale nel romanzo, si potrebbe pensare al Garofano rosso); niente a che vedere altresì con i narratori siciliani oggi più presenti nell’ attenzione dei lettori e della critica. Con questo romanzo, Sebastiano Addamo riesce a dare – ecco giustificata appieno la scelta della casa editrice Bompiani – un ritratto primigenio dell’ isola e nello stesso tempo attuale: di una attualità chiarificatrice per chi vuol darsi la pena di capire la patria di Gorgia e di Pirandello, oltre che gustarla nel suo sconcertante esotismo. In questo romanzo troverete inserti o pause esplicative non dico indispensabili, ma certamente utili a meglio comprendere la contorta filosofia siciliana, mostrandola nelle sue semplici impalcature primitive. Un esempio: «Al mio paese, ma in molti paesi, e specie del Sud e della Sicilia, come c’ era un fascismo d’ accatto, miserabile, fatuo e minchionesco, così c’ era un’ opposizione pure d’ accatto, molto misteriosa, quasi inutile, risentita, e sia pure onesta. Ma come il marxismo fu la coscienza del proletariato e diventò la coscienza per la stessa borghesia – il neocapitalismo cosiddetto che cosa è, se non appropriazione e uso del marxismo ma nel senso contrario? -, così, all’ inverso, un sistema ridicolo e imbelle produce un’ opposizione se non ridicola certo imbelle». O ancora: «Nella prevalenza della natura c’ è esattamente il limite della storia. Forse per questo la Sicilia sta ancora attendendo la “sua” storia». Ecco, forse Corrado Alvaro può andar bene se proprio si vogliono trovare apparentamenti all’ autore del Giudizio della sera, o Sebastiano Aglianò, cui dobbiamo la sempre utile inchiesta rudemente intitolata Che cos’ è questa Sicilia?. Anche se nella descrizione delle plebi catanesi e delle prostitute sospinte nel baratro dell’ abiezione si coglie una luciferina cifra narrativa che potrebbe far pensare a Curzio Malaparte. Ma Addamo – e si vedrà meglio se altri suoi libri verranno riproposti – ha lasciato una sua personale impronta letteraria. Alcuni suoi titoli vanno ricordati: Un uomo fidato, 1978; I mandarini calvi, 1978; I chierici traditi, 1978; Le abitudini e l’ assenza, 1982, Palinsesti borghesi, 1987. Carlo Bo, esattamente trent’ anni fa, annotava: «Addamo è uno scrittore che aspetta ancora il suo momento, un momento che forse non verrà mai, data la natura del giuoco letterario predominante e dato anche il carattere estremamente riservato dello scrittore». Non è da credere in un successo postumo di questo narratore, che fu preside di liceo e fine intellettuale, ma in una sua giusta collocazione nell’ ambito dei valori letterari del secondo Novecento italiano, sì. E va dato atto alla Bompiani di tentarci, così come sta facendo con altri autori per fortuna tra noi, come Giuseppe Bonaviri di cui sono appena usciti i racconti fantastici raccolti sotto il titolo L’ infinito lunare (p. 288, 9,20).
Matteo Collura
———————————————-
Come i neofiti dell’oscuro
di Sarah Zappulla Muscarà
“Il giudizio della sera. Chi ripensa all’opera della sua giornata e della sua vita, quando è arrivato stanco alla fine, giunge di solito ad una malinconica considerazione: tuttavia la colpa di ciò non sta nel giorno e nella vita, bensì nella stanchezza. Immersi nell’attività, non abbiamo di solito il tempo per esprimere giudizi sulla vita e sull’esistenza, e neppure quando siamo nel pieno del godimento: ma se una volta arriviamo a far ciò, non diamo più ragione a colui che ha aspettato il settimo giorno e il riposo per trovare molto bello tutto ciò che esiste, – egli ha perduto il momento migliore”. Così Friedrich Nietzsche con la frantumazione, l’ambiguità, l’immediatezza dell’intuizione dell’aforisma che è, osserva Sebastiano Addamo, “come il lampo nella notte: la illumina vivissimamente, ma subito dopo rende il buio più denso e compatto”.
Dettato da acre riflessione critica sulla condizione della società italiana sconvolta dalla drammaticità degli eventi bellici del secondo conflitto mondiale, dall’esigenza di fornire una risposta all’angoscia nichilista e all’inquietudine esistenziale scaturite dal disfacimento etico, ideologico e religioso dell’Occidente, metafora della negazione della cultura dei padri, dell’alienazione e della reificazione, Il giudizio della sera (apparso per la prima volta nel 1974, per i tipi di Garzanti) è dolente allegoria della variegata fenomenologia umana contemporanea sospesa in perpetuo travaglio tra bene e male, luce e buio, slancio vitale e meditazione sul nulla. Una dialettica di antinomie tesa a superare il pessimismo, il male di vivere, la crisi del potere con i suoi frutti avvelenati, per affermare l’esigenza di un radicale rinnovamento, di un energico ribaltamento di valori, contrapporre con Albert Camus al mito di Sisifo l’uomo in rivolta, addomesticare l’“assurdo”, sancire la fine di un’epoca e il palesarsi di un’altra. Per non perdere “il momento migliore”. Fosse pure quello del “parricidio”.
Sorretto da salda cultura filosofica e letteraria, lucida, cartesiana razionalità, sfiduciata visione del mondo, Sebastiano Addamo, d’impervia e contratta malinconia, ripercorre, con occhi invasi di smagato, irredimibile risentimento, il viaggio di conoscenza reale e simbolico di cinque adolescenti siciliani, braccati dai demoni di una città e di un presente di illusori miraggi, che si traduce in una vera e propria discesa agli inferi.
Al Bildungsroman, romanzo di formazione e generazionale, in Il giudizio della sera si affianca, in termini manifesti, la prospettiva dell’autobiografia. Gino, alter ego dello scrittore, Pippo, Carletto, Gianni, e Morico, abbandonata Lentini per seguire gli studi liceali a Catania, avviano un tortuoso processo di crescita attraverso l’impatto con le due traumatiche esperienze della sessualità e della guerra.
Stagliata sullo sfondo delle tiepide atmosfere serotine di un “ridolente autunno”, immota nel pantano di un’atavica, secolare ignavia, sonnecchiante in “quel tempo friabile”, in quella vita “eterna”, ingannata dalle menzogne del fascismo, oltraggiata dalla crescente miseria, violata dalle bombe, Catania, dapprima “tenera e profonda”, poi “tetra e raggomitolata”, è teatro del rituale di morte e risurrezione di una cultura e di una società, scenario apocalittico di una “laica Pasqua” (Vincenzo Consolo), di un canto del cigno di quel “mondo borghese che ancora non sapeva di contemplare la propria morte”. Quel “mondo borghese” che s’accampa con insistenza opaco nella narrativa successiva dello scrittore, da Un uomo fidato a I mandarini calvi a Palinsesti borghesi.
L’istintualità esuberante, l’ebbrezza dionisiaca, il febbrile desiderio di sperimentazione dei giovani protagonisti fortemente collide con la sempre più stagnante, fatiscente, truce atmosfera cittadina soffocata dal giogo del fascismo e della guerra, segnata dal degrado materiale e morale. Ma è un mesto picarismo la brama di conoscenza filtrata dalla spasmodica ricerca del sesso. Alle scorribande notturne, alle ricognizioni fugaci, ai primi acerbi approcci si alternano malinconiche riflessioni, enigmatici dubbi, dilanianti interrogativi da cui erompe l’aspirazione al cambiamento che si fa rabbia, l’energia distruttrice che si fa ribellione, l’apertura alla speranza che si fa attesa palingenetica. La storia “è solo un’occasione, che si tratta di rendere feconda con una rivolta vigile”, ancora con Camus. È il cruento trapasso generazionale dall’“era dei Padri” all’“età del parricidio”. L’acquisizione della maturità – “imparare il mondo” – di Gino si consuma infatti tra le macerie di una umanità corrotta e corruttrice, sotto un bombardamento che si traduce in atto di accusa di ogni totalitarismo familiare, politico, etico, dando corpo all’angoscia di annientamento sottesa al tragico sentimento della “morte immanente”.
Scaturita dall’incandescente rovello filosofico sul disagio della civiltà conseguente alla crisi dei sistemi di valore, l’analitica esistenziale di Addamo, nel solco del pensiero di autori a lui cari, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Heidegger, Husserl, Sartre, fra i principali, ma pure intrisa della linfa della consuetudine mediterranea alla riflessione, si dispiega in termini demistificanti. Una demistificazione di pregiudizievoli, vetusti retaggi culturali finalizzata alla conquista del senso autentico dell’individualità al di là di ogni pastoia. È la “lacerazione del velo di Maya” di cui parla Schopenhauer, la necessità di sollevare la spessa coltre di inibizioni, districare l’intricata tramatura di falsi miti che bloccano, mortificandone lo spirito dionisiaco, le pulsioni vitali e la tensione conoscitiva verso l’essenza più profonda dell’uomo.
Si dipana nei meandri della geografia dell’“oscuro” l’itinerario gnoseologico tracciato dall’autore secondo cui l’uomo è “origine e nulla” e la contemporaneità “il luogo per ogni anacronismo”. In un’epoca lacerata dal nicciano grido “Dio è morto”, compito dello scrittore non è “tranquillizzare”, bensì “inquietare”, scuotere dal torpore di metafisiche certezze, ma soprattutto, “contaminandosi con la laidezza quotidiana, fraternamente coinvolta nella rissa giornaliera degli uomini”, rivelare “l’oscurità che è nell’uomo, nei suoi gesti, nel suo tessuto emozionale” e restituire infine “la vigile inquietudine per una realtà altra”. In precario equilibrio sull’incerto discrimine fra narrazione realista e saggio filosofico, percorso da un sentimento di “laica trascendenza”, Il giudizio della sera è animato da quella spinta verso l’“oltre” che è a un tempo deiezione del principio heideggeriano dell’“essere” e dolorosa coscienza del nulla, dell’“essere-per-la-morte”.
Acuita da vigile percezione sensoriale, l’attività euristica dei giovani adolescenti approda alla sinistra consapevolezza del potere “nientificante” della morte. È soprattutto l’odorato ad incidere più profondamente nella sfera psichica penetrando fino alle radici della vita. “Il naso, che è veicolo o tramite” presiede infatti alla scoperta dell’orrore per la condizione stessa dell’esistere. Agente di un processo di trasferimento di senso che rinvia a precisi significati metaforici, l’odore acquista un’importanza primaria nel modello di scepsi delineato da Addamo, che scoperchia il maleodorante quartiere di San Berillo, dove aleggia “odor di cesso e di piscio di gatto”, “odore di putrefazione e di liquami infetti”. L’odore tristo, fetido, turpe, individua “l’evento”, eccita gli impulsi sessuali, palesa la guerra. Ne guizzano funebri lampi di “cedimento, corruzione, abominio, disordine e talvolta anche rivolta” (Oltre le figure). Il puzzo, che già con Dante “’l profondo abisso gitta”, è sublimazione di “terrori senza speranza”. Evoca “l’oscuro, l’infero”. Certifica il decesso. È l’“olor de la muerte” di Ernest Hemingway. Ha valenza teologica, testimoniando il “giudizio di Dio”, secondo Fedor Dostoevskij.
Un nauseabondo, funereo lezzo di decomposizione soffia nel quartiere di San Berillo, “regno delle prostitute”, “vecchie, giovani, scarmigliate e feroci”, “melma oscena, tenebrosa e virulenta di un torrente che però […] nasceva certo dall’Es singhiozzante e spasmodico, ma certo pure dal mondo stesso dove la merce governa più che esservi governata”. Labirinto che si accende nell’oscurità diramandosi in vicoli bui, sordidi, disfatti, via delle Finanze, via Coppola, via Maddem, via Di Prima, via Rapisarda, via di Sangiuliano, pullulanti di protettori, ruffiani, deboli, perdenti, deturpati da immedicabili ferite, ammorbati dalla miseria, dal fetore, dal disordine. “Prima forma di baratto” la prostituzione, secondo l’annotazione di Carl Marx, posta in epigrafe al romanzo. E Walter Benjamin: “L’ambiente oggettivo degli uomini assume sempre più scopertamente la fisionomia della merce”. Fedele all’istanza lukacsiana dell’arte come “rispecchiamento”, Addamo denuncia, con l’incedere serpeggiante della corruzione, la mercificazione, l’alienazione, le distorsioni della logica capitalistica che, come avverte Alain Robbe-Grillet, conducono alla progressiva reificazione ed eclisse della persona di fronte al predominio acquisito, per contro, dalle cose. E così se le “puttane” divengono “oggetti, merce, e mezzi di merce”, gli aranceti, immagine della conquista della verghiana “roba” da parte dei contadini proletari, ma pure “ruolo”, “status”, “filosofia e visione della vita”, perdono l’attributo di prodotti trasfigurandosi in “esseri vivi e volitivi”, in venerati “feticci”, l’odore del loro succo in odore di “sangue, odore di fatiche e di miseria”.
All’universo derelitto, emarginato delle prostitute l’autore guarda con scettico disincanto e implicazione empatica, sempre tuttavia con tormentato sentimento della tragicità della vita e della morte. Quello stesso sotteso alla descrizione, permeata di plastica sensibilità pittorica, della Visita di Henri de Toulouse-Lautrec nel racconto Lo zio Isidoro, confluito nella silloge Palinsesti borghesi: “Le solite puttane che il mostriciattolo sapeva raccogliere. Le puttane stavano con la veste rialzata in attesa della visita periodica: i volti guardai, ma soprattutto le pance delle due donne, dove niente dava adito alla pietà […] e nemmeno all’orrore, ma c’era la giovinezza e la vecchiaia, la ferocia di quel volto di ragazza che non guardava verso nessuna parte sicura soltanto di sé, la sua pancia tesa e tonda come un cocomero che a passarci l’unghia si spacca; e la fine di tutto segnata sull’altro volto, la fine di tutto segnata da quella pancia che sbandava da tutti i lati, la stanchezza d’una memoria che non ha più orizzonti”. Una bruciante pietas, una teologia negativa, in cui l’autore si carica del dramma dell’uomo orfano di Dio, promana dalla pagina di Addamo: “una pietà anche eccessiva vale sempre più della crudeltà assoluta”. Scrive Fedor Dostoevskij: “Uomo, uomo, non si può vivere del tutto senza pietà”. E Georges Rouault, a proposito della potente bellezza che trasuda dalla feroce crudezza del polittico dell’Altare di Isenheim: “Per rifare il terribile crocifisso di Matthias Grünewald, che con le sue mani contratte, i piedi torti, rattrappiti, fa piegare la croce, per rinnovare il dramma in una parola, bisognerebbe avere ancora in cuore una fede simile alla sua”.
Persuaso con Leonardo Sciascia che la letteratura è “luogo di svelamento della realtà anche morale”, in linea con il principio dell’“ethos della scrittura”, cifra di tutta l’opera sua, Sebastiano Addamo, dinnanzi alla decadenza della carne e all’abbrutimento morale, si fa veemente difensore del valore supremo della dignità: “Soltanto avanti negli anni avrei imparato che anche una puttana fa parte della razza umana, ed è questa a secernere se stessa e il proprio contrario, secerne bile e amore e sventura; il terrore e i sogni; la spada e l’ostensorio; il male e il bene; secerne anche dignità, e perciò essa – la dignità – si può trovare dappertutto, innocente sempre e sempre colpevole in ogni luogo”. Con tassativa asciuttezza, ne La metafora dietro a noi: “È il vuoto. L’assenza dell’assenza” la condizione del suo esistere. Anche Pierre-Joseph Proudhon addita nella prostituzione “il sacrificio della dignità umana all’egoismo, alla cupidigia, all’orgoglio, al piacere, a tutte le seduzioni inferiori”. Oggetto di divagazioni oniriche, di “voglie oscure e trepidanti”, di malsana sessualità, le prostitute assurgono ad emblema del “tragico dilemma esistenziale” del catanese: il sesso “dispotico e aspro”, freudiano principio del piacere in cui sembra consistere l’essenza della vita, perseguito con accanimento, voracità, avidità e al contempo velato di malinconie repentine, ansie funeste, “sensi di colpa”, “ancestrale memoria di madri e alvei”, come pure di deterrenti icone di santi. Con la secca perentorietà di quello stile aforistico prediletto da Addamo, Nietzsche annota: “Il cristianesimo, col suo disprezzo del mondo, ha fatto dell’ignoranza una virtù, l’innocenza cristiana, forse perché il più frequente risultato di questa innocenza è […] il senso della colpa”. “Il sesso e l’utilizzo dei suoi strumenti non sono che il compenso del vuoto dell’inedia, della solitudine”, chiosa lo scrittore. Desiderio di morte dietro cui si cela il perenne bisogno di un appagamento che la realtà non può offrire. Irrisione di falsi pudori, stanco filisteismo, l’insano, dissacratore amplesso del giovane Gino con la laida figura materna della padrona infrange archetipi e tabù nel furore iconoclasta che investe istituti familiari e religiosi.
L’atmosfera del romanzo alterna all’iniziale vago senso d’allegrezza, esplicitato attraverso la descrizione dei luoghi “asettici” di via Etnea, con le scintillanti cupole dei Minoriti, della Collegiata, del Duomo, da cui promana il “rumore pulsante della vita”, viale XX Settembre, avvolto da un “silenzio pulito ed elegante”, da una “calma lunga e sicura che si diradava all’intorno come zagara”, il presagio minaccioso, lugubre, ferale della “fine”. Sono, ancora una volta, empiristiche sensazioni, primordiali rielaborazioni dell’esperienza sensibile, di cui l’autore si serve per liberare la ragione da ogni passiva acquiescenza alla tradizione e ad ogni autorità, a veicolare i segni della diffusione, sempre più invasiva, nella vita quotidiana di quella letale “malattia che era la guerra”. Catania come Orano de La Peste di Camus è infettata da un morbo funesto di cui è sintomatico l’afrore del capillare luridume che assedia la città: “Tutto divenne guerra. […] Sopravvenne l’odore di piscio. Inopinatamente, senza alcun preavviso, dilagò, s’impose, si impossessò della città. […] La guerra dilagò con tale odore”. Con Aristotele: “Nihil in intellectu quod prius non fuit in sensu”. E in rapida escalation “dopo l’urina venne la merda”. Ma “l’analità” costituisce a un tempo simbolo e rifiuto della guerra: “lasciti immondi e impuri […] densi quasi di una ideologia […], incaricati – nella loro degradante inerzia di degradazione – d’una speranza che a nessuno era chiara”.
La guerra non è quella di lunghe, inespugnabili trincee, di mirabolanti avanzate, di manovre vittoriose propagandate dai mendaci bollettini del regime. È quella dei marciapiedi imbrattati di un “vasto putrescente addobbo escrementizio”, delle “carte da lutto” affisse alle porte delle vedove ridotte alla prostituzione, dei volti sformati, disperati di creature forsennate. È monito contro l’asservimento al potere, contro la falsificazione della realtà. Per Leone Tolstoj: “la storia sarebbe una gran bella cosa, se solo fosse vera”. Ha radici lontane nel tempo la guerra, è la lotta verghiana per la sopravvivenza, ricerca affannosa di cibo, pugnace desiderio di primitività. Il vero nemico da sconfiggere “la vecchia sorella fame”.
L’amaro disincanto dell’autore nei confronti della storia, “luogo dell’inesistente”, è ferma condanna dell’immobilismo, del trasformismo della politica siciliana. Il ritardo e la diversità s’intitola significativamente la lettera che Sebastiano Addamo indirizza a Pier Paolo Pasolini, dalle pagine della rivista “Nuovi Argomenti” (poi ne I chierici traditi), sottolineando tuttavia in tale binomio una rivendicazione di alterità, il segno peculiare del vivere in Sicilia. La “Sicilia afosa, calda, luminosa, ma dove la troppa luce – abbacina, stordisce, macera […] – diventa spesso densa e oscura nube di scirocco”, generando “una specie di alterazione ottica” secondo cui “le polemiche arrivano già quasi scontate, i clamori attutiti, quasi spenti, chiusi in una soffice nebbia, rarefatti, remoti e quasi incredibili”, dove perciò “il ritardo non sempre implica negatività, ma quasi sempre implica ‘diversità’”. L’isola, dove “l’unica cosa che veramente si muove è la terra quando distrugge il Belice o sono gli emigranti”, ribadisce con forza lo scrittore nel romanzo, “sta ancora attendendo la ‘sua’ storia”.
Con lento ma affilato bisturi, Addamo scava solitudini, piaghe, attossicamenti, intramando all’asprezza del giudizio morale i toni di una smorzata ironia. Alla scrittura il compito di ‘sublimare’ il bottino di sofferenze lasciato dalla guerra. Ma la scrittura, avverte, “può valere non tanto ad accreditare fede nella parola, bensì a tener conto della sua disperata impotenza” (Vittorini e la narrativa siciliana contemporanea). Di fronte alla sofferenza e alla morte la parola si assottiglia, si radicalizza, diviene lamento. O urlo d’inesprimibile dolore. Come quello di Edvard Munch. E infine silenzio: “Il silenzio comincia a essere l’unico modo di parlare, lo spazio del soggetto si restringe, la parola come espressione di reagire e modo di solidarietà, si spezza. Le ragioni dell’individuo collimano con l’afasia” (Oltre le figure).
Moderno aruspice dello scacco storico del nostro tempo, con prosa scettica, a tratti barocca, d’indignata razionalità nelle zone parenetiche, l’autore de Il giudizio della sera, innestandosi in una illustre tradizione siciliana di realismo, se ne discosta in virtù di un’aggressiva dilatazione espressionista che forza il dato reale caricandolo di significati che sfiorano il simbolo. Una galleria di squallidi ritratti di una società in putrefazione accoglie maschere raccapriccianti, dalle sconciature fisiognomiche, dai profili slabbrati, dalle devastazioni crudeli. E sono seni che divengono “otri spenti”, o “molli globi dove le vene azzurre si frastagliavano, quasi la carne si fosse assottigliata sotto quei vermi lunghi che la ingoiavano”, corpi trasfigurati in sacchi pieni di “ossa ammassate e lacerate” o in “carne malata”.
Di forte valenza evocativa la scala cromatica della tavolozza di Addamo. Come la pittura di Renato Guttuso in cui taluni giardini del pittore di Bagheria, intrisi di “serena mestizia”, “celano e svelano nel loro tripudio la vecchia siciliana malinconia della morte e del disfacimento”. L’armonia coloristica di stampo mediterraneo, con le “accese policromie del carretto”, con il “rosso e il giallo dell’arancia, il verde lucente delle sue foglie, oltre al turchino del cielo e del mare”, si spegne nella fredda monocromia dei toni del grigio che appannano la vista come il grigio del fumo derivante dalla deflagrazione delle bombe. Un fumo grigio era, non a caso, l’originario titolo del romanzo.
È la Sicilia a nutrire l’immaginario di Sebastiano Addamo. La sua Catania non è tuttavia quella “città sdraiata a terra, peggio: coricata a terra!”, la cui aria “molle e pastosa” dà l’impressione di “camminare in mezzo al miele”, di Vitaliano Brancati, né quella aperta sul mare, “luccicante sotto il sole a picco”, su cui volano “gabbiani roteanti”, “calma e accogliente” di Ercole Patti. Ma non appare, d’altra parte, la luce della Sicilia ai suoi scrittori soltanto in apparenza dispiegata solarità, costantemente insidiata com’è dalla tenebra? Essa stessa lutto? La luce e il lutto intitola Gesualdo Bufalino una raccolta di articoli che ci restituiscono le due facce contrastanti, ossimoriche dell’isola. Come i “neofiti dell’oscuro” fra bagliori di luce nelle tenebre della notte (Il giro della vite).

—————–
(post pubblicato originariamente il 22 settembre 2009)
* * *
© Letteratitudine – www.letteratitudine.it
LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo
Seguici su Facebook e su Twitter
Tags: bompiani, il giudizio della sera, laura marullo, matteo collura, Omaggio a Sebastiano Addamo, premio addamo, Sarah Zappulla Muscarà, sebastiano addamo
Scritto mercoledì, 15 luglio 2020 alle 18:40 nella categoria OMAGGI, RICORRENZE, ANNIVERSARI E CELEBRAZIONI, SEGNALAZIONI E RECENSIONI. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.









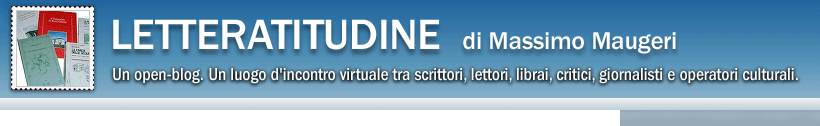














 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI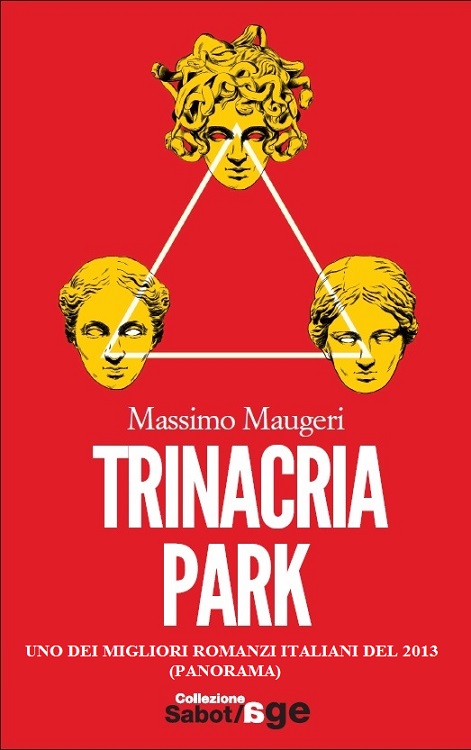
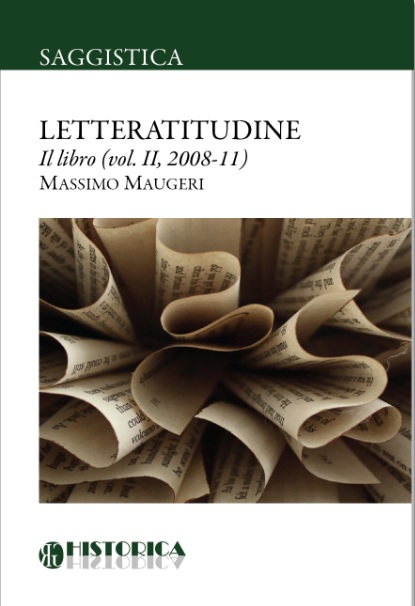


Commenti recenti