lunedì, 14 dicembre 2009
LETTERATURA DI MADRI E FIGLIE: Sandra Petrignani, Dora Albanese

Il filo conduttore di questo post è il rapporto tra madre e figlia: uno dei più importanti tra quelli contemplati nell’ambito delle relazioni umane. Un rapporto non sempre facile, ma essenziale. Che muta nel tempo, ma che – alla fine (forse) – rimane sempre uguale.
Vorrei discuterne con voi insieme a due scrittrici (appartenenti a generazioni diverse) che hanno pubblicato – di recente – due testi di narrativa che, a mio avviso, sono collegati proprio dal tema che propongo in questa discussione: Sandra Petrignani (scrittrice notissima) e Dora Albanese (esordiente, ma già nota ai frequentatori di questo blog).
Introduco subito qualche domanda con l’intento di favorire la discussione:
Rispetto agli altri tipi di rapporti umani, cos’è che caratterizza quello tra madre e figlia?
È un rapporto basato più sulla complicità o sulla conflittualità?
Quali sono i rischi? E quali le opportunità?
Quali sono le fasi della vita (sia della madre, che della figlia) più delicate? Quelle che influenzano di più il loro modo di relazionarsi?
E come è cambiato il rapporto madre/figlia, in questi anni? Che differenza c’è – oggi – rispetto a venti, trenta, cinquant’anni fa?
Infine… che differenza c’è – a vostro avviso – tra il rapporto madre/figlia e quello madre/figlio?
I due libri protagonisti di questo post, in un modo o nell’altro, affrontano questo argomento.
Il libro di Sandra Petrignani è un romanzo intitolato “Dolorose considerazioni del cuore” (edito da Nottetempo). Ecco la scheda…
Dal suo rifugio sotto le coperte, Tina racconta a Vittoria, amica amatissima, persa e ritrovata, i fatti, il disordine e i ricordi degli anni in cui una brusca rottura le ha tenute lontane. Nel tentativo di ricondurre a un unico, ricorrente malamore i tanti modi in cui ha amato, Tina recupera dai suoi cassetti brani di romanzi incompiuti e li annoda alla testimonianza di un presente insopportabile. L’assistenza a due genitori anziani, incattiviti da una relazione infelice, riporta in superficie le sofferenze infantili e permette di ricomporre gli indizi di un antico rifiuto. Si delinea così l’”autobiografia di una borderline” dalla caotica vita sentimentale, nella quale gli affetti vivono di strappi e tormentosi ritorni. Eppure il cielo resta alto sulle rovine e una ricomposizione è possibile.
Dora Albanese, invece, per i tipi di Hacca, ha pubblicato la raccolta di racconti “Non dire madre“…
Attraverso il topos della maternità, Dora Albanese racconta tre metamorfosi sociali e culturali del Sud postbellico: la dura maternità della Lucania “interna”, ancora legata a feroci e dolcissimi stili contadini; la frustrata maternità piccolo-borghese di una Matera “piana”, dimentica della superba e misera civiltà dei Sassi; e, infine, la maternità delle nuove generazioni, sospese tra “ritorni al passato”, fastidi per un benessere di facciata, e goffi e ostinati tentativi di abbracciare il mondo, magari attraverso un altro topos di questo libro, quello dell’emigrazione. In Non dire madre il tema della maternità e della femminilità è ossessivamente indagato e sviscerato con franchezza, senza abbellimenti estetici e senza indulgenze; anzi, le donne di questo libro sono sempre colte in un estremo momento di quotidianità scoperta, finanche di buffa sciatteria. A Dora Albanese interessa il trucco che si scioglie sul viso, l’odore immediato della carne e della placenta, la calata delle maschere, l’emergere impietoso delle paure, delle viltà, dei sentimenti più immediati, senza temere né la crudeltà né il sentimentalismo – dilagante attitudine, quest’ultima, di un Sud che, a furia di recitare, ha pure imparato a recitare i sentimenti.
Seguono due recensioni: la prima, firmata da Stefania Nardini, riguarda il romanzo di Sandra Petrignani; la seconda, di Gianfranco Franchi, è relativa alla raccolta di racconti di Dora Albanese.
(Spero che Stefania e Gianfranco abbiano la possibilità di partecipare al dibattito).
Siete tutti invitati a discutere dei due libri e dei temi proposti.
Massimo Maugeri
P.s. Potete ascoltare le interviste che le autrici protagoniste di questo post hanno rilasciato alla trasmissione Fahrenheit. Quella di Sandra Petrignani è qui… quella di Dora Albanese è qui.
————
Petrignani: la storia dell’età forte
di Stefania Nardini
A un’amica, un’amica mai perduta nonostante le pause che il tempo intransigente impone, una lettera vera, di quelle che vengono dal profondo del cuore. Da scrivere rannicchiandosi sotto le coperte.
Perché ci vuole uno spazio intimo. Caldo. Come quando i gatti decidono di stare da soli. Perché scrivere sotto una coperta significa mettersi a nudo. Lasciarsi andare alle emozioni, viaggiare senza soste ripercorrendo la propria vita, la propria storia.
Erano trascorsi tre anni da quando Tina si incontrò l’ultima volta con Vittoria. Una scelta? No. Piuttosto le circostanze, i cambiamenti, che spesso creano distanze che poi si rivelano apparenti. Tina per raccontarsi a Vittoria sceglie la parte di sé che meglio riesce a esprimere senza paure, filtri: la scrittura. Recupera romanzi incompiuti rimasti nel suo cassetto.
Creando un melange con il suo oggi. L’oggi di una donna matura che suo malgrado è portata ogni giorno a fare i conti con la sua vita, i suoi antichi problemi, i suoi mali. L’oggi di Tina sono i suoi genitori. Anziani, malati, sui quali il tempo implacabile ha tracciato un segno irreversibile, che si rivela in comportamenti discontinui, tra fantasmi del passato che cedono spazio all’universo fragile di chi da vecchio perde le difese.
Un romanzo, “Dolorose considerazioni del cuore” di Sandra Petrignani (ed. Nottetempo), che ha sicuramente un connotato generazionale che sboccia, pagina dopo pagina, nel racconto della protagonista, nel suo rapporto con una madre, tipica donna del dopoguerra, simile a tante altre madri dell’epoca: capace di amare e di fare male in nome di un “credo” conformista, in nome di una morale umorale, o per quell’esteriorità che si fa “veleno” da inghiottire nella vita quotidiana. Il mito del figlio maschio, la scuola dalle suore, il marito eroe da accettare comunque, l’uso di “parabole” per giustificare un semplice desiderio. E lei: la piccola Tina che cresce nel suo disagio che un giorno cercherà di superare con l’esperienza dell’analisi. Perché poi, come ci racconta bene Petrignani, la vita oltre al malessere costruito dal passato ti riserva quello della crescita, dell’esperienza, delle relazioni, dove tutto va e viene senza tregua. Si collezionano amori sbagliati che sembravano perfetti, si cede ai carnefici che ti vogliono vittima, si ama senza sapere dove si va…
Un libro da cui si evince un percorso esistenziale che giunge ad una maturità liberatoria, quando viene il momento in cui è la vita che si ricompone intorno alla propria storia. Ma è anche la fase del declino dei propri genitori, per i quali non resta che l’essenza dell’amore. Sono vecchi, dimenticano le cose, vanno accompagnati ovunque, accuditi, assistiti, e non possono far altro che abbandonarsi a una figlia che li ricorda come erano, per poi guardarli come sono.
Quando ascoltando la vecchia canzone “O main papà”, il padre si commuove e con Tina si ritrovano uniti dalle lacrime.
Sandra Petrignani che ha al suo attivo romanzi per i quali ha ricevuto importanti riconoscimenti, come “Care presenze” , “Ultima India”, La scrittrice abita qui”, giusto per citarne alcuni, con “Dolorose considerazioni del cuore” si dimostra ancora una volta una scrittrice di grande talento e di grande sensibilità, dote, quest’ultima, che esprime senza risparmiarsi mai. “Questo libro é nato dalla realtà di dovermi improvvisamente occupare di due genitori vecchi, non solo dal punto di vista accuditivo, ma anche pratico, economico – mi racconta. Uno crede di aver chiuso i conti con l’infanzia e invece una situazione del genere ti ributta addosso tutto, anche di più. Rileggi tutta la tua vita e i rapporti difficili con due persone che hanno determinato la tua vita e il tuo carattere…
Ho rovistato nei cassetti e ho davvero trovato manoscritti iniziati e lasciati lì in epoche diverse della vita. Ho riscritto ricucito inventato qualcosa (pochissimo).”
In questo testo emergono due sentimenti: il dolore e la grande gioia di vivere nell’amore, nel sentimento dell’amicizia. Sandra Petrignani ci lascia riflettere, ma ci regala anche la speranza di essere persone vere. Perché il dolore è come l’onda del mare. Va, viene. E quando c’è tempesta si infrange su quella scogliera che è la nostra esistenza. Una scogliera a tratti friabile. Là dove ha lasciato il segno tante, forse troppe, volte. Dove, appunto, c’è il cuore.
————
Non dire madre: Dora Albanese
di Gianfranco Franchi
Prepotente come l’esordio di questo romanzo, di bellezza pari all’intensità e alla violenza dei sentimenti di una madre, della madre che racconta cosa significa dare alla luce un bambino, e cosa significa avere diciannove anni, in quel momento, ricordo d’aver letto poco, negli ultimi anni. Forse niente. La maternità è un mistero assoluto, per noi uomini; è solo il principio di una metamorfosi della donna che abbiamo amato e ameremo per sempre, è solo la sensazione di un evento fenomenale, incancellabile (e: giusto. Naturale, perfetto). E da quell’esordio in avanti mi sono lasciato andare, tra le pagine, come se fossi cullato. È strano, non ho accompagnato né guidato la lettura – sono stato, come dire, trasportato. Tutto a un tratto è cambiata la voce della narratrice, e ho scoperto che avevo di fronte una raccolta di racconti di una scrittrice lucana, classe 1985, esordiente; alle spalle qualche pubblicazione web e cartacea, qui alla sua opera prima. Ho guardato meglio la copertina di Maurizio Ceccato e ho sorriso. Mi sono accorto che nessuno mi stava cullando, e ho letto. Da letterato, ho apprezzato una gran sensibilità per i dialoghi, un grande amore per le proprie origini, un enorme orgoglio per Matera, per Stigliano, per le proprie radici; infine – magnifico – per il dialetto delle madri, per l’essenza di quella società contadina, matriarcale, tenace, forte. Ho sorriso di come mi s’era rovesciato tutto. Ho pensato al mistero della maternità, a quanto grande è questo enigma anche per le stesse donne che vanno a viverlo. È tanto grande che a un tratto narrarlo diventa impossibile: si devia nell’allegoria, si pasticcia col presente, ci si confonde tra un ricordo e un altro, si cerca una fine che non c’è (la fine è sempre una fortuna, un dono: ma è qualcosa di giusto, e naturale. Proprio come la nascita), si guarda nel lago delle proprie origini per dimenticare d’essere diventate origini voi, voi stesse donne. È bellissimo, e sbagliato (ma quanto è bello sbagliare? Quanto è sano?).
**
Saluto l’esordio di una narratrice che farà scintillare la Lucania di vita nuova, nelle patrie lettere. Sarà come pioggia su una terra arida. Sarà madre di un canto di quella terra, di quelle persone, di quella cultura, che sin qua manca. E come spesso accade, saprà farlo meglio di chi vive lì, perché adesso lei da Roma osserva tutto con più chiarezza: sta interiorizzando e giudicando la sua vita, e la sua cultura originaria, e presto ne deriveranno nuove e grandi cose. Questo libro è il primo passo. È l’elegia dolorosa e magnifica della maternità, sin quando è romanzo. Poi, è prosa letteraria, espressione ancora d’una ricerca – d’uno stadio della ricerca. D’una ricerca di qualcosa che io non posso dire, non ne ho la prepotenza, né l’incoscienza; ma è qualcosa che Dora Albanese saprà plasmare.
**
“Sarebbe bello uscire da questa camera e gettarsi nella pioggia, donare al buio il rosso delle mie ferite e il verde dei miei lividi, riempire dei miei capelli neri ogni fosso, tanto da annullare quest’annullarsi di colori, e appiattire tutto. Sarebbe bello, questa notte, ballare a piedi nudi e a braccia aperte, bagnata da gocce di pioggia, e affondare i piedi nella mia terra. Ho scelto di partorire in Lucania per dare in eredità a mio figlio le mie stesse origini. Ho sempre creduto, fantasticando, che Lucania fosse il nome di una madonna nata nei Sassi, e morta in quello strapiombo acquoso che è la Gravina”
(Dora Albanese, “Non dire madre”, p. 43).
**
Tutto ha inizio nel reparto Ostetricia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Matera. La narratrice, diciannove anni, sta per dare alla luce suo figlio; e intanto sogna di ritrovare le piccole cose quotidiane, di tuffarcisi e di non voltarsi più indietro; e il dolore la fa sentire “sgraziata” e “involgarita”. Sembra incredula lei stessa, che sempre s’era sentita libera ed emancipata, e aveva grandi sogni di libertà e d’incoscienza (ballare il flamenco a Madrid; ballare, e basta) tatuati sul polso (“duende”). È incredula, ferita e combattiva: le altre gestanti sono tutte più grandi, e hanno qualcosa di borghese (la responsabilità: la programmazione della vita, come fosse una cena) che lei proprio non sopporta. Non vuole interagire con loro, non vuole che osservino, giudichino, pensino. Non vuole che si rapportino a lei. “Che ne sanno, loro, di me? Che ne sanno del motivo per cui ho fatto un figlio a diciannove anni? Cosa ne sanno loro del perché ho scelto di sdoppiarmi proprio in questo ospedale, proprio in questa città, davanti agli occhi di tutti?” (p. 21).
La mamma deve starle vicino. Lei vuole. Già s’accorge che parla con quell’intercalare che si usa “solo da noi a Sud, un intercalare con cui presto dovrò prendere confidenza, anche se non significa niente, perché in questo momento avrei bisogno io di essere attaccata al seno” (p. 23). E poi allatta il bambino, davanti a tutti. Accetta d’essere madre. Sa che il bambino è anche frutto delle sue paure, “della mancanza di coraggio, della giovinezza e dell’inesperienza”; s’accorge d’avere paura del bisogno che il piccolo ha di lei.
Osserva sua madre. Cerca impossibili vie di fuga. Pensa. “Credo che mia madre abbia trascorso buona parte della sua vita a ingoiare tutto: i problemi famigliari, le incomprensioni con la suocera e le cognate, i problemi e la vita dei figli. La vita dei figli mia madre l’ha depositata, come un’ape regina, nella gola, e sta aspettando la carestia per ridistribuire i viveri” (p. 39). Pensa, prima di dormire, che è stato bello vedere la madre dormire al suo fianco. Adesso sarà difficile dire “madre”: essere madre annienta il sacrificio dell’altrui maternità.
Passa del tempo. Passano cinque anni. Riesce a crescere suo figlio senza l’aiuto di nessuno. Si sente una donna bella e sazia. Si sente simile alle mamme del Sud nella stanchezza e nei tormenti (“Mentre gli occhi scavano pozzanghere, noi madri teniamo sempre il pianto in bocca”, p. 50). Soffre perché suo padre non capisce; perché sembra offeso dalla sua scelta di vita, perché ripete che sua sorella più piccola può prendere il cattivo esempio. Vive a Roma, e trova pace nel paese che ha deciso sia la sua origine – il paese delle sue madri – Stigliano, terra di contadine forti e coraggiose. E condivide ricordi. Nonna che racconta di aver assistito a un parto in casa, e di aver visto ammazzare un bambino storpio; che racconta la disperazione dei poveri, e di come cercavano di abortire; di come sopravvivevano alle cose della vita. Con dignità, nonostante le eccezionali difficoltà: e con semplicità. E poi, ricorda un aborto accaduto senza che nemmeno capisse. Ricorda un’amica anoressica, a sedici anni. Ricorda come ha combattuto quel male. Ricordando il male, vince il male: lo nomina, lo domina.
Altrove. La sua storia d’amore è in crisi. Luca non ispira più senso di protezione. Lei vuole andarsene. Vuole liberarsi della fedina. Vuole andarsene portandosi via qualche libro di poesia, due vestiti, un caricabatterie. E poi perdona, si rimangia tutto, cambia idea. Lui le appartiene come la sua terra.
E da qui in avanti il romanzo scompare. Sembra di trovarsi di fronte a una raccolta di racconti vera e propria. Storie di amori più maturi, di un istruttore di scuola guida che si innamora di una suora, di una madre che parla della nostalgia di sua figlia, di povere donne meridionali emigrate a Roma in cerca di una fortuna che non c’è; di un vecchio amico che diventa donna, e per farlo finisce in coma, e se ne va; di squarci di Roma, dove “Il mio quartiere è una piazza, un piccolo paese nella metropoli. La Roma insonne e chiassosa non toccherà mai la mia piccola piazza in via La Spezia, e questa cosa mi rassicura”, in cerca d’una dimensione di paese che non c’è. Se vi pare.
Fonte: Lankelot
———–
VIDEOINTERVISTA A SANDRA PETRIGNANI
---------
BRANI ESTRATTI DAI LIBRI DI SANDRA PETRIGNANI E DORA ALBANESE
* * *
da Dolorose considerazione del cuore di Sandra Petrignani (pagg. 60-61)
“Tina, che fai?”
“Tina, vieni qui”.
“Tina, non ti sporcare”.
“Tina, non stare in mezzo alla corrente”.
“Tina, mettiti il golf”.
Ero sempre nei suoi pensieri, non ero in nessuno dei suoi pensieri. Ero nelle sue parole, questo sí. Nel suo cuore no. Il suo cuore lo avevano preso i cacciatori, chissà quando. Era rimasta viva, apparentemente. In realtà non c’era piú, io non avevo mamma. Un simulacro dalla pelle liscia, dai capelli neri, dagli occhi brillanti, dalla bocca rossa. E le perle ai lobi delle orecchie.
Io gridavo “non andare via” ogni volta che si preparava a uscire e non poteva portarmi con sé, “non lasciarmi sola”. Gridavo senza voce, “resta con me”. Ero muta. La voce compressa sotto lo sterno.
“Tina, fa’ la brava, aspettami, torno presto,” come si dice a un cucciolo, un cane che piega la testa sconsolato.
Quanto dura “presto”? Che razza di misura è? Ore di abbandono e di solitudine. E quell’altra parola, “subito”, la piú bugiarda di tutte. Lei usciva e non tornava mai piú, tutte le volte.
“Non stare in mezzo alla corrente”, questo il viatico per affrontare la giornata e la vita. Correnti e umidità.
Precipitavo nel vuoto, e lei mi metteva la maglia.
—————–
da “Non dire madre” di Dora Albanese (pagg. 18-19)
Oggi e pure domani, e per sempre credo, non sarò lo specchio di nessuno, e questo viso gonfio ricoperto da capillari rotti sarà la mia seconda faccia: di certo non mi dimenticherò mai di me, e ogni volta che mi specchierò vedrò dall’altro lato un miscuglio di carne aperta e di sudore.
Mio padre sbuca all’improvviso, inaspettatamente, davanti alla barella, e mi dice che è tutto finito e che ce l’ho fatta. Mia madre, invece, da lontano si asciuga le lacrime, e tiene fermo sulla bocca un sorriso che sa di disperazione.
Nonostante la sofferenza, il travaglio e i nove mesi di gravidanza, non mi sono mai sentita così lucida come in questo momento; nonostante abbia partorito senza alcun conforto chimico un bambino di quasi cinque chili, non mi sento affatto stanca, interiormente. È come se non fosse ancora successo niente, è come se il peggio dovesse ancora arrivare.
Adesso l’unico mio desiderio è riuscire a smettere di tremare come una rana, essere più dignitosa nell’aspetto e avere poca gente attorno.
Domando subito a mia madre, non appena mi si avvicina un poco, se ho gridato molto durante il parto; lei fa di no con la testa, e dice che non si è sentito quasi niente, e che sono stata forte e coraggiosa a non pretendere il cesareo.
In effetti è vero, credo anch’io di non aver gridato molto, anche quando l’ostetrica, mentre mi radeva i peli del pube, per sbaglio mi ha tagliato un pezzo di carne; sì, alla fine sono stata brava, ho solo sforzato la gola per sostenere il dolore come fece Cristo quando venne inchiodato al palo, ed è proprio a lui che ho pensato per tutto il tempo – però è sempre a lui che si pensa quando la sofferenza graffia nelle vene.
——————
da “Dolorose considerazione del cuore” di Sandra Petrignani (pagg. 76-77)
Eppure l’amavo. Io non sapevo niente, sapevo solo la forza del mio amore frustrato. Non sapevo la sua debolezza, la sua infelicità, la sua pazzia. La guardavo prepararsi per andare a una festa. La pelle perfetta. I capelli neri. Le perle bianche. Il lungo vestito frusciante.
Le spalle che restavano scoperte. Volevo baciarla.
Volevo sempre baciarla.
“No. Mi rovini il trucco”.
Baciami tu.
“No. Ho il rossetto”.
No no no. L’aria percorsa da elettricità. Non sapeva di essere bella. Sempre insoddisfatta. Sempre preoccupata di non essere all’altezza. Troppo elegante. Troppi vestiti da sera, troppe pellicce. A me piaceva la misura, mi piacevano le cose semplici, però l’ammiravo a bocca aperta. Era scintillante. Si trasformava come Cenerentola.
Anche la sua carrozza era finta, pronta a ritornare zucca. Lei lo sapeva e s’innervosiva. Che io le togliessi il rossetto.
———————-
da “Non dire madre” di Dora Albanese (pagg. 28 – 29)
Entra la ginecologa senza chiedere permesso, e invita a uscire gli ultimi parenti rimasti in camera. La ringrazio con gli occhi, ma la dottoressa, che è donna e medico, capisce al volo il mio rifiuto. È stata lei ad assistere al parto, è lei che ha tagliato il cordone ombelicale gonfio di ossigeno, è lei che mi ha fatto molto male quando con le dita ha rotto le acque.
Anche mia madre viene allontanata dalla stanza e, prima di uscire, prende Alessio dal mio petto, e lo rimette nella culla.
– Non mi lasciare sola, mamma, aiutami, non abbandonarmi, non so cosa fare con il bambino se piange, resta con me, mamma, voglio stringerti la mano –.
Vorrei implorarla di rimanere, anche se non ne ho più il diritto.
“Rilassati, adesso” dice la ginecologa. Poi getta uno sguardo alla cartella clinica e continua a parlarmi chiamandomi per nome, come per farmi sentire al sicuro – proprio come accadeva a scuola quando la prof di matematica, per tranquillizzarmi, mi chiamava per nome per farmi svolgere le equazioni alla lavagna.
“Adesso, Erica, devi fare un ultimo sforzo. Chiudi gli occhi. Puoi anche mordere le lenzuola, se vuoi…”
mi dice rimettendo a posto la cartellina.
– Mamma, mamma, aiutami madre, madre aiuto, o madre sempre meno madre –.
Taccio, pensando al conforto materno che non arriverà mai.
Chiudo gli occhi come mi è stato detto, e trattengo le lacrime mentre la dottoressa continua a lavorare con distacco.
È giusto che io non dica mai più madre ora che il mio volto è racchiuso in una lacrima; è giusto che io non dica mai più madre, perché secondo lei, l’ho abbandonata prematuramente, e non ho apprezzato fino in fondo tutti i suoi sacrifici, anche se in realtà non è andata proprio così. Ho fatto un figlio punto e basta. Ho fatto di me una donna completa, ho messo le mani nella sabbia, e non la testa, come pure fanno molti a diciannove anni, e le conseguenze le pagherò io da sola, mentre i miei genitori lentamente si volteranno di spalle.
Il bambino dorme e io soffro, mi arrendo a quella donna che non porta sollievo ma altro dolore.
“Dobbiamo fare la spremitura dell’utero, durerà poco, ma devi essere forte, non possiamo permettere che si formino grumi di sangue, altrimenti bisognerà fare il raschiamento” dice mettendomi il palmo della mano sulla pancia ancora gonfia.
– Mi fai male, mi fai male, voglio morire, morire… perché non ho abortito… quella maledetta paura… avrei dovuto abortire… aia! aia! aia!… Voglio morire! –
Tengo i denti stretti, e piango ad occhi chiusi, mentre sto ferma e mi lascio torturare. Per il troppo pudore non getto neanche un urlo, e mi faccio spremere la pancia come fosse un’arancia, mentre tra le mie gambe scorre un fiume rosso.
———————-
da “Dolorose considerazione del cuore” di Sandra Petrignani (pagg. 161-162)
Era seduta davanti a una tazza di latte.
“Non ha chiuso occhio stanotte,” dice Roda, “è preoccupata”.
“Preoccupata perché? Deve solo bere tanta acqua,” faccio io a voce alta in modo che lei senta. “L’azotemia si cura cosí, ha detto il medico. Se fosse una cosa grave, non si curerebbe con l’acqua”.
“Ho un tumore al cervello,” dice lei lasciando la tazza dove sta.
Cerco di ridere: “Ma che dici?”
“Ho paura”.
Le spiego con calma che non ha niente di terribile. È solo vecchiaia, vorrei aggiungere, ma non lo dico. Nessun tumore. Il cervello è un po’ lesionato, ma solo nella trasmissione dal pensiero alla parola. È una seccatura, lo ammetto. Ma sarebbe piú terribile che fosse davvero un cancro: operazioni, chemioterapia. Invece deve solo adattarsi a quella che è indubbiamente una menomazione, con cui però si può provare a convivere.
“Le parole crociate, non riesco piú a farle, nemmeno le piú semplici,” farfuglia disperata. La frase è quasi incomprensibile, ma ho imparato a ricostruire il senso dei suoi discorsi frammentati.
“Va bene, rinuncerai alla Settimana Enigmistica,” cerco tutta la dolcezza possibile per consolarla. “Farai altre cose”. Frugo nella mia mente alla ricerca di un’idea, la guardo. Ha i capelli in disordine, da un mese dice che vuole tagliarsi i capelli. Non le piacciono i parrucchieri del quartiere. E quello che era il suo parrucchiere, Roberto, è al centro della città, lontano.
Come fa ad arrivarci da sola? Penso alla riunione di lavoro che mi aspetta.
“Potresti andare da Roberto, per esempio. Se vuoi ti ci accompagno, ci sto andando anch’io”.
Ha un lampo di arresa incredulità negli occhi. Oppone resistenza per mettermi alla prova. “Devo vestirmi”.
Già pronta a rinunciare.
“Va bene, ti aspetto”.
L’aspetto nell’ingresso, leggiucchiando un giornale, dando occhiate corroboranti alla vetrata del terrazzo.
L’intrico verde delle piante è l’unico dettaglio dell’appartamento dei miei genitori che non ho mai sentito ostile.
Ricompare ancora in vestaglia e mi abbraccia. Improvvisamente mi abbraccia stretta stretta, e piange.
La sento piccola e fragile, me la ricordo piú alta di me, altera, fredda.
“Ho solo te,” dice chiaramente.
“E io ci sono e ti proteggo”.
Quell’abbraccio ha cambiato ogni cosa fra me e lei.
Mi propongo di tornare a sentire quell’abbraccio sul mio corpo ogni volta che sto per crollare.
Tags: Dolorose considerazioni del cuore, dora albanese, gianfranco franchi, hacca, Non dire madre, nottetempo, sandra petrignani, stefania nardini
Scritto lunedì, 14 dicembre 2009 alle 16:53 nella categoria EVENTI, INTERVENTI E APPROFONDIMENTI, SEGNALAZIONI E RECENSIONI. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. I commenti e i pings sono disabilitati.









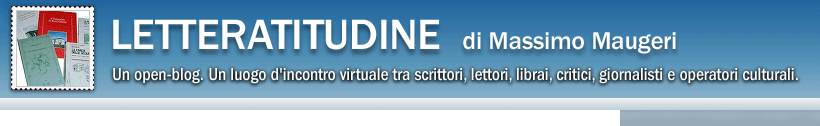














 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento) a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI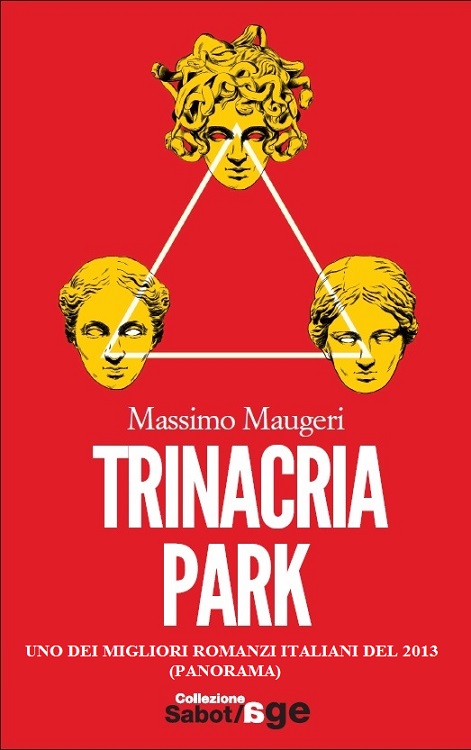
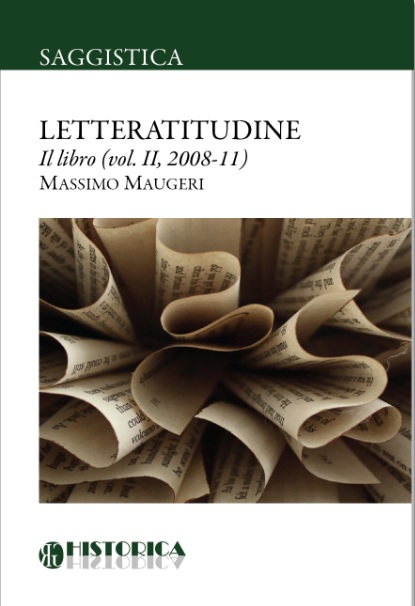


Commenti recenti